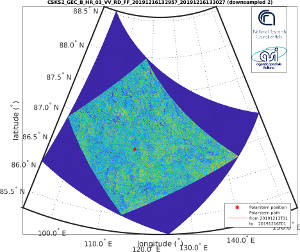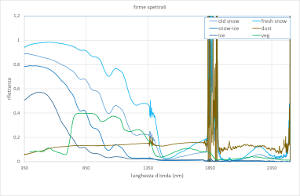Laboratorio per la determinazione analitica di microinquinanti organici normati ed emergenti (MicroChem)
Breve descrizione
Le attività sperimentali svolte presso il MicroChem Lab della sede di Roma si focalizzano sulla determinazione analitica di microinquinanti organici normati ed emergenti e dei loro metaboliti, finalizzate alla comprensione delle loro dinamiche di diffusione, distribuzione, persistenza e destino nei diversi comparti ambientali ed allo studio delle relazioni tra i cambiamenti climatici e la diffusione dei contaminanti a lungo e corto raggio. A tal fine, è necessaria la messa a punto e ottimizzazione di metodologie analitiche specifiche ed altamente sensibili che consentano la rilevazione di concentrazioni in traccia e sub-traccia degli analiti di interesse nelle diverse matrici.
Comparti ambientali di interesse
Le attività sono rivolte agli ecosistemi acquatici e terrestri, pertanto i comparti ambientali di interesse sono i seguenti: acque superficiali (marine, fluviali, lacustri), neve/ghiaccio, suoli, sedimenti, vegetazione acquatica e terrestre, biota.
Tecniche di studio
La determinazione dei microinquinanti organici di interesse viene eseguita mediante la combinazione di procedure di:
- metodi di pretrattamento (es. liofilizzazione, filtrazione, etc);
- metodologie estrattive e di purificazione (estrazione in fase solida-SPE, estrazione liquida pressurizzata-PLE, estrazione liquido-liquido-LL);
- metodologie analitiche sensibili e selettive basate sull’accoppiamento di tecniche cromatografiche (HPLC o GC) e rivelazione mediante fluorescenza, FID-ECD, spettrometria di massa.
Strumentazione
Il laboratorio è fornito della seguente strumentazione:
Liofilizzatore da banco (LABCONCO) con display touchscreen e capacità da 2,5 L, per il pretrattamento di matrici solide da sottoporre ad estrazione liquida pressurizzata.
Solid Phase Extraction (SPE): Estrattore in fase solida a 12 porte dove alloggiare cartucce contenenti fasi adsorbenti specifiche per l’estrazione degli analiti di interesse da matrici liquide con connessione ad un sistema da vuoto.
Sonicatore (Branson, mod. 2510) per l’estrazione, con gli opportuni solventi, degli analiti di interesse da determinate matrici solide.
ASE 150 (Dionex, Thermoscientific), per l’estrazione liquida pressurizzata (PLE) di contaminanti da matrici solide
Speed Extractor E-916 (Buchi), per l’estrazione liquida pressurizzata (PLE) di 6 campioni in parallelo, anche con differenti metodologie.
 Rotavapor R 100 (Buchi), munito di interfaccia elettronico per il controllo del sistema da vuoto e del refrigeratore a ricircolo.
Rotavapor R 100 (Buchi), munito di interfaccia elettronico per il controllo del sistema da vuoto e del refrigeratore a ricircolo.
Gas Cromatografo (Thermo Fisher, Trace 3000) accoppiato con rivelatore a spettrometria di massa(Thermo Fisher, ISQ7000). Il Sistema è munito di un autocampionatore per l’esecuzione di analisi in sequenza (Thermo Fisher. AI 1310). Tale Sistema è interamente gestito mediante il Chromeleon Software.
HPLC (sistema binario, Vanquish TM Core HPLC system, Thermo Scientific TM, Italia, Perkin Elmer, USA) accoppiato con rivelatore a spettrometria di massa ad altarisoluzione (Orbitrap Exploris 120, Thermo Scientific TM, Italia). Tale sistema è gestito mediante ilsoftware Xcalibur (versione 5.1).
Per informazioni: Dott.ssa Luisa Patrolecco – luisa.patrolecco AT cnr.it
Ancoraggi strumentati Sud Adriatico
Ancoraggi strumentati Sud Adriatico - ULTIMO TITOLO Ancoraggio Strumentato Permanente Adriatico (ex) MSA AGGIORAMENTO 2023
Sistema osservativo del cascading di NAdDW in Adriatico Meridionale (Mooring Southern Adriatic, MSA)
MSA
L'Adriatico meridionale è la parte più profonda del Mare Adriatico con una profondità massima di 1200 m. Nella sua parte occidentale, le acque superficiali provenienti dall'Adriatico settentrionale scorrono verso sud lungo la costa italiana, mentre le acque ioniche scorrono verso nord lungo la costa croata. Sotto lo strato superficiale, l’acqua intermedia levantina modificata (MLIW), proveniente dal Mediterraneo orientale, entra nel mare Adriatico sul lato orientale dello Stretto di Otranto, ad una profondità compresa tra 200-600 m.
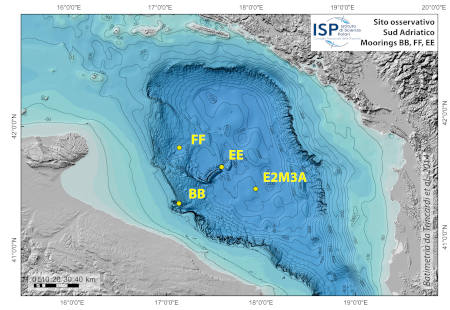 L'Adriatico meridionale è un sito di formazione di acqua densa, l'Adriatic Deep Water (AdDW). Questa viene generata attraverso una convezione verticale profonda di oceano aperto, causata dalla perdita di calore superficiale a seguito di eventi di vento freddo che si verificano nel tardo inverno. Occasionalmente, contribuiscono all'AdDW anche le acque dense che si formano in piattaforma nel Nord Adriatico (NAdDW), durante l'inverno prodotte anche in questo caso dalla perdita di calore superficiale e dall'evaporazione causate dalle tempeste di Bora. La NAdDW costituisce l'acqua più densa di tutto il Mediterraneo orientale, scorre principalmente lungo la piattaforma occidentale del Mar Adriatico centrale come corrente di fondo seguendo il gradiente topografico e arriva al promontorio del Gargano dopo 2-4 mesi da quando è stata prodotta. Recentemente sono stati osservati tempi di arrivo più brevi (3-4 settimane). Una volta arrivata al ciglio della piattaforma continentale sprofonda verso il centro dell’Adriatico Meridionale lungo la scarpata di fronte al Gargano o attraverso il canyon di Bari, trasportando ossigeno disciolto, nutrienti, particellato, ed inquinanti agli ecosistemi bentonici profondi.
L'Adriatico meridionale è un sito di formazione di acqua densa, l'Adriatic Deep Water (AdDW). Questa viene generata attraverso una convezione verticale profonda di oceano aperto, causata dalla perdita di calore superficiale a seguito di eventi di vento freddo che si verificano nel tardo inverno. Occasionalmente, contribuiscono all'AdDW anche le acque dense che si formano in piattaforma nel Nord Adriatico (NAdDW), durante l'inverno prodotte anche in questo caso dalla perdita di calore superficiale e dall'evaporazione causate dalle tempeste di Bora. La NAdDW costituisce l'acqua più densa di tutto il Mediterraneo orientale, scorre principalmente lungo la piattaforma occidentale del Mar Adriatico centrale come corrente di fondo seguendo il gradiente topografico e arriva al promontorio del Gargano dopo 2-4 mesi da quando è stata prodotta. Recentemente sono stati osservati tempi di arrivo più brevi (3-4 settimane). Una volta arrivata al ciglio della piattaforma continentale sprofonda verso il centro dell’Adriatico Meridionale lungo la scarpata di fronte al Gargano o attraverso il canyon di Bari, trasportando ossigeno disciolto, nutrienti, particellato, ed inquinanti agli ecosistemi bentonici profondi.
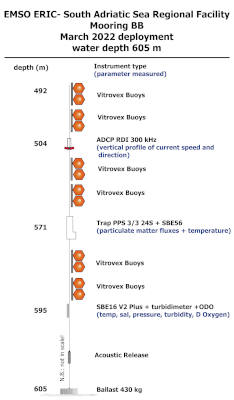 Per monitorare l’arrivo stagionale dell’acqua densa proveniente dall’Adriatico settentrionale, e la sua variabilità interannuale e su lungo periodo per effetto dei cambiamenti climatici, è stato posizionato un sistema osservativo basato su tre catene correntometriche: i moorings BB, EE e FF. Questo sistema è stato attivato e finanziato a partire dal 2004 da diversi progetti scientifici (EU-EuroSTRATAFORM, EU-HERMIONE, PRIN-OBAMA, EU-Perseus, EU-CoCoNet, Progetto bandiera Ritmare (SP5-WP5-AZ3) e Strategia per l’ambiente marino (D. L. 190/2010). Inoltre questi ancoraggi oceanografici fanno parte della rete osservativa italiana di punti fissi (IFON) e, sono supportati dall’Ufficio Programmazione e Grant Office del CNR.
Per monitorare l’arrivo stagionale dell’acqua densa proveniente dall’Adriatico settentrionale, e la sua variabilità interannuale e su lungo periodo per effetto dei cambiamenti climatici, è stato posizionato un sistema osservativo basato su tre catene correntometriche: i moorings BB, EE e FF. Questo sistema è stato attivato e finanziato a partire dal 2004 da diversi progetti scientifici (EU-EuroSTRATAFORM, EU-HERMIONE, PRIN-OBAMA, EU-Perseus, EU-CoCoNet, Progetto bandiera Ritmare (SP5-WP5-AZ3) e Strategia per l’ambiente marino (D. L. 190/2010). Inoltre questi ancoraggi oceanografici fanno parte della rete osservativa italiana di punti fissi (IFON) e, sono supportati dall’Ufficio Programmazione e Grant Office del CNR.
Dal 2021 i siti BB e FF, sono entrati a far parte del consorzio EMSO-ERIC (European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory European-Research Infrastructure Consortium) come nodo osservativo del mare Adriatico meridionale composto dagli ancoraggi BB e FF e dal sito osservativo E2M3A gestito da OGS Trieste. EMSO-ERIC è un'infrastruttura europea di ricerca diffusa per l'osservazione degli oceani, che consente il monitoraggio a lungo termine e anche in tempo reale dei processi oceanici. Consiste di un sistema di Regional Facilities ubicate in siti marini strategici dei mari europei, nel Nord Est Atlantico, nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. Ogni sito è equipaggiato con sensori multidisciplinari posizionati sul fondo marino e lungo la colonna d’acqua per misurare in continuo parametri fisici e bio-geochimici che consentono la comprensione e la descrizione di ecosistemi marini, il monitoraggio del cambiamento climatico e forniscono informazioni relativi a rischi naturali. La partecipazione al consorzio EMSO-ERIC include anche la misura dei flussi verticali di materiale particellato, tramite di n. 2 trappole di sedimento, nel mooring profondo dell’osservatorio E2-M3A (gestito da OGS Trieste) ubicato al centro della fossa Sud Adriatica.
La partecipazione ad EMSO-ERIC è sostenuta anche dalle attività della Joint Research Unit Italiana del consorzio (EMSO Italia). Infine il mooring BB è parte della Rete di Misurazioni in continuo a lungo termine della temperatura e salinità delle acque profonde del Mediterraneo (Programma Hydrochanges della CIESM).
L'ubicazione dei siti è stata scelta sulla base dell'integrazione di osservazioni morfo-batimetriche che definivano le aree in cui il passaggio delle acque dense era più probabile con previsioni basate sulla modellizzazione del deflusso delle acque dense. Il mooring BB è posizionato nel ramo settentrionale del canyon di Bari, il mooring EE è posizionato in un’area in erosione prospiciente il Dauno seamount, a circa 1200m di profondità, e il mooring FF è sulla scarpata continentale antistante il promontorio del Gargano (Schema mooring BB). I sensori oceanografici sono fissati a diverse altezze nella parte più profonda della colonna d'acqua. Le infrastrutture sono ubicate in mare aperto ed è possibile raggiungerle solo tramite un mezzo navale. Il porto di attracco principale più vicino è Bari. Il sito BB dista dal porto circa 20 mn, il sito FF circa 40 mn, il sito EE dista 45 mn ed il sito E2M3A circa 60 nm.
Gli strumenti impiegati sono dotati di memoria ed alimentazione interna. I dati oceanografici sono scaricati in modalità delayed durante la manutenzione degli ancoraggi che avviene con cadenza semestrale o annuale. Durante la manutenzione gli ancoraggi vengono recuperati per eseguire lo scarico dei dati, la raccolta dei campioni delle trappole, la sostituzione delle batterie e la verifica della funzionalità prima della rimessa a mare. Queste manutenzioni sono state eseguite utilizzando diverse navi da ricerca del CNR (R/V Urania, R/V Minerva Uno e N/O G. Dallaporta) o navi di opportunità nell’ambito delle attività sperimentali dei progetti sopracitati.
Personale coinvolto: Stefano Miserocchi (stefano.miserocchi AT cnr.it), Leonardo Langone e Patrizia Giordano.
Corsolini Simonetta
 Ricercatore confermato presso il Dipartimento Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente dell’Università di Siena dal 1 novembre 2001. Attualmente è docente dei corsi: Ecotossicologia delle Aree Remote (Laurea Magistrale); Ecologia Marina (Laurea Triennale). E' responsabile del Curriculum Biology, Ecology, Biodiversity del Dottorato di Interesse Nazionale in Scienze POlari (sede Università ca' Foscari di Venezia); è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze e Tecnologie Ambientali, Geologiche e Polari. Collabora con colleghi di università/enti di ricerca italiani e stranieri. Dal 1994 fa parte del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) e ha partecipato a sette Spedizioni Antartide. Fa parte del programma internazionale TUNU-Programme: Euro-Arctic Marine Fishes—Diversity and Adaptation, coordinato dalla UiT The Arctic University of Norway a Tromsø, partecipando a sei spedizioni in Artide.
Ricercatore confermato presso il Dipartimento Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente dell’Università di Siena dal 1 novembre 2001. Attualmente è docente dei corsi: Ecotossicologia delle Aree Remote (Laurea Magistrale); Ecologia Marina (Laurea Triennale). E' responsabile del Curriculum Biology, Ecology, Biodiversity del Dottorato di Interesse Nazionale in Scienze POlari (sede Università ca' Foscari di Venezia); è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze e Tecnologie Ambientali, Geologiche e Polari. Collabora con colleghi di università/enti di ricerca italiani e stranieri. Dal 1994 fa parte del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) e ha partecipato a sette Spedizioni Antartide. Fa parte del programma internazionale TUNU-Programme: Euro-Arctic Marine Fishes—Diversity and Adaptation, coordinato dalla UiT The Arctic University of Norway a Tromsø, partecipando a sei spedizioni in Artide.
E' Presidente del Action Group "Input Pathways of Persistent Organic Pollutants to Antartide, ImPACT" del Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR). Dal 2019 è membro del Expert Group on POPs del Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP).
E' responsabile del Laboratorio di Ecotossicologia e Aree Remote (ERRe LAB) del Dipartimento di afferenza. I principali interessi di ricerca includono l’ecotossicologia dei contaminanti organici persistenti (POPs) nelle Regioni Polari e l’ecologia marina, in particolare: flussi di POP tra comparti abiotici e biotici e tra i livelli tessuto-comunità; bioaccumulo in predatori e reti trofiche; valutazione del rischio (TEQ); studio di POP e contaminanti emergenti; POP in alimenti e rischio per l'uomo (TWI, EDI); ecologia di uccelli marini (1994-2005).
Pescatore Tanita
 Ha conseguito una laurea in Ecobiologia (LM) presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e sta frequentando il Dottorato in Ecologia e gestione sostenibile delle risorse ambientali presso l’Università degli Studi della Tuscia (Viterbo).
Ha conseguito una laurea in Ecobiologia (LM) presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e sta frequentando il Dottorato in Ecologia e gestione sostenibile delle risorse ambientali presso l’Università degli Studi della Tuscia (Viterbo).
Le sue attività di ricerca sono focalizzate sulla dinamica e il destino di alcuni contaminanti organici (tensioattivi anionici e pesticidi) presenti nel suolo, in differenti scenari di esposizione e gli effetti che queste sostanze possono avere sulla comunità microbica naturale e sul comportamento di organismi terrestri (es. il lombrico E. foetida).
Ha inoltre acquisito esperienza nello studio della presenza e del destino di microinquinanti organici persistenti (es. IPA, PCB, NP) in diversi compartimenti ambientali e la loro possibile interazione con il biota, anche attraverso lo sviluppo e la validazione di metodologie analitiche selettive (es. GC-MS).
ClimRisk2020: Time for Action! - 21-23 October 2020
 Conferenza annuale 2020
Conferenza annuale 2020
Il convegno, organizzato on-line, avrà una sessione specifica dedicata a:
Glaciers, ice sheets, sea–ice: climate of the past and future tipping points
SESS report 2020
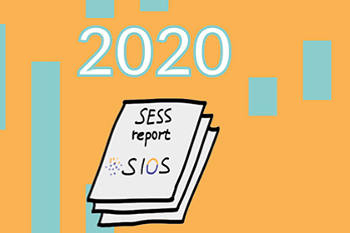 The call for contributions to the 2nd SESS report is open
The call for contributions to the 2nd SESS report is open
Deadline: 15 April 2020
SESS Report 2020 Web page
Training course on terrestrial remote sensing in Svalbard: now open also for non-members
 This autumn, SIOS will offer a training course on how to effectively use remote sensing data acquired from satellites, from the air or from the ground, and their associated tools and software in the context of terrestrial research in Svalbard. The course is intended for field scientists, Ph.D. students and technicians with no or little experience with remote sensing techniques. The training will be delivered by remote sensing experts from SIOS member institutions, international teachers and potential virtual talks from ESA experts.
This autumn, SIOS will offer a training course on how to effectively use remote sensing data acquired from satellites, from the air or from the ground, and their associated tools and software in the context of terrestrial research in Svalbard. The course is intended for field scientists, Ph.D. students and technicians with no or little experience with remote sensing techniques. The training will be delivered by remote sensing experts from SIOS member institutions, international teachers and potential virtual talks from ESA experts.
Application deadline: 7 June 2020
SIOS Web page
Laboratorio di Geochimica Organica
 Breve descrizione
Breve descrizione
Nel laboratorio di Geochimica Organica dell'ISP di Bologna ricercatori e studenti si occupano di processi moderni e ricostruzioni paleo accoppiando l’informazione fornita dai biomarcatori fossili e dagli isotopi stabili del carbonio/azoto. I biomarcatori e gli isotopi stabili, collettivamente chiamati proxy, sono infatti strumenti di indagine per la comprensione dei feedback tra clima e cicli biogeochimici. Il laboratorio è dotato di diversi sistemi per estrarre, purificare e analizzare una serie di biomarcatori tra cui composti terrestri (e.g. fenoli della lignina, lipidi a catena alifatica, prodotti derivati dalla cutina) per comprendere lo scambio terra-oceano di carbonio (e.g. fusione del permafrost, piene fluviali, etc), alchenoni per indagini paleo sulla temperatura superficiale dell’oceano e isoprenoidi altamente ramificati per ricostruzioni paleo di ghiaccio marino. Inoltre, il laboratorio è dotato di un Preparative Fraction Collector (Agilent-Gerstel) per l'isolamento dei singoli composti. Questa tecnica, dedicata alle analisi al radiocarbonio dei biomarcatori, trova diversi impieghi come sviluppo di modelli di età per gli archivi climatici sedimentari e lo studio dei processi legati alla fusione del permafrost.
Strumentazione
Il laboratorio di Geochimica Organica è dotato di diversi sistemi gascromatografici per la quantificazione degli isotopi stabili del carbonio e azoto, per l’analisi elementale della sostanza organica (CHNS) e la quantificazione/isolamento di biomarcatori organici. La strumentazione disponibile include:
- Thermo Fisher Scientific FLASH 2000 Element Analyzer accoppiato ad uno spettrometro di massa DeltaQ (EA-IRMS)
- GC Agilent GC 7820-MSD EI 5977B
- GC Agilent 8860-FID G2790A
- GC Agilent 8890 integrato con un sistema di purificazione Gerstel PFC (Preparative Fraction Collector).
Per informazioni: Dott. Tommaso Tesi - tommaso.tesi AT cnr.it
Ph.D in Science and Management of Climate Change
 The PhD programme in Science and Management of Climate Change is a joint initiative between Ca’ Foscari University of Venice and the Euro-Mediterranean Center on Climate Change (CMCC)
The PhD programme in Science and Management of Climate Change is a joint initiative between Ca’ Foscari University of Venice and the Euro-Mediterranean Center on Climate Change (CMCC)
The programme is taught entirely in English. Duration: 4 years
Details
Dottorato in Scienze e tecnologie ambientali, geologiche e polari
 Il Dottorato ha sede presso le strutture del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Siena. Il Dottorato in Scienze e tecnologie ambientali, geologiche e polari ha una forte connotazione inter- e multidisciplinare (settori scientifico disciplinari delle aree CUN 03, 04, 05 e 07) e si propone di fornire una formazione post-laurea di alto livello nelle ricerche, sia di base che applicate, rivolte allo studio del funzionamento e delle interazioni tra i diversi comparti della Terra, le quali trovano una sintesi nella cosiddetta Earth System Science.
Il Dottorato ha sede presso le strutture del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Siena. Il Dottorato in Scienze e tecnologie ambientali, geologiche e polari ha una forte connotazione inter- e multidisciplinare (settori scientifico disciplinari delle aree CUN 03, 04, 05 e 07) e si propone di fornire una formazione post-laurea di alto livello nelle ricerche, sia di base che applicate, rivolte allo studio del funzionamento e delle interazioni tra i diversi comparti della Terra, le quali trovano una sintesi nella cosiddetta Earth System Science.
Pagina dettagli - Dottorato in Scienze e tecnologie ambientali, geologiche e polari
MASTER Universitario in Sviluppo Sostenibile, Geopolitica delle Risorse e Studi Artici
 La Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) e Unitelma Sapienza, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed il CNR, organizzano il Master in Sviluppo Sostenibile, Geopolitica delle risorse e Studi Artici. L'obiettivo del Master è di sviluppare capacità e competenze nei settori della green economy, della geopolitica dell'energia e delle risorse con particolare attenzione all'eco-sostenibilità e all'utilizzo responsabile del territorio. Un focus approfondito sarà dedicato all'importanza geostrategica ed economica delle Regioni artiche.
La Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) e Unitelma Sapienza, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed il CNR, organizzano il Master in Sviluppo Sostenibile, Geopolitica delle risorse e Studi Artici. L'obiettivo del Master è di sviluppare capacità e competenze nei settori della green economy, della geopolitica dell'energia e delle risorse con particolare attenzione all'eco-sostenibilità e all'utilizzo responsabile del territorio. Un focus approfondito sarà dedicato all'importanza geostrategica ed economica delle Regioni artiche.
Collaborazioni
Nazionali
L’ ISP collabora con diversi enti di ricerca nazionali, oltre che con molteplici università, e fornisce supporto tecnico-scientifico e know-how in progetti di cooperazione con enti pubblici ed aziende private.
Molti temi di ricerca sono sviluppati in collaborazione con altri istituti del dipartimento DSSTTA, come ad esempio i tre istituti dedicati allo studio del mare (ISMAR, IAS, IRBIM) e quelli dedicati allo studio dell’atmosfera (ISAC, IIA). Questo permette di estendere le competenze interne in modo complementare e multidisciplinare.
Le attività di ricerca geologica e idrologica vengono sviluppate in sinergia con IGG e IGAG, anch’essi attivi nella ricerca polare artica e antartica.
Le attività di ricerca sugli ecosistemi terrestri sono svolte in sinergia con IRET.
Tra le collaborazioni con altri enti nazionali figurano quelle con ENEA, INGV, OGS, INRiM, INAF, mentre per quanto riguarda le università troviamo i dipartimenti di chimica delle università di Firenze, Pisa, Perugia, Torino e Genova e il dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica di Venezia.
Collaborazioni in altri ambiti sono in atto con l’università dell’Insubria, La Sapienza, di Messina, Firenze, Napoli, il Politecnico di Milano e l’università di Milano-Bicocca.
Ocean Space Nowtilus - L'Ecosistema lagunare
 L'Ecosistema lagunare con Luigi Cavaleri, oceanografo all’ISMAR-CNR, Fabiana Corami, biologa, Istituto di Scienze Polari del CNR (CNR-ISP); e Beatrice Rosso, ricercatrice, Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell’Università Ca’ Foscari.
L'Ecosistema lagunare con Luigi Cavaleri, oceanografo all’ISMAR-CNR, Fabiana Corami, biologa, Istituto di Scienze Polari del CNR (CNR-ISP); e Beatrice Rosso, ricercatrice, Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell’Università Ca’ Foscari.
Podcast disponibile a partire da venerdì 5 giugno, ore 16.00.
Agenda della manifestazione
WEBINAR on the European Polar Research Programme - 11 June 2020
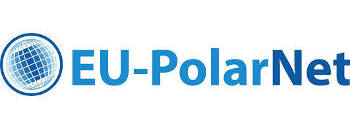 Conferences and workshops
Conferences and workshops
Webinar on the European Polar Research Programme
11th June 2020 - Time: 10:00 - 13:00 CEST
Place: online. Please register here
Amministrazione
 ANTONELLI GIUSEPPE - Segretario amministrativo
ANTONELLI GIUSEPPE - Segretario amministrativo
E-mail: giuseppe.antonelli AT cnr.it
 CESTER VALENTINA
CESTER VALENTINA
E-mail: valentina.cester AT cnr.it
 CIALLI PAMELA
CIALLI PAMELA
E-mail: pamela.cialli AT cnr.it
 COSENZA ALESSANDRO
COSENZA ALESSANDRO
E-mail: alessandro.cosenza AT cnr.it
 DI LEO GUGLIELMO
DI LEO GUGLIELMO
E-mail: guglielmo.dileo AT cnr.it
 NOGAROTTO ALESSIO
NOGAROTTO ALESSIO
E-mail: alessio.nogarotto AT cnr.it
SACCHETTO ALESSIO
E-mail: alessio.sacchetto AT cnr.it
 ZANELLA JACOPO
ZANELLA JACOPO
E-mail: jacopo.zanella AT cnr.it
 ZANOTTO EMANUELA
ZANOTTO EMANUELA
E-mail: emanuela.zanotto AT cnr.it
Laboratorio di Biodiversità acustica ed ecologia marina (BioSoundEcology Lab)
 Breve descrizione
Breve descrizione
Le attività sperimentali svolte presso il BioSoundEcology Lab della sede di Messina si concentrano sull’analisi delle sorgenti acustiche sottomarine biologiche e lo studio delle dinamiche ecologiche degli animali marini vertebrati ed invertebrati che popolano gli habitat polari. Inoltre, le attività del laboratorio hanno un focus sulla valutazione degli impatti delle sorgenti acustiche di natura antropica sull’ecologia, la fisiologia ed il comportamento degli organismi marini. In particolare, attraverso lo studio dei suoni generati dagli animali, vengono approfonditi gli aspetti relativi alla loro biologia ed ecologia. L’analisi del rumore generato da attività umane, invece, fornisce gli elementi utili a comprendere gli effetti sugli animali attraverso lo studio delle risposte comportamentali e dello status fisiologico degli stessi.
Matrici di interesse
Le attività sono rivolte principalmente agli habitat marini.
Tecniche di studio
Vengono applicati metodi di acquisizione passiva dei dati acustici sia in field che in ambiente controllato e delle risposte animali al disturbo sonoro ambientale:
- Analisi dei dati acustici;
- Stima del rumore sottomarino e delle componenti acustiche ambientali;
- Valutazione delle dinamiche ecologiche attraverso l’analisi delle vocalizzazioni degli animali marini;
- Analisi delle variazioni biochimiche, fisiologiche e comportamentali degli animali esposti a disturbo acustico;
- Studio dell’ecologia acustica dei mammiferi marini.
Strumentazione
Il laboratorio è fornito di strumentazione per il monitoraggio acustico passivo (idrofoni cablati e sistemi autonomi di acquisizione dati acustici) e per lo studio in ambiente controllato degli effetti del rumore sugli organismi marini (videocamere, amplificatore, trasduttore acustico, software per l’analisi acustica e comportamentale).
Per informazioni: Dott. Francesco Filiciotto – francesco.filiciotto AT cnr.it
Laboratorio di Chimica dell’Idrosfera (HydroChem)
 Breve descrizione
Breve descrizione
Nel laboratorio HydroChem, presso la sede di Messina, si eseguono analisi chimiche per la caratterizzazione dei corpi idrici marini (costieri e pelagici) e lacustri, fornendo supporto tecnico-scientifico allo studio dei cicli biogeochimici e dei processi ecologici anche in relazione all’acidificazione marina, così come agli studi sulle biomasse microbiche condotte nel Laboratorio di Microscopia. In particolare, vengono eseguite analisi di ossigeno, salinità, pH, nutrienti (azoto e fosforo) e carbonio organico particellato. Nell’ambito dell’attività monitoraggio ambientale, diversi prototipi di analizzatori di nutrienti sono stati sperimentati sia su piattaforma fissa che su battello, in siti pristini o soggetti a inquinamento antropico.
Matrici di interesse
Le matrici analizzate sono in massima parte riconducibili all’idrosfera (acque marine e lacustri, brine).
Strumentazione
Il laboratorio è fornito di strumentazione di base per la chimica ambientale [spettrofotometro, spettrofluorimetro, luminometro, buretta digitale per titolazione ossigeno, centrifuga, salinometro, analizzatori automatici per nutrienti (ammoniaca, nitriti, nitrati e ortofosfati), cappe ad estrazione, pompe da vuoto, setti filtrazione, agitatore magnetico, pHmetro].
Per informazioni: Dott. Filippo Azzaro – filippo.azzaro AT cnr.it
Laboratorio di Ecologia e Biotecnologie Microbiche (EcoBiM)
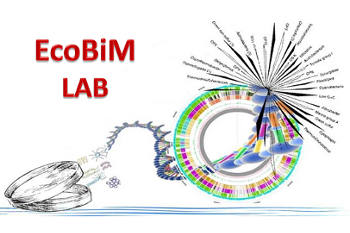 Breve descrizione
Breve descrizione
Le attività sperimentali svolte nel laboratorio EcoBiM, presso la sede di Messina, riguardano lo studio ecologico e biotecnologico dei microrganismi, in particolare procarioti, che popolano gli habitat polari marini e terrestri. Vengono approfonditi aspetti ecologici quali la diversità dei microrganismi, la loro risposta a condizioni di stress ambientale (derivanti da forzanti naturali o antropiche, quali cambiamento climatico e contaminazione chimica), le implicazioni astrobiologiche della vita in ambienti estremi, l’evoluzione e l’adattamento in ambienti polari. Il laboratorio svolge, inoltre, analisi rivolte alla valutazione delle capacità metaboliche e potenzialità biotecnologiche di microrganismi cold-adapted, ricercando biomolecole con applicazioni industriali e batteri in grado di rimuovere sostanze inquinanti a bassa temperatura in una visione di biorisanamento.
Matrici di interesse
Le matrici analizzate sono in massima parte riconducibili all’idrosfera (acque marine, fluviali e lacustri, brine) ed alla criosfera (permafrost, neve, ghiaccio marino e continentale, brine intrapermafrost), ma sono oggetto di studio anche i suoli ed i sedimenti. Particolare interesse riveste, inoltre, lo studio delle interazioni tra microorganismi e superfici biotiche (ad esempio, organismi pelagici e bentonici) ed abiotiche (come comunità microbiche colonizzanti materiali polimerici, indicate con il termine di plastisfera).
Tecniche di studio
Per la caratterizzazione microbiologica di ambienti estremi, analogamente alle procedure analitiche comunemente applicate per lo studio di aree temperate, si fa ricorso a metodi dipendenti (colturali) ed indipendenti (biomolecolari e biochimici) dalla coltivazione, tra cui:
- isolamento e mantenimento in coltura pura di ceppi batterici;
- tipizzazione fenotipica (caratteristiche fisiologiche, biochimiche e morfologiche) e genotipica (analisi delle sequenze di 16S rRNA e ricerca di geni funzionali) di batteri coltivabili;
- screening colturali per la ricerca di biomolecole utili (tra cui antibiotici, esopolisaccaridi, biosurfattanti);
- valutazione delle capacità metaboliche della comunità microbica attraverso saggi miniaturizzati;
- ibridazione in situ con sonde oligonucleotidiche (CARD-FISH) per caratterizzazione di comunità microbiche;
- estrazione di DNA e RNA ambientale per studi di metagenomica e metatrascrittomica;
- allestimento di microcosmi arricchiti con contaminanti organici ed inorganici e test di degradazione.
Strumentazione
Il laboratorio è fornito di strumentazione di base per la microbiologia ambientale ed applicata (cappa a flusso laminare, autoclave, incubatori e bagni termostatati, centrifughe, apparati di filtrazione, sonicatori, spettrofotometri, fluorimetri) e di attrezzature per la biologia molecolare (termociclatore e apparecchi per elettroforesi).
Per informazioni: Dott.ssa Angelina Lo Giudice - angelina.logiudice AT cnr.it
Laboratorio di Microscopia Ambientale (MAMB)
 Breve descrizione
Breve descrizione
Le attività sperimentali svolte presso il laboratorio MAMB della sede di Messina sono rivolte allo studio ecologico dei microorganismi applicando metodi specifici per la determinazione della abbondanza e biomassa dei procarioti (Batteri e Archea) e del fitoplancton, nonché per la descrizione morfometrica e morfologica a livello cellulare. La valutazione di tali caratteristiche fenotipiche fornisce un differente approccio all’analisi della struttura dell’ecosistema e permette di valutare l’eterogeneità delle popolazioni naturali. Variazioni di taglia, forma e morfologia cellulare sono considerati indicatori sensibili dei cambiamenti trofici e climatici negli ecosistemi. Il laboratorio svolge inoltre analisi per la quantificazione delle cellule vitali (Live/Dead) e respiranti (CTC+) utilizzando specifici biomarker microbici. Le attività del laboratorio vengono svolte anche a supporto dei Laboratori EcoBiM e BiogeM.
Matrici di interesse
Le matrici analizzate sono in massima parte riconducibili all’idrosfera (acque marine, fluviali e lacustri, brine), a suolo, sedimenti, al biofilm, alla criosfera (permafrost, neve, ghiaccio marino e continentale, brine intrapermafrost) e ad organismi acquatici.
Tecniche di studio
Tecniche microscopiche in epifluorescenza ed analisi d’immagine per la:
- determinazione della biomassa dei procarioti mediante conteggio e analisi morfometrica e morfologica delle cellule utilizzando filtri selettivi per il DAPI (4',6-diamidin-2-fenilindolo);
- determinazione delle cellule dotate di fluorescenza primaria utilizzando filtri selettivi specifici;
- quantificazione delle cellule dotate di attività respiratoria (5-Cyano-2,3-ditolyl-tetrazolium chloride- CTC), utilizzando filtri selettivi per la rodamina;
- quantificazione delle cellule vitali con membrane integre (Live/Dead) utilizzando filtri selettivi per la fluoresceina e rodamina;
- identificazione di cellule batteriche target mediante tecniche di immunofluorescenza (anticorpi fluoresceinati);
- stima dell’abbondanza relativa di gruppi filogenetici microbici mediante CARD-FISH (catalyzed reporter deposition-fluorescence in situ hybridization).
Strumentazione
- Microscopio ad epifluorescenza Zeiss AXIOPLAN 2 Imaging equipaggiato con videocamera digitale AXIOCAMHR (Zeiss) e software AXIOVISION 3.1. Caratteristiche tecniche. Lampada a vapori di mercurio ad alta pressione (100 W); obiettivo ad immersione 100XPlan-Neofluar; oculari da 10 X di cui uno dotato di reticolo quadrettato; set di filtri ottici interscambiabili e appropriati per:
DAPI: eccitazione G365, ripartitore cromatico FT395 e filtro di sbarramento LP420;
Fluorescenza primaria: BP450-490/FT510/LP515;
Rodamina: BP546/12; FT580; LP590;
Fluoresceina: BP450-490; FT510; LP520.
Per informazioni: Dott.ssa Giovanna Maimone – giovanna.maimone AT cnr.it - CNR-ISP Sede di Messina
Laboratorio di Biogeochimica Microbica (BiogeM)
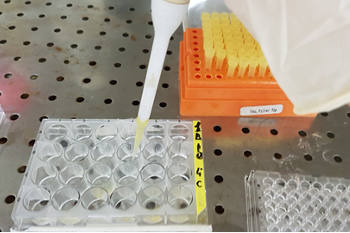 Breve descrizione
Breve descrizione
Le attività di ricerca condotte nel laboratorio BiogeM presso la sede di Messina sono finalizzate allo studio dei processi biologici marini e terrestri che modulano e influenzano le caratteristiche chimiche dell’ambiente polare e i relativi cicli di materia ed energia, anche in relazione ai cambiamenti climatici. Particolare attenzione è rivolta alla valutazione del ruolo dei microorganismi nel ciclo globale del carbonio e nei cicli biogeochimici dei nutrienti (azoto, fosforo) di ambienti marini e lacustri, attraverso lo studio dei processi sia produttivi che degradativi. Tra questi, le attività coinvolte nella decomposizione dei polimeri organici, tramite attività enzimatiche microbiche, ed i processi di mineralizzazione attraverso la respirazione microbica. I processi biogeochimici mediati dalla componente microbica sono oggetto di studio anche nell’ambito della criosfera per comprendere il significato ecologico dei microbi nel permafrost, e la loro capacità di mantenere un metabolismo attivo in condizioni di vita estreme. Insieme ai processi microbici legati alla pompa biologica ed alla decomposizione della materia organica, vengono determinati anche una serie di parametri biogeochimici indiretti connessi alla biomassa fitoplanctonica e batterica (Clorofilla, ATP, lipopolisaccaridi-LPS).
Matrici di interesse
Le matrici analizzate sono in massima parte riconducibili all’idrosfera (acque marine, fluviali e lacustri, brine), a suolo, sedimenti, al biofilm, alla criosfera (permafrost, neve, ghiaccio marino e continentale, brine intrapermafrost) e ad organismi acquatici.
Tecniche di studio
Presso il laboratorio BiogeM vengono effettuate misure per la determinazione dei seguenti parametri:
- Produzione primaria fitoplanctonica;
- Attività respiratoria microbica (O2 consumato; CO2 prodotta) (tramite saggio ETS);
- Attività enzimatiche microbiche (leucin aminopeptidasi, beta-glucosidasi e fosfatasi alcalina) (mediante substrati fluorogenici);
- Produzione batterica eterotrofica;
- Contenuto in Clorofilla-a totale e frazionata (pico-, nano- e micro-fitoplanctonica), feopigmenti;
- ATP microbico nelle frazioni pico-, nano e microplanctoniche;
- Analisi quantitativa dei lipopolisaccaridi (LPS) mediante il test cromogenico LAL.
Strumentazione
Spettrofluorimetro, Luminometro, fluorimetro, spettrofotometro corredato di lettore di fluorescenza su piastre a 96 pozzetti, incubatore, autoclave, bilancia, omogenizzatore, sistemi di filtrazione, centrifuga refrigerata.
Per informazioni: Dott.ssa Gabriella Caruso – gabriella.caruso AT cnr.it - CNR-ISP Sede di Messina
Osservazione, rimozione manuale e riconoscimento dello zooplancton catturato in colonna d’acqua mediante trappole di sedimento
 Dove: CNR-ISP Sede di Bologna
Dove: CNR-ISP Sede di Bologna
Tipologia: Tirocinio curricolare
Titolo: Osservazione, rimozione manuale e riconoscimento dello zooplancton catturato in colonna d’acqua mediante trappole di sedimento
Tutor/Docente di riferimento: Dr. Patrizia Giordano, tel. 051 6398902, e-mail: patrizia.giordano AT cnr.it
Tecniche di laboratorio per il trattamento e analisi di campioni di trappole di sedimento per la stima dei flussi verticali di materiale particellato e di sostanza organica nella colonna d’acqua
 Dove: CNR-ISP Sede di Bologna
Dove: CNR-ISP Sede di Bologna
Tipologia: Tirocinio curricolare
Titolo: Tecniche di laboratorio per il trattamento e analisi di campioni di trappole di sedimento per la stima dei flussi verticali di materiale particellato e di sostanza organica nella colonna d’acqua
Tutor/Docente di riferimento: Dr. Patrizia Giordano, tel. 051 6398902, e-mail: patrizia.giordano AT cnr.it
Long-term variability of zooplankton communities in an Artic fjord (Kongsfjorden, Svalbard) in relation of climate variability (2010-2020)
 Dove: CNR-ISP Sede di Bologna
Dove: CNR-ISP Sede di Bologna
Tipologia: Tesi di Laurea
Titolo: Long-term variability of zooplankton communities in an Artic fjord (Kongsfjorden, Svalbard) in relation of climate variability (2010-2020)
Tutor/Docente di riferimento: Dr. Patrizia Giordano, tel. 051 6398902, e-mail: patrizia.giordano AT cnr.it
Vittuari Luca
 Professore ordinario afferente al Settore Concorsuale 08/A4 – Geomatica, presso l'Università di Bologna - Dipartimento DICAM. Coordinatore del corso di Dottorato PhD@DICAM composto di quattro curricula (Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali). Responsabile scientifico del Laboratorio di Rilievo e Geomatica (LARIG). Parte dell’International GNSS Service e membro del consorzio universitario internazionale UNAVCO.
Professore ordinario afferente al Settore Concorsuale 08/A4 – Geomatica, presso l'Università di Bologna - Dipartimento DICAM. Coordinatore del corso di Dottorato PhD@DICAM composto di quattro curricula (Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali). Responsabile scientifico del Laboratorio di Rilievo e Geomatica (LARIG). Parte dell’International GNSS Service e membro del consorzio universitario internazionale UNAVCO.
Principali attività scientifiche e di ricerca nelle regioni polari:
- Ricerche in Antartide per lo studio della geodinamica e per lo studio dei movimenti dei ghiacciai, nell'ambito del Programma nazionale di ricerca in Antartide (PNRA) a partire dal 1990.
- Ad oggi ha partecipato a 10 spedizioni scientifiche in Antartide e una in Artide (Isole Svalbard) nel 2002.
- Responsabile della rete geodetica GPS per lo studio del campo di velocità della superficie del ghiaccio attorno al sito del carotaggio profondo presso Dome Concordia (European Project for Ice Core in Antarctica, EPICA).
- Membro del progetto europeo H2020 Beyond EPICA - Oldest Ice, che ha l'obiettivo di recuperare un carotaggio profondo in ghiaccio in Antartide, in grado di mostrare la storia climatica della transizione del Pleistocene medio e oltre.
- Responsabile della stazione permanente GNSS installata presso la Stazione Concordia.
- Contributo nell'installazione e nell'analisi dei dati di una stazione mareometrica presso Mario Zucchelli Station (MZS, Antartide).
Severi Mirko
 Ha conseguito il diploma di laurea in Chimica presso l’Università degli Studi di Firenze nel 2000. Durante il triennio 2001-2004 ha svolto attività il dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Firenze lavorando sulla messa a punto di tecniche semi-continue di Cromatografia Ionica accoppiate a sistemi di Flow Analysis nell’ambito del progetto europeo EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica). In data 20 Aprile 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Scienze Chimiche. Ha partecipato attivamente alle campagne nazionali di ricerche in Antartide 2001-2002 e 2003-2004 nelle basi di Dome Concordia e Baia Terra Nova effettuando analisi cromatografiche in situ su un ice core profondo perforato a Dome C nell’ambito del progetto EPICA.
Ha conseguito il diploma di laurea in Chimica presso l’Università degli Studi di Firenze nel 2000. Durante il triennio 2001-2004 ha svolto attività il dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Firenze lavorando sulla messa a punto di tecniche semi-continue di Cromatografia Ionica accoppiate a sistemi di Flow Analysis nell’ambito del progetto europeo EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica). In data 20 Aprile 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Scienze Chimiche. Ha partecipato attivamente alle campagne nazionali di ricerche in Antartide 2001-2002 e 2003-2004 nelle basi di Dome Concordia e Baia Terra Nova effettuando analisi cromatografiche in situ su un ice core profondo perforato a Dome C nell’ambito del progetto EPICA.
Dal Giugno 2002 ha partecipato a varie campagne di processamento delle carote di ghiaccio EPICA-DML e TALDICE presso l’Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research di Bremerhaven (D). Ha partecipato a numerose campagne di campionamento in Artide (presso la base Dirigibile Italia a Ny Alesund) per lo studio dei cambiamenti climatici attraverso l’aerosol atmesferico. Dal Dicembre 2004 al 31/01/2018 è stato titolare di varie borse e assegni di ricerca inerenti la messa a punto e l’applicazione di metodi analitici su carote di ghiaccio e archivi climatici. Dal 01/02/2018 al 30/11/2018 è stato Ricercatore Legge 240/10 a tempo determinato (RTDa) presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” dell’Università di Firenze SSD CHIM/01. A partire dal 01/12/2018 ha ricoperto la posizione di Ricercatore Legge 240/10 a tempo determinato (RTDb) presso il Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” dell’Università di Firenze SSD CHIM/01. Dal 1 Dicembre 2021 ricopre il ruolo di Professore Associato presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Firenze.
Parmiggiani Flavio
 Laurea in Fisica presso Università di Milano. In pensione dal 2013, attualmente opera come ricercatore associato a ISAC-CNR dove, dal 2001, è stato Dirigente di Ricerca.
Laurea in Fisica presso Università di Milano. In pensione dal 2013, attualmente opera come ricercatore associato a ISAC-CNR dove, dal 2001, è stato Dirigente di Ricerca.
L’attività di ricerca recente si è essenzialmente espletata nella partecipazione a 2 progetti europei:
- ICE-ARC
- SPICES
La tematica di ricerca per cui è stata richiesta l’associazione all’ISP-CNR è lo studio delle caratteristiche e della distribuzione del ghiaccio marino in aree polari con immagini SAR.
Gambaro Andrea
 Professore Ordinario all’ Università Ca’ Foscari di Venezia. Dal 2003 ha curato l'attività didattica nei Corsi di Laurea in Chimica, in Scienze Chimiche per la Conservazione e il Restauro (SCCR), in Scienze e Tecnologie dei Materiali e in Scienze Ambientali.
Professore Ordinario all’ Università Ca’ Foscari di Venezia. Dal 2003 ha curato l'attività didattica nei Corsi di Laurea in Chimica, in Scienze Chimiche per la Conservazione e il Restauro (SCCR), in Scienze e Tecnologie dei Materiali e in Scienze Ambientali.
L’attività di ricerca si è focalizzata prevalentemente su: 1) studi sull'origine, l'evoluzione stagionale e il destino ambientale di composti organici solforati di origine biologica (dimetilsolfuro, solfuro di carbonio e dimetilsolfoniopropionato) prodotti nel sistema acquatico; 2) messa a punto di metodologie analitiche per la determinazione di microinquinanti organici (PCB, IPA, PCN, PBDE, PCDD, PCDF, IA) in matrici ambientali (acqua, sedimento, aerosol atmosferico) mediante gascromatografia accoppiata alla spettrometria di massa sia a bassa che ad alta risoluzione; 3) messa a punto di metodologie analitiche per la determinazione di composti organici di origine naturale (amminoacidi, zuccheri, metossifenoli, tossine algali e funginee ecc..) e antropica (fragranze, inquinanti aromatici) in acqua, biota, aerosol, neve e ghiaccio mediante cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa per lo studio della contaminazione locale, globale e i cambiamenti climatici. Tale attività ha portato a collaborazioni con vari gruppi di ricerca (Griffith University, Australia; University of Charleston, U.S.A.; Boston College, U.S.A.; University of Sarajevo, Bosnia Herzegovina; University of Belgrade, Serbia; Aristotle University of Thessaloniki, Grecia; University of Rijeka, Croazia; University of Tirana, Albania ecc..).
Nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide è stato responsabile di Unità Operativa (UO) nel 2004-2006; Responsabile di Progetto nel 2010-2012; Responsabile di UO nel 2013-2014 e dal 2016.
L'attività di ricerca ha portato alla pubblicazione di oltre 140 pubblicazioni di cui 126 appaiono su SCOPUS, 10 capitoli di libri e di circa 200 comunicazioni a Convegni nazionali ed internazionali (h-index= 30).
Becagli Silvia
 Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche all'Università di Firenze nel 1991 con votazione 110/110 e Lode, ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Scienze Ambientali nel 1998 con la tesi “Studio dell'ecosistema antartico attraverso l'analisi chimica di carote di ghiaccio”. Dipendente dell’Università di Firenze dal 1999 nel ruolo di Tecnico. Nel 2013 e nel 2017 ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale per professore di II Fascia nel settore concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica) e sempre nel 2017 ha ottenuto l’abilitazione a Professore di I Fascia per lo stesso settore concorsuale.
Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche all'Università di Firenze nel 1991 con votazione 110/110 e Lode, ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Scienze Ambientali nel 1998 con la tesi “Studio dell'ecosistema antartico attraverso l'analisi chimica di carote di ghiaccio”. Dipendente dell’Università di Firenze dal 1999 nel ruolo di Tecnico. Nel 2013 e nel 2017 ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale per professore di II Fascia nel settore concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica) e sempre nel 2017 ha ottenuto l’abilitazione a Professore di I Fascia per lo stesso settore concorsuale.
Si occupa dello sviluppo di metodologie analitiche innovative ad alte prestazioni per la determinazione di ioni e metalli in matrici ambientali, principalmente aerosol, neve e ghiaccio. L’attività di ricerca è finalizzata allo studio le sorgenti e i processi di trasporto dell’aerosol atmosferico in aree a diverso grado di antropizzazione con particolare riguardo alle aeree polari (Artide, Antartide) e marine nel bacino del Mediterraneo Centrale. L’attività include lo studio dei cicli delle sostanze naturali, dei contributi antropici e dell’interazione aerosol-clima, sia per il periodo attuale, dalle misure di aerosol, che per le epoche passate dall’analisi chimica di carote di ghiaccio prelevate in Antartide.
Svolge attività editoriale per le seguenti riviste:
- Special issue jointly organized between Biogeosciences and Atmospheric Chemistry and Physics, Atmospheric deposition in the low-nutrient-low-chlorophyll (LNLC) ocean: effects on marine life today and in the future.
- International Journal Environmental Research and Public Health – Section “Environmental Chemistry and Technology” (IF 2018 = 2.468).
È autrice/co-autrice di più di 110 pubblicazioni indicizzate su ISI Web of Science e Scopus ed ha attualmente un H-index di 30.
Battistel Dario
 Professore Associato all'Università Ca' Foscari di Venezia (Italia) dal 2019. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Chimica a Ca' Foscari (2011). I suoi interessi di ricerca sono stati inizialmente focalizzati sullo sviluppo di metodi elettroanalitici per il rilevamento e l'imaging (SECM).
Professore Associato all'Università Ca' Foscari di Venezia (Italia) dal 2019. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Chimica a Ca' Foscari (2011). I suoi interessi di ricerca sono stati inizialmente focalizzati sullo sviluppo di metodi elettroanalitici per il rilevamento e l'imaging (SECM).
Dal 2013, l'attività di ricerca si è focalizzata sullo sviluppo di metodi analitici basati principalmente su GC/MS e sulla loro applicazione nelle scienze ambientali e Palaeoclimatologia. È stato coordinatore del progetto di Ateneo 2015 "L'ultimo albero in piedi" e del progetto "INSIDE" nell'ambito del programma SPIN 2018. È stato responsabile di UO del progetto Evasion nell'ambito del programma PNRA 2016.
L'attività di ricerca ha portato alla pubblicazione di 39 articoli con più di 400 citazioni (H-index 12). Dal 2019 è membro del comitato editoriale come redattore accademico della rivista Plosone e arbitro di diverse riviste scientifiche.
Dal 2013 ha curato l'attività didattica in Climate of the Past (Scienze Ambientali), Metodi Chimici per i Materiali del Patrimonio Culturale (Scienza della Conservazione e Tecnologia per i Beni Culturali) e Chimica Analitica (Chimica e Tecnologie Sostenibili).
Dal 2016 è membro del Consiglio Didattico e membro del Consiglio di Quality Assurance (AQ) in Scienza e Tecnologia della Conservazione per i Beni Culturali dell'Università Ca’ Foscari di Venezia. Membro del Dottorato di Ricerca in Scienze Ambientali dell'Università Ca’ Foscari di Venezia e Membro del Comitato Paritetico Professori- Studenti (Commissione Paritetica Docenti - Studenti CPDS).
Argiriadis Elena
 Posizione attuale: Ricercatore presso Istituto di Scienze Polari del CNR, Venezia.
Posizione attuale: Ricercatore presso Istituto di Scienze Polari del CNR, Venezia.
In precedenza: assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia dal 2011, anno in cui ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Ambientali. Nel 2016 ha conseguito il dottorato in Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici presso la stessa università.
Tra i principali interessi di ricerca, il campionamento e monitoraggio atmosferico, le analisi in gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa e la messa a punto di metodi analitici per la determinazione di inquinanti organici persistenti in atmosfera e di biomarker in sedimenti lacustri. Attualmente si occupa principalmente di caratterizzazione di proxy organici in sedimenti, suoli e stalagmiti, finalizzata in particolare alla ricostruzione di paleofuochi, della presenza umana e della composizione della vegetazione durante l’Olocene.
Ha collaborato e collabora a diversi progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale (EU-FP7, EU-H2020, NSF-DEB) e coordina il progetto “BioCyCLeS”, finanziato dal Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (PNRA 2018). È autrice di 14 articoli su riviste internazionali con più di 240 citazioni (h-index 7). È stata correlatrice di 12 tesi di laurea e si è occupata della segreteria scientifica e dell’organizzazione logistica della Conferenza Annuale della Società Italiana per le Scienze del Clima (SISC) nel 2017 e nel 2018.
Variabilità dei flussi di materiale particellato nel mare Adriatico Meridionale
 Dove: CNR-ISP Sede di Bologna
Dove: CNR-ISP Sede di Bologna
Tipologia: Tirocinio, Tesi di Laurea
Titolo: Variabilità dei flussi di materiale particellato nel mare Adriatico Meridionale
Tutor/Docente di riferimento: Dr. Stefano Miserocchi, tel. 051 639880, e-mail: stefano.miserocchi AT cnr.it
Stime del forcing radiativo delle nubi nel plateau antartico e in artico
 Dove: CNR-ISP Sede di Bologna
Dove: CNR-ISP Sede di Bologna
Tipologia: Tesi di Laurea
Titolo: Stime del forcing radiativo delle nubi nel plateau antartico e in artico
Tutor/Docente di riferimento: Dr. Angelo Lupi, tel. 051 6399588, email: angelo.lupi AT cnr.it
Vitale Vito
 Dirigente di ricerca presso l'Istituto di Scienze Polari (ISP) del CNR di Bologna, impegnato nella ricerca e gestione delle attività polari dal 1986, sia in Antartide che nell'Artico. Esperto di processi di trasferimento radiativo nell'atmosfera, con particolare attenzione al bilancio radiativo alla superficie e al top dell'atmosfera, e al ruolo che la composizione atmosferica e le caratteristiche della superficie svolgono nella modulazione delle diverse componenti ad onda corta (SW) e a onda lunga (LW), determinandone la variabilità stagionale e inter-annuale. Negli ultimi 10-15 anni, ha promosso anche l'implementazione di piattaforme di osservazione complesse e multidisciplinari, come la Amundsen-Nobile Climate Change Tower a Ny Alesund, per studiare i processi e le interazioni all'interfaccia aria-neve-terra e nel Boundary Layer Atmosferico (ABL).
Dirigente di ricerca presso l'Istituto di Scienze Polari (ISP) del CNR di Bologna, impegnato nella ricerca e gestione delle attività polari dal 1986, sia in Antartide che nell'Artico. Esperto di processi di trasferimento radiativo nell'atmosfera, con particolare attenzione al bilancio radiativo alla superficie e al top dell'atmosfera, e al ruolo che la composizione atmosferica e le caratteristiche della superficie svolgono nella modulazione delle diverse componenti ad onda corta (SW) e a onda lunga (LW), determinandone la variabilità stagionale e inter-annuale. Negli ultimi 10-15 anni, ha promosso anche l'implementazione di piattaforme di osservazione complesse e multidisciplinari, come la Amundsen-Nobile Climate Change Tower a Ny Alesund, per studiare i processi e le interazioni all'interfaccia aria-neve-terra e nel Boundary Layer Atmosferico (ABL).
Le attività di ricerca portate avanti, includono anche (i) studi sugli effetti degli eventi di deplezione dell'ozono nell'Artico sui flussi di superficie UV e sulla loro propagazione alle latitudini più basse, (ii) indagini sull'albedo della superficie della neve (a banda larga e spettrale) e sul processi di scioglimento in primavera, (iii) osservazioni dei profili verticali dell'aerosol (stratificazione) nell'ABL polare con palloni frenati (iv) il miglioramento delle misure dell'aerosol nella colonna atmosferica durante la notte polare grazie alla nuova tecnica della fotometria lunare.
Sempre interessato a migliorare le capacità di osservazione in / per ambienti estremi/polari, sviluppando anche strumentazione innovativa. Gli sforzi attuali sono dedicati allo sviluppo di nuovi sistemi per le caratteristiche ottiche della neve (albedo spettrale, riflettanza BRDF), nonché a migliorare le misurazioni atmosferiche sull'oceano in generale, e in particolare la qualità, la continuità e l'accuratezza delle misurazioni sulle navi delle componenti e del bilancio radiativo alla superficie, della nuvolosita' e sue caratteristiche, e dell'aerosol colonnare (AOT).
![]() https://orcid.org/0000-0003-0978-8976 Scholar
https://orcid.org/0000-0003-0978-8976 Scholar
Tesi Tommaso
 MS (2003) e PhD (2006) in Scienze Ambientali Marine (Università di Bologna).
MS (2003) e PhD (2006) in Scienze Ambientali Marine (Università di Bologna).
La sua ricerca si concentra sui cambiamenti climatici nei sistemi moderni e antichi con focus sulla criosfera (ghiaccio marino e permafrost). Ha ricevuto due grant Marie Curie per lavorare presso la Oregon State University (USA) e l'Università di Stoccolma (Svezia). Fa parte dell'Editorial Board della rivista Marine Chemistry (Elsevier) con focus su biomarcatori organici marini e ha partecipato come Guest Editor della rivista Ocean Science (Copernicus). È rappresentante italiano e membro del Marine Working Group dello IASC (International Arctic Science Committee).
Ha pubblicato 50 articoli scientifici su riviste peer-review che trattano l'uso di biomarcatori fossili per studiare il cambiamento climatico moderno e paleo. Ha servito come chairman all’European Geophysical Union (EGU) a Vienna (Austria) e all'American Geophysical Union (AGU) Fall meeting a San Francisco (USA. Ha partecipato a 17 spedizioni oceanografiche nel Mediterraneo Mare e Artico combinati rappresentano oltre 200 giorni di attività in mare.
![]() http://orcid.org/0000-0002-1686-3375
http://orcid.org/0000-0002-1686-3375
Impact of the COVID19 outbreak on Italian Polar activities
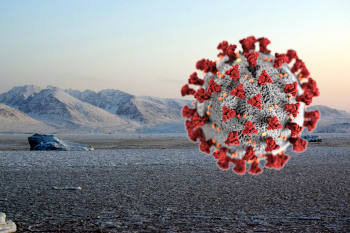
5 Maggio 2020
Arctic
Svalbard: Based on the national policy adopted in consequences of COVID19 pandemic and the restrictions imposed by Norwegian government and the Governor of Svalbard, CNR cancelled all the upcoming field activities at Dirigibile Italia Arctic station until the end of May. Assuming that these restrictions will continue, further cancellations are expected. At the moment, CNR has only one technician there managing the routine operations. Starting from June, some monitoring activities will be supported by the Norwegian Polar Institute staff. (read more)
Barbante Carlo
 (1° direttore ISP dal 1° maggio 2020 al 30 aprile 2024)
(1° direttore ISP dal 1° maggio 2020 al 30 aprile 2024)
Professore Ordinario dell’Università Ca' Foscari Venezia; si occupa da anni di ricostruzioni climatiche ed ambientali e dello sviluppo di metodologie analitiche innovative in campo ambientale e biologico.
Ha partecipato a numerose spedizioni e campagne di prelievo in aree polari e nelle Alpi ed è coordinatore di progetti di ricerca nazionali ed internazionali, nonché autore di oltre 250 pubblicazioni in riviste scientifiche ad alto impatto (h-index 45).
Docente di Earth’s Climate alla Ca’ Foscari Harvard Summer School ha recentemente acquisito un prestigioso Advanced Grant dell’European Research Council per lo studio dell’impatto antropico sul clima in epoca pre-industriale. È stato professore distaccato presso l’Accademia Nazionale dei Lincei dal 2012 al 2014 ed è membro eletto dell’Accademia delle Scienze detta dei XL e dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti. E’ Rappresentante Nazionale nel Comitato di Programma di H2020 su “Climate Action, Environment, Raw Material and Resource Efficiency”.
Svalbard Strategic Grant (SSG)
 The Svalbard Strategic Grant is a seed money program aimed at advancing coordination, collaboration and data sharing between researchers with a relevance to Svalbard.
The Svalbard Strategic Grant is a seed money program aimed at advancing coordination, collaboration and data sharing between researchers with a relevance to Svalbard.
The program is financed by the Research Council of Norway (RCN) and administered by the Svalbard Science Forum (SSF) secretariat in Longyearbyen.
A call for proposals is made annually. The application deadline is the 16 December 2019.
The full call text is available here.
Analisi quantitativa e qualitativa di small microplastics (inferiore a 100 um) e additivi nei suoli montani: lo Stelvio come caso di studio
 Dove: CNR-ISP Sede Venezia-Mestre
Dove: CNR-ISP Sede Venezia-Mestre
Tipologia: Tirocinio, Tesi di Laurea
Titolo: Analisi quantitativa e qualitativa di small microplastics (<100 µm) e additivi nei suoli montani: lo Stelvio come caso di studio
Tutor/Docente di riferimento: Dr. Fabiana Corami, tel. 041 2348658, e-mail: fabiana.corami AT cnr.it
Distribuzione e caratterizzazione di small microplastics (inferiore a 100 um) nel permafrost: le Isole Svalbard come caso di studio
 Dove: CNR-ISP Sede Venezia-Mestre
Dove: CNR-ISP Sede Venezia-Mestre
Tipologia: Tirocinio, Tesi di Laurea
Titolo: Distribuzione e caratterizzazione di small microplastics (<100 µm) nel permafrost: le Isole Svalbard come caso di studio
Tutor/Docente di riferimento: Dr. Fabiana Corami, tel. 041 2348658, e-mail: fabiana.corami AT cnr.it
Laboratorio di Microscopia e Preparativa (MiP)

Breve descrizione
Tra gli inquinanti emergenti, le microplastiche sono diffuse in tutto il globo. In relazione alle loro dimensioni, queste particelle possono essere scambiate come particelle di cibo, possono essere ingerite e accumulate negli organismi, entrando così nella rete trofica. Considerata la loro persistenza ed abbondanza in tutti i comparti ambientali, le microplastiche costituiscono un rischio per l’ambiente e anche la salute umana. Possono inoltre essere vettori di altri inquinanti (inquinanti organici ed elementi in tracce), favorendone l’accumulo all’interno degli organismi. La definizione delle microplastiche è stata data dalla European Chemical Agency nel 2019 (ECHA, 2019): particelle contenenti polimeri solidi alle quali possono essere aggiunti additivi o altre sostanze, e dove più dell’1% w/w delle particelle presentano le dimensioni comprese tra 1nm ≤ x ≤ 5mm o per fibre di lunghezza compresa tra 3nm ≤ x ≤ 15mm, con rapporto lunghezza/diametro >3. Polimeri naturali che non hanno subito modificazioni chimiche (come l’idrolisi) sono esclusi da questa definizione (ECHA 2019). Le microplastiche possono essere primarie e secondarie; fonti di microplastiche primarie sono gli scarichi delle lavatrici, l’usura degli pneumatici, l’urban dust, cosmetici e prodotti per la cura della persona. Una analisi quantitativa accurata con una chiara identificazione del polimero sono necessarie per valutare correttamente l’impatto ambientale di questa classe di inquinanti e per poi progettare azioni correttive per la gestione ambientale.
Strumentazione
Micro-FTIR Nicolet™ iN™10 Infrared Microscope Thermo Scientific, microscopio ottico accoppiato ad uno spettroscopio IR; dotato di due detector: il primo che lavora a temperatura ambiente ((detector DTG (Deuterato Triglicina solfato)), il secondo raffreddato ad azoto liquido (Mercury Cadmium Telluride (MCT) detto anche cooled detector). Ha tre modalità di analisi: trasmissione, riflessione, ATR ed è dotato di videocamera digitale.
Matrice e tipo di misura
Analisi non distruttiva di campioni discreti di acqua marina, sedimenti, suolo, permafrost, acqua dolce, organismi (crostacei, bivalvi, pesci, ecc.), particolato atmosferico, neve, scarichi da lavatrici. Analisi di polimeri plastici, additivi plastici, composti inorganici, fibre naturali. Con il microFTIR è possibile quantificare le particelle/fibre microplastiche, gli additivi, ecc. presenti e simultaneamente identificare il polimero. Questo strumento viene impiegato nell’analisi delle microplastiche, ma è anche utilizzato per le discipline relative al restauro. Si possono analizzare microplastiche presenti in diverse matrici ambientali: dagli scarichi provenienti dalle lavatrici alle acque marine, dal permafrost ai fluidi biologici, ecc.
Per informazioni: Dr. Fabiana Corami - fabiana.corami AT cnr.it - CNR-ISP Sede di Venezia
Tirocini formativi / Training Internships
 Dove: CNR-ISP Sede Messina
Dove: CNR-ISP Sede Messina
Tipologia: Tirocinio di formazione e orientamento
Convenzione tra ISP e l'università di Messina per attività di formazione e orientamento
Special Issue: Advances in Water Quality Monitoring and Assessment in Marine and Coastal Regions (deadline 31 December 2021)

A special issue of Water (ISSN 2073-4441). This special issue belongs to the section "Oceans and Coastal Zones".
This Special Issue aims at the promotion of a multidisciplinary approach to evaluate the quality of aquatic ecosystems, with a particular focus on the transitional environments where marine and terrestrial habitats interlink. Research/review papers jointly dealing with coastal oceanography, hydrogeology, biogeochemistry and marine ecology are of interest, although studies on surface waters (rivers, lakes, etc.) in coastal regions are also welcomed.
Deadline for manuscript submissions: 31 March 2021
Special Issue Editors: Alessandro Bergamasco (CNR-ISMAR), Hong Quan Nguyen (WACC), Gabriella Caruso (CNR-ISP), Qianguo Xing (YIC), Eleonora Carol (CONICET)
Special Issue: Distribution and Metabolic Activities of Marine Microbial Communities in Response to Natural and Anthropogenic Forcings (deadline 30 June 2020)

A special issue of Journal of Marine Science and Engineering (ISSN 2077-1312). This special issue belongs to the section "Marine Biology".
Deadline for manuscript submissions: 30 June 2020
Special Issue Editor: Gabriella Caruso (CNR-ISP)
Altra strumentazione disponibile - Sede Venezia-Mestre

Cromatografo liquido ad elevate prestazioni Agilent 1100 series HPLC system
Breve descrizione
La strumentazione HPLC-MS/MS permette di determinare quantitativamente composti organici polari in diverse matrici ambientali e vegetali e in campioni di biota. Viene comunemente usato per lo studio di traccianti specifici di sorgenti o processi ambientali in campioni prelevati nelle aree polari. Viene usato per la determinazione del levoglucosano, tracciante principale della combustione di biomassa, nelle carote di ghiaccio per lo studio del profilo storico del regime dei fuochi in studi paleoclimatici. Diversi composti organici idrosolubili (amminoacidi liberi e combinati, composti fenolici) sono determinati usando il sistema HPLC-MS/MS in campioni di aerosol per definire la composizione chimica atmosferica in campioni urbani o polari. Pesticidi polari o tossine sono comunemente determinati con questo sistema in campioni di acque dolci, acqua di mare, biota o campioni vegetali.
Strumentazione
Cromatografo liquido ad elevate prestazioni Agilent 1100 series HPLC system (Waldbronn, Germany) dotato di degasatore, sistema di pompe binario, autocampionatore e comparto termostato per le colonne accoppiato con uno spettrometro di massa triplo quadrupolo "API 4000 " (Applied Biosystems/MDS SCIEX, Toronto, Ontario, Canada) dotato di sorgente Turbo V.
Per informazioni: Dr. Roberta Zangrando - roberta.zangrando AT cnr.it - CNR-ISP Sede di Venezia
Matrice e tipo di misura
Analisi di campioni discreti di ghiaccio, neve, aerosol atmosferico, acqua lacustre, acque dolci, acqua di mare, sedimento, matrici vegetali. Analisi di composti organici polari quali ad esempio anidrozuccheri, amminoacidi, composti fenolici, acidi organici.
Agilent 1100 series HPLC system accoppiato a API 4000, cromatografo liquido ad elevate prestazioni accoppiato con uno spettrometro di massa triplo quadrupolo. (IMMAGINE)

Cromatografo liquido UHPLC mod. Dionex Ultimate 3000 Dual Pump RS
Breve descrizione
Questo strumento è l'elemento chiave per realizzare l'analisi in semicontinuo dei composti organici in campioni di ghiaccio.
Strumentazione
Cromatografo liquido UHPLC mod. Dionex Ultimate 3000 Dual Pump RS (Thermo ScientificTM) con degasatore e termostato per le colonne.
Per informazioni: Dr. Elena Barbaro - elena.barbaro AT cnr.it - CNR-ISP Sede di Venezia
Matrice e tipo di misura
Analisi in semicontinuo di carote di ghiaccio. Sistema da accoppiare alla continuous flow analysis (CFA).
Dionex Ultimate 3000 Dual Pump RS Thermo Scientific, cromatografo Liquido UHPLC doppia pompa. (IMMAGINE)

Mercur Plus - Analytik Jena AG, spettrofotometro di fluorescenza atomica a vapori freddi (CV-AFS).
Breve descrizione
La spettroscopia di fluorescenza atomica a vapori freddi (CV-AFS) è una tecnica analitica utilizzata per la determinazione del mercurio a livelli di tracce/ultra-tracce. Viene utilizzata principalmente su matrici acquose "pulite" (ad es. ghiaccio, neve e acqua) da aree remote e incontaminate.
La sensibilità dello strumento viene sfruttata utilizzando metodi ufficiali come US-EPA 1631 versione E o UNI-EN 15853: 2010. Il Hg presente nella matrice viene ossidato a Hg2+ con una soluzione di BrCl e quindi ridotto a mercurio elementare (Hg0) con SnCl2. Il Hg0 viene strippato dalla matrice acquosa usando un gas di trasporto inerte (argon) e successivamente trasportato in trappole d'oro per la pre-concentrazione mediante formazione di amalgama. Dopo il desorbimento termico a T tra 450-500° C, il Hg0 viene desorbito dalle trappole d'oro e viene trasportato in una cella di quarzo.
La luce proveniente da una lampada a vapori di mercurio attraversa la cella di quarzo, che contiene il mercurio in un flusso di gas carrier (argon), eccita tutti gli atomi di mercurio che emettono una caratteristica radiazione di fluorescenza a 253,7 nm. La quantità di luce emessa dagli atomi di mercurio nel campione è proporzionale alla quantità di mercurio che passa attraverso la cella di quarzo. La CV-AFS del CNR-ISP è collocata all’interno di una clean room dedicata.
Strumentazione
Mercur Plus - Analytik Jena AG, spettrofotometro di fluorescenza atomica a vapori freddi (CV-AFS).
Per informazioni: Dr. Massimiliano Vardè - massimiliano.varde AT cnr.it - CNR-ISP Sede di Venezia
Matrice e tipo di misura
Matrici acquose: deposizioni atmosferiche, neve, ghiaccio, acque potabili, acque minerali, acque superficiali, acque di mare. Mercurio, come mercurio totale, o dopo trattamento del campione come disciolto, filtrato e non filtrato.
Mercur Plus - Analytik Jena AG, spettrofotometro di fluorescenza atomica a vapori freddi (CV-AFS). (IMMAGINE)

Gas cromatografo interfacciato con Spettrometro di massa (GC-MS)
Breve descrizione
Il sistema GC-MS permette la quantificazione di composti volatili apolari in matrici ambientali. In campo ambientale trova la sua principale applicazione nella determinazione di inquinanti organici persistenti (POPs) quali PCBs, PBDEs, PAHs, pesticidi, in matrici ambientali sia in aree urbane che remote come le aree polari. Come pure trova applicazione nella determinazione composti per la cura dell’igiene personale come le fragranze che sono state osservate non solo in area urbana ma anche in Antartide.
Nei laboratori della sede di Venezia sono presenti 3 sistemi GC-MS. Fra questi il sistema dotato di trappola criogenica permette la preconcentrazione di composti volatili (permettendo la quantificazione di composti volatili difficili da analizzare in GC anche in quantità bassissima).
È presente inoltre un sistema dotato di pirolizzatore che permette l’analisi di materiali non volatili come materiali plastici.
Strumentazione
• GC-MS 7890A-5975C (Agilent)
• GC-MS GC7890A+MS5975C (Agilent)con trappola criogenica MARKES Int
• GC-MS GC6890+MS5973 (Agilent)con pirolizzatore Pyroprobe 5000 Series
Per informazioni: Dr. Elena Argiriadis - elena.argiriadis AT cnr.it - CNR-ISP Sede di Venezia
Matrice e tipo di misura
Analisi di campioni discreti di ghiaccio, neve, aerosol atmosferico, acqua lacustre, acque dolci, acqua di mare, sedimento, matrici vegetali. Analisi di composti apolari volatili quali PCBs, PBDEs, PAHs, pesticidi, fragranze, sterols.
GC-MS 7890A-5975C Agilent (IMMAGINE)
Laboratorio Spettrometria di Massa (SpeM)
Breve descrizione
Nel laboratorio SpeM, presso la sede di Venezia, i ricercatori si occupano della caratterizzazione chimica (elementi in traccia) ed isotopica (δD, δ13C, δ15N, δ18O) di matrici naturali e della determinazione del contenuto totale di carbonio e azoto (in suoli e sedimenti).
Per elementi in traccia si intendono tutti quegli elementi della tavola periodica presenti nelle matrici naturali con concentrazioni inferiori a 1 ppm (parti per milione). La quantificazione di tali elementi consente, oltre alla caratterizzazione chimica dei campioni esaminati, di valutare eventuali problemi di contaminazione, anche derivanti da attività umane, di comprendere gli scambi che possono avvenire tra i vari comparti dei diversi ecosistemi, di studiare l’origine e la provenienza degli elementi e di ricostruire variazioni temporali legate a cambiamenti climatici attuali e del passato.
Per isotopi si intendono atomi appartenenti ad uno stesso elemento chimico quindi con lo stesso numero atomico ma che differiscono per il numero di massa (differiscono cioè tra loro per il numero di neutroni contenuti all'interno del nucleo). Gli isotopi sono dunque uguali da un punto di vista chimico ma differenti da un punto di vista fisico. Si differenziano in stabili e instabili o radioattivi. Tra gli isotopi stabili più studiati troviamo l’ossigeno, il carbonio, l’idrogeno e l’azoto. Lo studio degli isotopi stabili valuta l’abbondanza relativa tra i vari isotopi di un elemento e dà una misura del rapporto tra uno degli isotopi pesanti e quello più leggero (il più abbondante in natura) di un determinato elemento. Tale rapporto in natura non è costante ma può variare in conseguenza di processi chimici, fisici e biologici che possono portare ad un impoverimento o ad un arricchimento di un isotopo rispetto all’altro nelle varie fasi di un sistema naturale: si parla di frazionamento isotopico. Gli isotopi stabili hanno applicazioni fondamentali per gli studi ambientali e paleoambientali. Ad esempio, la misura di δ18O in una carota di neve/ghiaccio consente di effettuare una ricostruzione dell’andamento della temperatura nel passato.
Strumentazione



Element XR DeltaV Advantage Elemental Analyzer Flash2000HT
ICP-SFMS Element XR Thermo Scientific equipaggiato con vari sistemi di introduzione del campione (spray-chamber Scott-type in PFA; spray-chamber ciclonica, in vetro o in PFA, raffreddata con sistema Peltier; sistema APEX-ESI dotato di spray-chamber ciclonica riscaldata e di un sistema di raffreddamento per la riduzione delle interferenze da ossidi e doppie cariche sia in vetro che in PFA, resistente all’acido fluoridrico; sistema ARIDUS-CETAC dotato di spray-chamber in PFA riscaldata e di membrana riscaldata, per l’abbattimento di ossidi e doppie cariche). Lo strumento è inoltre dotato di autocampionatore protetto da una cappa a flusso laminare che mantiene pulita l’area dove si trovano i campioni durante le sessioni di analisi.
Per informazioni: Dr. Giulio Cozzi - giulio.cozzi AT cnr.it - CNR-ISP Sede di Venezia
IRMS DeltaV Advantage Thermo Scientific con: GasBench (con autocampionatore), Analizzatore Elementale (Elemental Analyzer Flash HT con doppia fornace, due autocampionatori per solidi e un autocampionatore per liquidi e ConFloIV) e Gascromatografo (GC Trace con autocampionatore).
Per informazioni: Dr. Clara Turetta - clara.turetta AT cnr.it - CNR-ISP Sede di Venezia
EA Elemental Analyzer Flash2000HT Thermo Scientific con doppia fornace, due autocampionatori per solidi e un autocampionatore per liquidi.
Per informazioni: Dr. Clara Turetta - clara.turetta AT cnr.it - CNR-ISP Sede di Venezia
Matrice e tipo di misura
ICP-SFMS: neve/ghiaccio, acqua di mare, acque superficiali e sotterranee, acque interstiziali. Determinazione di elementi in traccia e subtraccia (da ppb a ppq).
IRMS - Gas-Bench: Acque (neve/ghiaccio, acqua di mare, acque superficiali e sotterranee, acque interstiziali), carbonati (foraminiferi, carbonati s.s.). Determinazione di δD, δ13C, δ18O.
IRMS - EA: suoli, sedimenti, biota. Determinazione di δ13C, δ15N.
EA: suoli, sedimenti, biota. Determinazione di azoto totale (TN), carbonio totale (TC) e di carbonio organico (OC).
Giordano Patrizia
 Laurea in Scienze geologiche - Università di Bologna, 1999. Ricercatore presso il CNR ISMAR di Bologna, 2000-2019. Ricercatore presso il CNR ISP di Bologna, 2019-oggi.
Laurea in Scienze geologiche - Università di Bologna, 1999. Ricercatore presso il CNR ISMAR di Bologna, 2000-2019. Ricercatore presso il CNR ISP di Bologna, 2019-oggi.
Si occupa di ricostruzioni sedimentologiche, mineralogiche e biogeochimiche, modalità di trasporto e processi deposizionali dei sedimenti di fondo e particelle sospese; valutazioni di impatto ambientale a seguito di input di nutrienti e contaminanti da attività urbane, industriali, portuali, acquacoltura e offshore in ambienti lacustri, di transizione ed ecosistemi marini costieri e profondi. Si è specializzata nel ciclo del fosforo per identificare le cause di crisi distrofiche, crisi anossiche e fenomeni di mucillaggine. Studia i cicli biogeochimici di carbonio, nutrienti e metalli, la loro speciazione, i processi di diagenesi precoce, la biodisponibilità e i flussi bentonici all'interfaccia acqua-sedimento.
Ha partecipato alla progettazione, messa a mare e gestione di Sistemi Osservativi per il Monitoraggio Ambientale Meteo-Marino (Boe Automatiche e Mooring) e allo sviluppo, calibrazione e validazione di incubatori di sedimenti, camere bentoniche e lander per la misurazione, il campionamento e l'analisi di parametri ambientali marini con finalità di ricerca e monitoraggio degli ecosistemi marini.
È impegnata nello studio del carbonio, dei nutrienti, dei contaminanti e della materia organica nei particolati e nei loro calcoli del bilancio di massa, dei flussi verticali e del trasporto laterale dalla piattaforma continentale ai bacini profondi.
Partecipazione a progetti EC, PRA e PNRA, convenzioni con le autorità regionali italiane e contratti con grandi e piccole- medie imprese. Leader PI o WP di progetti nazionali e internazionali. Più di 50 crociere oceanografiche (25 come Chief Scientist). Supervisore e tutor di oltre 30 tesi di laurea e tirocini. Autore e coautore di ca. 100 relazioni scientifiche, 20 pubblicazioni, 50 abstract (149 citazioni, indice H = 8; fonte Scopus).
![]() http://orcid.org/0000-0001-5662-2659 Scopus
http://orcid.org/0000-0001-5662-2659 Scopus
Studio del ciclo geochimico del Mercurio nel manto nevoso superficiale nel plateau Antartico (sito di Dome-C)
 Dove: CNR-ISP Sede Venezia-Mestre
Dove: CNR-ISP Sede Venezia-Mestre
Tipologia: Tirocinio, Tesi di Laurea
Titolo: Studio del ciclo geochimico del Mercurio nel manto nevoso superficiale nel plateau Antartico (sito di Dome-C)
Tutor/Docente di riferimento: Dr. Andrea Spolaor e Dr. Warren Cairns, tel. 041 2348659,041 2348992, e-mail: andrea.spolaor AT cnr.it, warrenraymondlee.cairns AT cnr.it
Studio della frazione idrosolubile di elementi in traccia (TE) e terre rare (REE) in campioni di aerosol atmosferico artico allo scopo di investigare le sorgenti e i meccanismi di trasporto atmosferico
 Dove: CNR-ISP Sede Venezia-Mestre
Dove: CNR-ISP Sede Venezia-Mestre
Tipologia: Tirocinio, Tesi di Laurea
Titolo: Studio della frazione idrosolubile di elementi in traccia (TE) e terre rare (REE) in campioni di aerosol atmosferico artico allo scopo investigare le sorgenti e i meccanismi di trasporto atmosferico
Tutor/Docente di riferimento: Dr. Giulio Cozzi e Dr. Clara Turetta, Tel. 041 2348935, 041 234894, e-mail: giulio.cozzi AT cnr.it, clara.turetta AT cnr.it
Studio di composti organici idrosolubili in campioni di aerosol atmosferico artico per investigare le sorgenti e i meccanismi di trasporto atmosferico
 Dove: CNR-ISP Sede Venezia-Mestre
Dove: CNR-ISP Sede Venezia-Mestre
Tipologia: Tirocinio, Tesi di Laurea
Titolo: Studio di composti organici idrosolubili in campioni di aerosol atmosferico artico per investigare le sorgenti e i meccanismi di trasporto atmosferico
Tutor/Docente di riferimento: Dr. Elena Barbaro, tel. 041 2348545, e-mail: elena.barbaro AT cnr.it
BSRN
La rete BSRN (Baseline Surface Radiation Network) è nata per migliorare la qualità delle misure dei flussi radiativi Terra-Atmosfera che determinano le condizioni termiche e la circolazione dell'atmosfera e dell'oceano. L’ISP ha in carico la gestione dell’osservatorio installato presso la stazione Italo-Francese Concordia in Antartide. Installata nel 2006 la BSRN e finanziata con continuità dal PNRA, è costituita da una serie di strumenti passivi (radiometri e fotometri) per la misura delle diverse componenti del bilancio radiativo (sia nello spettro solare che in quello infrarosso), compreso l’albedo superficiale.
Oltre a queste misure, durante l’estate australe vengono anche misurati il contenuto colonnare di aerosol tramite un fotometro solare SP02 e lo spettro della radiazione ultravioletta tramite un radiometro UV-RAD), da cui è possibile ricavare il valore di ozono, anch’esso su tutta la colonna atmosferica.
Altre misure che vengono effettuate nell’ambito delle attività dell’osservatorio in collaborazione con l'Istituto Meteorologico Finlandese (FMI) riguardano le proprietà fisiche e ottiche del particolato atmosferico al suolo: coefficienti di diffusione ed assorbimento e la distribuzione dimensionale.
Gruvebadet - Laboratorio aerosol
Il laboratorio atmosferico Gruvebadet si trova circa ad un km a sud di Ny-Ålesund ed è dedicato allo studio della composizione atmosferica e più in particolare dell’aerosol. Il laboratorio è stato aperto nel 2010 dal CNR nell’edificio che una volta ospitava le docce dei minatori di Ny-Ålesund (Gruve = miniera, badet = bagno in norvegese).
Il laboratorio è attrezzato per ospitare un gran numero di strumenti dedicati allo studio dell’aerosol. È presente un tetto accessibile per l’installazione sia di teste di prelievo che di campionatori veri e propri, oltre ad una serie di “passaggi” per i tubi di campionamento tra l’interno del laboratorio ed il tetto.
Il laboratorio è gestito dal CNR in collaborazione con numerose università italiane: Firenze, Perugia, Venezia, Torino etc.
Le principali misure effettuate nel laboratorio comprendono:
- la caratterizzazione chimica del particolato atmosferico, anche segregata per dimensione e che comprende la caratterizzazione della componente organica e dei metalli;
- la misura della distribuzione dimensionale degli aerosol e delle loro proprietà di diffusione e di assorbimento della radiazione;
- la misura della componente carboniosa del particolato (EC/OC);
- lo studio dei processi di formazione di nuove particelle e della loro capacità di formare le nubi.
Negli ultimi anni alle attività atmosferiche si sono affiancate quelle di studio del manto nevoso superficiale. L’interazione tra atmosfera e neve è uno degli argomenti che più necessità di approfondimento in quanto, ad esempio, la deposizione di particolato sulla neve può accelerarne lo scioglimento.
Il laboratorio aperto dal CNR ha attirato sempre più interesse da parte di ricercatori stranieri; ad oggi infatti sono numerose le collaborazioni internazionali attivate su questi argomenti (KOPRI, NPI, Università di Helsinki etc.).
- Laboratorio Gruvebadet sul sito:
artico.cnr.it
Climate Change Tower
La Amundsen-Nobile Climate Change Tower (CCT) è una piattaforma scientifica concepita per monitorare le caratteristiche termodinamiche della bassa atmosfera e studiare i processi di scambio, di energia e di massa, e le interazioni con la superficie. Installata alle Isole Svalbard nel villaggio di Ny-Ålesund, a circa 1.2 km a ovest dell’abitato, la CCT è una struttura metallica alta 34 m. composta da 17 moduli, dotata di diversi punti di accesso alla rete elettrica e per la trasmissione di dati. Alla distanza di circa 40 m. dalla torre, in una cabina dedicata, si trovano i sistemi di acquisizione dati e di controllo della strumentazione.
Alla CCT sono stati installati, a quattro diverse altezze, set di strumenti per misurare i profili dei parametri atmosferici standard (temperatura, umidità relativa, intensità e direzione del vento); sono stati installati a 2 quote sensori per la misura del bilancio radiativo e delle sue componenti nel visibile e nell’infrarosso; sono stati installati a 2 quote sensori a risposta veloce per la misura dei flussi di calore, momento e umidità. Alla torre sono inoltre stati connessi sensori per la misura della caratterisitiche fisiche della neve (spessore, temperatura superficiale e nello strato) e del suolo sottostante (temperatura).
Dedicata alle imprese dell'esploratore norvegese Roald Amundsen e dell’italiano Umberto Nobile la CCT è stata finanziata dal Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente Terra e Ambiente (DSSTTA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ed è stata inaugurata il 30 aprile 2009.
A partire dal 2012 la CCT e l’area circostante sono diventate un punto di riferimento per la l’osservazione integrata delle diverse componenti del sistema climatico e, attraverso nuove collaborazioni nazionali ed internazionali, sono state implementate installazioni per la misura dei gas serra ( in collaborazione con KOPRI) per la misura dell’indice di copertura nevosa e di riflettività spettrale della neve, per la misura dei profili di vento telerilevati con SODAR e Wind LIDAR (in collaborazione con KOPRI), per lo studio della variazione dello strato attivo, della vegetazione, della copertura nevosa e del profili della temperatura nel permafrost.
Ancoraggi Strumentati Permanenti
MDI
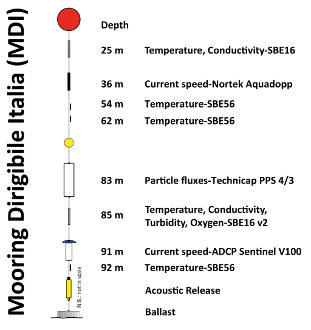 Nella parte interna del Kongsfjorden (Isole Svalbard) a circa 100 m di profondità è stato installato un ancoraggio strumentato permanente con l'obiettivo di studiare l’intensità e la composizione dei flussi di particelle in caduta verso il fondo, monitorando nel contempo le principali proprietà fisiche della colonna d'acqua. L'ancoraggio chiamato Dirigibile Italia (MDI) è stato implementato per la prima volta nel settembre 2010 e viene revisionato annualmente. I dati acquisiti e memorizzati dai vari strumenti vengono scaricati durante la manutenzione, controllati per QA /QC ed inseriti nell'Artic Data Center italiano (IADC).
Nella parte interna del Kongsfjorden (Isole Svalbard) a circa 100 m di profondità è stato installato un ancoraggio strumentato permanente con l'obiettivo di studiare l’intensità e la composizione dei flussi di particelle in caduta verso il fondo, monitorando nel contempo le principali proprietà fisiche della colonna d'acqua. L'ancoraggio chiamato Dirigibile Italia (MDI) è stato implementato per la prima volta nel settembre 2010 e viene revisionato annualmente. I dati acquisiti e memorizzati dai vari strumenti vengono scaricati durante la manutenzione, controllati per QA /QC ed inseriti nell'Artic Data Center italiano (IADC).
Attualmente è disponibile una serie temporale di dati per scopi climatici di ca 10 anni.
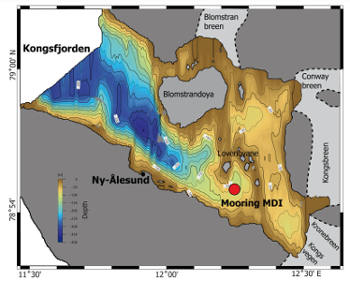 Il MDI consente di monitorare in continuo le variazioni delle caratteristiche termoaline di:
Il MDI consente di monitorare in continuo le variazioni delle caratteristiche termoaline di:
a) acqua superficiale proveniente dalla fusione del ghiacciaio;
b) acqua intermedia che deriva dall’intrusione dell’acqua di tipo Atlantico;
c) acqua di fondo prodotta localmente durante l'inverno.
Inoltre attraverso la raccolta di particolato vengono acquisite informazioni sui processi sedimentari e sulle interazioni di acqua e particolato con il microzooplancton, i ghiacciai e il deflusso costiero. La complessa interazione tra i processi che guidano l’apporto di particelle di origine autoctona (marina) e alloctona (terrestre) nel Kongsfjorden è ormai stata compresa, alcune interpretazioni su possibili cambiamenti futuri nei flussi di particelle per i fiordi artici in uno scenario di riscaldamento globale possono essere suggerite.
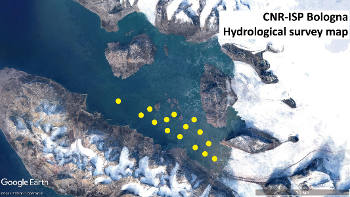 I sensori oceanografici sono posizionati lungo l’ancoraggio a diversi livelli nella colonna d'acqua. L'elenco dei parametri misurati include:
I sensori oceanografici sono posizionati lungo l’ancoraggio a diversi livelli nella colonna d'acqua. L'elenco dei parametri misurati include:
- temperatura dell'acqua a 25, 36, 54, 62, 85 e 92 m
- velocità e direzione delle correnti a 37 e 93 m
- conducibilità/salinità a 25 e 85 m
- torbidità e ossigeno disciolto a 85 m
- flussi di massa totale e di carbonio organico particolato a 83 m
Un sondaggio idrologico viene, inoltre, eseguito ogni anno, principalmente durante l’estate, al fine di rappresentare un quadro stagionale della distribuzione spaziale delle diverse masse d'acqua nel fiordo. Viene a tal scopo ripetuta una griglia di circa 15 stazioni per misurare le principali caratteristiche chimico-fisiche delle masse d'acqua: temperatura, conducibilità e torbidità.
50esima Giornata Mondiale della Terra - EARTH DAY 2020 - Viaggio dal Polo Sud al Polo Nord della Terra
 De Agostini Scuola, in collaborazione con il CNR, celebra la giornata internazionale della Terra con un viaggio dal Polo Sud al Polo Nord della Terra, alla scoperta della salute del nostro pianeta.
De Agostini Scuola, in collaborazione con il CNR, celebra la giornata internazionale della Terra con un viaggio dal Polo Sud al Polo Nord della Terra, alla scoperta della salute del nostro pianeta.
22 Aprile 2020, 11:00
Con: Luca Perri, Marco Casula (CNR-ISP), il team CNR in Antartide, Angelo Viola (CNR-ISP) e Serena Giacomin
VIDEO - Earth day 2020: Un viaggio sostenibile dal Polo Sud al Polo Nord
Destinatari:
Docenti e studenti della Scuola secondaria di I Grado e Primo biennio del II Grado
Assegni di Ricerca - Borse di Ricerca
Borse di Studio
Al momento non ci sono bandi attivi
Special Issue: Polar Microbial Ecology: The Role of Microbes in the Functioning of Extremely Cold Ecosystems (deadline 31 July 2020)

A special issue of Microorganisms (ISSN 2076-2607). This special issue belongs to the section "Environmental Microbiology".
This Special Issue invites you to join in by submitting contributions concerning the role of microbes in the functioning of extremely cold ecosystems, by including as main topics correlations between microbial diversity and polar environmental conditions, temporal and spatial changes in polar microbial communities, metagenomics and molecular advances in polar microbial ecology, relationships and symbiotic associations of cold-adapted microbes with their implications, biogeochemical processes in polar habitats, polar bioprospecting, role of polar microbes in restoration of environments, and biotechnological applications of these extremophiles.
Deadline for manuscript submissions: 31 July 2020
Special Issue Editors: Angelina Lo Giudice (CNR-ISP), Carmen Rizzo (UNI-Me), Maurizio Azzaro (CNR-ISP)
Osservatorio Col Margherita
Osservatorio meteo-climatico di alta quota del Col Margherita (MRG)
Stazione Regionale GAW-WMO
L'osservatorio di alta quota del Col Margherita (MRG) si trova nel versante meridionale delle alpi orientali (46.37 N, 11.79 E), ad un’altitudine di 2543 metri sul livello del medio mare. Il sito si trova all'interno delle Dolomiti, patrimonio UNESCO, ed è considerato strategico in quanto, nonostante l'altitudine non particolarmente elevata, è rappresentativo della condizione sinottica del versante sud-orientale della Alpi dove non sono presenti analoghe infrastrutture. Le principali caratteristiche del sito sono la rappresentatività delle condizioni sinottiche della libera troposfera a 700 hPa, la scarsa influenza delle barriere orografiche dell’area circostante e l’assenza di sorgenti locali di inquinamento.
Strumentazione attualmente installata presso l’osservatorio:
- stazione meteorologica completa: temperatura, umidità, velocità e direzione del vento, pressione atmosferica, radiazione solare incidente e riflessa, sensori per la misura della precipitazione atmosferica e dell’altezza del manto nevoso.
- Analizzatore di mercurio.
- Deposimetro per l’analisi del mercurio nelle precipitazioni.
- Deposimetri bulk per l’analisi di composti organici, inorganici e isotopi stabili.
Segui su Twitter
Storia
L'osservatorio atmosferico del Col Margherita è stato costruito nel 2012 nell'ambito del progetto GMOS (2013-2015) ed è stato successivamente operativo nell'ambito dei progetti NextData (2016-2018) e I-GOSP (2018-2020). L'osservatorio è dotato di una stazione meteorologica completa, di un analizzatore di ozono e di un analizzatore di mercurio gassoso totale. La stazione è completamente automatizzata. È collegato alla rete elettrica principale ed è anche fornita di un sistema di backup ad energia solare con ~200Ah di batterie in caso di guasto della rete. L'osservatorio è dotato di un telecomando tramite tecnologia GSM/GPRS. Il sito, data la vicinanza alla funivia dello Sky Area San Pellegrino che facilita l'accesso al sito, ospita anche campagne stagionali per il campionamento della neve e delle deposizioni atmosferiche umide e secche.
Rientrato in Italia Marco Casula (CNR-ISP)
 10 Giugno 2020
10 Giugno 2020
Marco Casula, tecnico del CNR-ISP, è rientrato in Italia dalla Stazione di Ricerca in Artico del CNR Dirigibile Italia a Ny-Ålesund, nelle Isole Svalbard.
Il tecnico si trovava presso la Stazione del Cnr dal primo gennaio 2020 con il ruolo di acting station leader ed era rimasto bloccato, causa COVID-19.
ALTRO:
- Intervista dal sito ufficiale del CNR (5 aprile 2020)
- Articolo sul sito "Altre Storie"
- Puntata di GEO AND GEO del 7 aprile 2020
ANTARCTICA 2020 - St. Petersburg, RUSSIA
Due to the unpredictable situation with COVID-19, the conference will be postponed until late spring 2021.
An international conference on polar science and exploration organized by the Arctic and Antarctic Research Institute (AARI) and Roshydromet.
They invite specialists in the following fields to participate in the conference:
- Antarctic geology and solid Earth geophysics
- Geomorphology and paleogeography
- Antarctic atmosphere and Southern Ocean
- Space weather
- Antarctic ice sheet dynamics and mass balance
- Subglacial environments
- Ice drilling and ice core science
- Biodiversity, microbiology and ecology
- Antarctic history and heritage.
#ANTARCTICA2020 Site
Special Issue: Geochemical Characterization of Geothermal Systems: Multidisciplinary Approaches to Define Source Processes, Evolution and Environmental Issues (deadline 15 December 2020)

A special issue of Geosciences (ISSN 2076-3263). This special issue belongs to the section "Geochemistry".
The main scope of this Special Issue is the exploration and evaluation of both innovative and long-validated approaches to the geochemical characterization of geothermal areas.
Deadline for manuscript submissions: 25 July 2022
Special Issue Editors: Giovanni Vespasiano (UNI-Cal), Massimiliano Vardè (CNR-ISP), Carmine Apollaro (UNI-Cal)
Gilardoni Stefania
 Formazione ed esperienze professionali. Dottorato in Scienze Chimiche presso l’Università degli Studi di Milano (2003). Laurea in Chimica presso l’Università degli Studi di Milano (2000)
Formazione ed esperienze professionali. Dottorato in Scienze Chimiche presso l’Università degli Studi di Milano (2003). Laurea in Chimica presso l’Università degli Studi di Milano (2000)
Primo ricercatore presso l’Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISP-CNR) sede di Bologna, Agosto 2019 – presente Ricercatore presso l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISAC-CNR), Luglio 2011 - Luglio 2019. Visiting researcher presso il Finnish Meteorological Instute (FMI), Febbraio 2011 – Marzo 2011. Ricercatore presso il Joint Research Center della Commissione Europea, Ottobre 2007 – Settembre 2010. Ricercatore presso la University of California – San Diego, Luglio 2005 – Settembre 2007. Ricercatore presso la University of California – Davis, Febbraio 2004 – Giugno 2005.
Attività internazionali. Editor per "Atmospheric Chemistry and Physics" (dal 2013). Editor per "Aerosol and Air Quality Research" (dal 2011). Guest Editor per "Atmosphere" special issue on Aerosol Mass Spectrometry (2017). Referee per diverse riviste sicentifiche incluse: Atmospheric Chemistry and Physics, Atmospheric Environment, Environmental Pollution, Environmental Science and Technology, Journal of Geophysical Research. Rappresentante italiani nell’ambito del “Expert Group on Black Carbon and Methane” del Arctic Council (dal 2019). Working group leader nell’ambito del progetto COST Colossal (2017-2021) per l’identificazione delle sorgenti dell’aerosol organico.
Interessi della ricerca scientifica. Caratterizzazione chimica e fisica dell’aerosol atmosferico, con particolare attenzione alla componente carboniosa (aerosol organico e black carbon). Studio delle proprietà rilevanti per il clima, incluso le proprietà chimiche, microfisiche, i processi di formazione dell’aerosol in atmosfera e le sue sorgenti primarie. Studio dell’interazione aerosol-nube e degli impatti della qualità dell’aria e del clima sulla formazione delle nebbie.
Autore di 58 pubblicazioni in riviste peer-review e di 5 capitoli di libro (h-index 21 – web of science)
Scopus - Author ID: 6602523027 ![]() http://orcid.org/0000-0002-7312-5571 WoS Researcher ID: P-1283-2014 Google Scholar
http://orcid.org/0000-0002-7312-5571 WoS Researcher ID: P-1283-2014 Google Scholar
Bando Dottorato di ricerca 37° ciclo in Scienze Polari - scadenza 21 aprile 2021
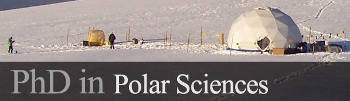 Università Ca’ Foscari - Venezia
Università Ca’ Foscari - Venezia
Emanato il bando di concorso per l'ammissione ai Corso di Dottorato 37° ciclo in Scienze Polari. Informazioni relative alle modalità di partecipazione al concorso: www.unive.it
Versione in Inglese scaricabile. Il termine per la presentazione della domanda di ammissione è mercoledì 21 aprile 2021 ore 13.00 (ora italiana). Per informazioni sul bando inviare una mail a phd.application AT unive.it.
Antartide. Nuova call per la spedizione italiana presso la stazione Concordia 2020-2021
 Il PNRA (Programma nazionale di ricerche in Antartide) procede annualmente alla composizione e alla formazione del gruppo scientifico-tecnico-logistico per le attività da svolgere nel continente antartico. Data la necessità di avvalersi della collaborazione di alcune figure professionali per le attività di cosiddetto Winter Over, è stato pubblicato l'Avviso di interesse per la partecipazione alla XXXVI spedizione italiana in Antartide presso la stazione Concordia nel periodo Novembre 2020-Novembre 2021.
Il PNRA (Programma nazionale di ricerche in Antartide) procede annualmente alla composizione e alla formazione del gruppo scientifico-tecnico-logistico per le attività da svolgere nel continente antartico. Data la necessità di avvalersi della collaborazione di alcune figure professionali per le attività di cosiddetto Winter Over, è stato pubblicato l'Avviso di interesse per la partecipazione alla XXXVI spedizione italiana in Antartide presso la stazione Concordia nel periodo Novembre 2020-Novembre 2021.
--->>>>>>> NUOVA SCADENZA 12 MAGGIO 2020
Zecchetto Stefano
 Laureato in Fisica presso l'Università di Padova. Ricercatore al CNR dal 1988.
Laureato in Fisica presso l'Università di Padova. Ricercatore al CNR dal 1988.
La sua principale attività di ricerca è nel campo del telerilevamento del mare con sensori attivi (Synthetic Aperture Radar-SAR, scatterometro), con particolare attenzione ai processi meteorologici alle meso e micro scale e alla determinazione di parametri geofisici da immagini SAR.
Si occupa della modellizzazione dei ghiacciai alpini per determinare la loro evoluzione nello scenario dei cambiamenti climatici.
Ha coordinato progetti ESA (European Space Agency) e partecipa a progetti ASI (Agenzia Spaziale Italiana). Attualmente è responsabile del progetto IsCSK4MOSAiC, partecipato da ASI e CNR, per la fornitura alla spedizione artica MOSAiC (settembre 2019 - settembre 2020, mosaic-expedition.org) in tempo quasi reale di immagini SAR di CosmoSkyMED.
Insegna Remote Sensing come professore associato presso l’Università del Golfo Persico, Bushehr, Iran.
Posizione lavorativa: cessato
Scopus - Author ID: 6701758544 ![]() http://orcid.org/0000-0003-4633-1238 WoS Researcher ID: O-2523-2015
http://orcid.org/0000-0003-4633-1238 WoS Researcher ID: O-2523-2015
Roma
Sede di ISP Roma
Dove siamo: la sede secondaria dell’Istituto di Scienze Polari di Roma – Montelibretti è ubicata nell’ Area della Ricerca CNR di Roma 1, Strada Provinciale 35d, km 0,700, 00010 Montelibretti (RM). Il personale ISP dell’Area di Montelibretti, occupa una superficie complessiva (uffici e laboratori) di 252 m2 distribuita tra 2 edifici in parte condivisi con il personale IRSA (Istituto di ricerca sulle Acque) ed IIA (Istituto sull’Inquinamento Atmosferico). Mappa
Come raggiungerci:
- in treno: linea ferroviaria FR1 (Fiumicino-Fara Sabina), scendere alla fermata Pianabella di Montelibretti e procedere per 200 m a piedi fino all’ingresso del CNR-Area della Ricerca di Roma 1;
- in auto: l’Istituto è raggiungibile in automobile con la possibilità di parcheggiare temporaneamente all’interno del CNR-Area della Ricerca di Roma 1;
- in aereo: dall’aeroporto di Fiumicino, prendere la linea ferroviaria FR1 (Fiumicino-Fara Sabina), scendere alla fermata Pianabella di Montelibretti e procedere per 200 m a piedi fino all’ingresso del CNR-Area della Ricerca di Roma 1.
Contatti
 ISP - Sede di Roma
ISP - Sede di Roma
Responsabile
Dr.ssa Luisa Patrolecco
E-mail: responsabile_rm AT isp.cnr.it
CNR Area della Ricerca di Roma 1
Via Salaria km 29,300 - 00015 Montelibretti (RM)
Tel: +39 06-90672797
Fax: +39 06-90672787
Sclavo Mauro
 Laurea in Fisica; Scuola di Perfezionamento in Ingegneria Marittima e Costiera; Dirigente di Ricerca CNR dal 2020. Si è occupato di modellazione di onde da vento e dei processi fisici tipici della fascia costiera con particolare riferimento al trasporto di sedimenti. Gli strumenti prevalentemente utilizzati sono modelli numerici di onde e di trasporto di sedimenti, anche accoppiati a modelli di circolazione 3-D. Si è anche interessato dello studio delle variazioni di clima ondoso dovute a cambiamenti climatici e del loro impatto sulla vulnerabilità costiera ed alla individuazione di indicatori per la gestione integrata della fascia costiera, alla modellizzazione di eventi meteomarini estremi. Si occupa inoltre di misure e restituzione di spettri ondosi mediante tecniche stereoscopiche.
Laurea in Fisica; Scuola di Perfezionamento in Ingegneria Marittima e Costiera; Dirigente di Ricerca CNR dal 2020. Si è occupato di modellazione di onde da vento e dei processi fisici tipici della fascia costiera con particolare riferimento al trasporto di sedimenti. Gli strumenti prevalentemente utilizzati sono modelli numerici di onde e di trasporto di sedimenti, anche accoppiati a modelli di circolazione 3-D. Si è anche interessato dello studio delle variazioni di clima ondoso dovute a cambiamenti climatici e del loro impatto sulla vulnerabilità costiera ed alla individuazione di indicatori per la gestione integrata della fascia costiera, alla modellizzazione di eventi meteomarini estremi. Si occupa inoltre di misure e restituzione di spettri ondosi mediante tecniche stereoscopiche.
E' stato Responsabile Scientifico di numerosi progetti nazionali ed internazionali ed è coautore di più di 80 lavori su riviste ISI e di oltre 150 comunicazioni a convegni. E'co-editore di MEDATLAS: Wind and Wave Atlas of the Mediterranean Sea ed è stato cotitolare di 2 brevetti CNR.
Scopus - Author ID: 7004338399 Google Scholar Research Gate
Viola Angelo Pietro
 In ricordo (1955 - 2023)
In ricordo (1955 - 2023)
Laureato in Fisica presso l’Università di Roma La Sapienza con una tesi in Oceanografia fisica.
Assunto nel 1984 al CNR ha svolto ricerche nell’ambito del telerilevamento da satellite della superficie del mare.
Nel 1992 ha iniziato ad occuparsi dei processi nello strato limite atmosferico utilizzando misure di telerilevamento acustico da terra. Ha collaborato allo sviluppo e alla implementazione sodar alla messa a punto di nuove metodologie per osservazione della bassa atmosfera.
Nell'ambito di queste attività ha partecipato a diverse campagne in Antartide presso le stazioni Mario Zucchelli e Concordia, per lo studio delle caratteristiche dinamiche dello strato limite atmosferico in ambiente polare. Dal 2009 ha orientato la sua attività’ di ricerca sui processi che attengono ai cambiamenti climatici nella regione polare artica, che ha visto un forte rilancio delle ricerche in atmosfera, con la costruzione della Climate Change Tower, un'importante infrastruttura per la misura dei parametri fisici dell'atmosfera, di cui è responsabile.
Attualmente ha un ruolo di coordinamento nel gruppo di lavoro delle attività di ricerca italiane alle Svalbard, rappresentante il CNR nel NYSMAC ed è inserito nei gruppi di lavoro di coordinamento SIOS per la gestione dei dati delle Svalbard (SDMS), è Chair del WG per le Infrastrutture di ricerca (RICC). E’ anche rappresentante italiano all’interno del gruppo di lavoro AMAP (monitoraggio atmosferico) del Consiglio Artico. Infine è responsabile scientifico dell’infrastruttura digitale IADC (Italian Arctic Data Center) per la gestione dei dati acquisti in Artico presso la stazione Dirigibile Italia.
Google scholar: 113 publ. , Cit. 1044, H index , 19 iH- Index , 33
Scopus - Author ID: 7005414768 ![]() http://orcid.org/0000-0002-6545-7496 Google Scholar
http://orcid.org/0000-0002-6545-7496 Google Scholar
Spataro Francesca
 Ha conseguito la laurea in Chimica ed il Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche presso l'Università Sapienza di Roma.
Ha conseguito la laurea in Chimica ed il Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche presso l'Università Sapienza di Roma.
E’ stata assegnista di ricerca e poi titolare di un contratto da ricercatore a tempo determinato dal 2013 al 2016 presso l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IIA). Dal 2016 al 2018 è ricercatore a tempo indeterminato, inizialmente presso l’Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR (CNR-IRSA) e dal 1 Agosto 2019 presso l’Istituto di Scienze Polari (CNR-ISP) Area della Ricerca di Roma - Montelibretti.
Ha partecipato a diverse campagne di monitoraggio anche in aree polari (Artico) che afferivano a progetti/collaborazioni Nazionali ed Internazionali.
L’attività di Ricerca si focalizza su:
- Processi di formazione, trasporto e rimozione degli inquinanti azotati ed alogenati in fase gassosa e particellare.
- Processi eterogenei con contaminanti azotati (NOx, NH3, HONO, HNO3).
- Studio della persistenza di micro-inquinanti organici normati ed emergenti in diversi comparti ambientali.
- Sviluppo ed ottimizzazione di metodi per la determinazione di contaminanti organici emergenti (in particolare farmaci ed antibiotici).
- Determinazione di microinquinanti organici persistenti ed emergenti in diverse matrici ambientali mediante la combinazione di tecniche estrattive (estrazione liquida pressurizzata, estrazione in fase solida, imbuti separatori) con tecniche analitiche (spettrometria, HPLC accoppiata a rilevazione UV, Fluorescenza e spettrometria di massa).
Scopus - Author ID: 36605258800
Salvatori Rosamaria
 Laureata in Scienze geologiche (1981), ha conseguito il Dottorato in Scienze della Terra (1987) presso l'Università di Roma La Sapienza.
Laureata in Scienze geologiche (1981), ha conseguito il Dottorato in Scienze della Terra (1987) presso l'Università di Roma La Sapienza.
Ha iniziato la sua attività scientifica al CNR durante il suo dottorato di ricerca e nel 2001 è entrata a far parte del CNR-IIA come primo ricercatore; dal 2019 fa parte dell’Istituto di Scienze Polari (CNR-ISP) - Area della Ricerca di Roma - Montelibretti. Docente di Telerilevamento e GIS per il Corso di Laurea Magistrale in Ecobiologia (Università di Roma, Sapienza) dal 2011.
Interessi scientifici: studi ambientali in aree polari e mediterranee utilizzando immagini telerilevate multi sensore e multi piattaforma per l’analisi dei cambiamenti del territorio a scala locale e regionale; analisi geostatistica di dati ambientali e cartografia tematica in ambiente GIS.
L’attività di ricerca è focalizza sullo studio delle proprietà spettroradiometriche (VIS-IR) delle superfici naturali per l’interpretazione e l’analisi dei prodotti derivanti dall’Osservazione della Terra.
Dal 1997, è coinvolta in indagini sul campo nelle regioni polari (Antartide e Artico) per lo studio delle proprietà radiometriche di neve e ghiaccio e delle interazioni all'interfaccia neve/aria/suolo.
People CNR
Rauseo Jasmin
 Ha conseguito una laurea in Ecobiologia (LM) presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e un PhD in Biologia Ambientale ed Evoluzionistica presso lo stesso ateneo.
Ha conseguito una laurea in Ecobiologia (LM) presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e un PhD in Biologia Ambientale ed Evoluzionistica presso lo stesso ateneo.
Le sue attività di ricerca sono focalizzate sullo studio delle interazioni dei contaminanti organici (es. farmaci, antibiotici, idrocarburi policiclici aromatici, nonilfenoli, bisfenolo, etc) con i microorganismi autoctoni; a tal proposito ha acquisito esperienza sull’allestimento di microcosmi di biodegradazione per lo studio della persistenza ambientale di contaminanti selezionati e i loro effetti su struttura e funzione delle comunità microbiche naturali.
Una nuova linea di ricerca riguarda lo studio della diffusione dei geni che conferiscono resistenza agli antibiotici (ARGs) tra le comunità microbiche naturali, correlando tale parametro con la concentrazione di antibiotici rilevata nell’ambiente.
Si occupa dello sviluppo e validazione di metodologie analitiche (es LC-MS/MS) per la determinazione di inquinanti organici in diverse matrici ambientali e analisi delle comunità microbiche naturali (es PLFA e qPCR).
Scopus - Author ID: 57192521577
Plini Paolo
 Laureato in Scienze Naturali nel 1984.
Laureato in Scienze Naturali nel 1984.
Ricercatore CNR dal 1994 presso l'Istituto Tecnologie Biomediche (ITBM). Dal 2002 all'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico (IIA). Dal 2019 all'Istituto di Scienze Polari (CNR-ISP) - Area della Ricerca di Roma - Montelibretti.
Macroaree CNR di riferimento: Terra e Ambiente.
Interessi di ricerca:
- organizzazione della conoscenza ambientale e geografica
- analisi qualitative e quantitative della vertebratofauna
- sistemi Informativi Geografici
- geoscienze militari.
Attualmente svolge attività di ricerca sullo sviluppo concettuale e sull’innovazione tecnologica nel settore dell’organizzazione della conoscenza, della terminologia controllata e dei thesauri multilingui per l'ambiente.
Ha collaborato tra l'altro con il Programma Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), con l'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA), con l'Agenzia Americana di Protezione Ambientale (US EPA).
E' coautore dei Thesauri UNEP-Infoterra, GEMET, GEneral Multilingual Environment Thesaurus e EARTh, Environmental Applications Reference Thesaurus.
Scopus - Author ID: 25121723300 ![]() http://orcid.org/0000-0001-7315-3364
http://orcid.org/0000-0001-7315-3364
Patrolecco Luisa
 Ha conseguito la Laurea in Chimica nel 1993 presso l'Università di Roma La Sapienza.
Ha conseguito la Laurea in Chimica nel 1993 presso l'Università di Roma La Sapienza.
Dal 1996 al 2019 è stata ricercatrice presso l’Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR-IRSA), responsabile del laboratorio di Analisi di Microinquinanti Organici Prioritari ed Emergenti negli Ecosistemi Acquatici.
Dal 1° agosto 2019 è ricercatrice dell’Istituto di Scienze Polari (CNR-ISP), di cui è Responsabile della Sede Secondaria (RSS) di Roma (Montelibretti e Tor Vergata).
Interessi Scientifici:
studio del comportamento ambientale di micro- e macroinquinanti organici negli ecosistemi acquatici e terrestri in aree temperate e polari, dal riconoscimento delle sorgenti, alle dinamiche di diffusione, all’impatto ambientale. Particolare attenzione è stata rivolta ai contaminanti pericolosi e prioritari secondo la WFD (tra cui IPA, PCB, pesticidi organoclorurati e loro metaboliti, PBDE), alteratori endocrini (ormoni steroidei, metaboliti tensioattivi, plasticizzanti) e contaminanti emergenti (residui farmaceutici, antibiotici, prodotti per la cura personale, fragranze, composti perfluorinati, pesticidi di nuova generazione).
Le attività di ricerca sono finalizzate:
- messa a punto e validazione di metodologie analitiche avanzate (GC-MS, LC-MS e LC-MS/MS) per la caratterizzazione e il monitoraggio di classi di inquinanti organici nei diversi comparti ambientali (acque marine, fluviali, sotterranee, reflue, sedimento, particolato fluviale, marino e lacustre, suolo, organismi);
- studio delle dinamiche di diffusione di contaminanti organici normati ed emergenti in ecosistemi marini polari (Artide, Antartide) e loro distribuzione nei comparti atmosfera/ghiaccio/mare/sedimento/biota in funzione dei cambiamenti stagionali e climatici;
- studi di ripartizione di tali contaminanti (speciazione e biodisponibilità); accumulo/bioaccumulo/biomagnificazione; persistenza e trasformazione (degradazione abiotica e biotica), interazione e possibili effetti sulla sfera biologica a diversi livelli trofici (microrganismi, organismi); effetti ecotossicologici dovuti alla contaminazione multipla;
- circolazione e caratterizzazione chimica e fisica della sostanza organica in ambienti marini e di transizione.
Ha partecipato a oltre 25 campagne oceanografiche e di campionamenti in ambiente mediterraneo e artico.
Autrice di 60 pubblicazioni internazionali ISI, 70 pubblicazioni/contributi con ISSN o ISBN, oltre 50 Relazioni Tecniche/Rapporti di Progetti nazionali e internazionali.
Scopus - Author ID: 6507972161 Research Gate
Di Franco Sabina
 Geologa, (laureata alla Sapienza nel 1992 con una tesi in geomorfologia applicata), lavora dal 2003 al CNR come tecnologo.
Geologa, (laureata alla Sapienza nel 1992 con una tesi in geomorfologia applicata), lavora dal 2003 al CNR come tecnologo.
I suoi campi di ricerca riguardano l'organizzazione della conoscenza, in particolar modo il linguaggio scientifico, la terminologia ed i suoi strumenti (thesauri, glossari, ontologie) e di valutazione degli impatti ambientali (redazione di studi di impatto ed inventari delle emissioni).
Si è anche occupata di pianificazione, progettazione e implementazione di WebGIS e GIS, con particolare attenzione alla cartografia tematica.
Research Gate
Cialli Pamela
 Maturità Linguistica. Dal 2007 al 2018 assunta al CNR con contratto di lavoro a tempo determinato, profilo Collaboratore di Amministrazione, VII livello, nell'ambito di un Accordo stipulato tra Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali – IV Divisione (ora Divisione III - Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale) con compiti riguardanti l'organizzazione e la gestione dei flussi informativi e documentali relativi ai procedimenti ex D.L.gs 152/2006 e s.m.i. attinenti alle AIA di competenza nazionale, relativamente al coordinamento sia delle attività tecniche che di quelle economico-finanziarie. Supporto alla gestione dei sistemi informativi dedicati alla conduzione dei procedimenti di AIA e alla fruizione da parte del pubblico dei relativi dati.
Maturità Linguistica. Dal 2007 al 2018 assunta al CNR con contratto di lavoro a tempo determinato, profilo Collaboratore di Amministrazione, VII livello, nell'ambito di un Accordo stipulato tra Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali – IV Divisione (ora Divisione III - Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale) con compiti riguardanti l'organizzazione e la gestione dei flussi informativi e documentali relativi ai procedimenti ex D.L.gs 152/2006 e s.m.i. attinenti alle AIA di competenza nazionale, relativamente al coordinamento sia delle attività tecniche che di quelle economico-finanziarie. Supporto alla gestione dei sistemi informativi dedicati alla conduzione dei procedimenti di AIA e alla fruizione da parte del pubblico dei relativi dati.
Da dicembre 2018 assunta al CNR con contratto di lavoro a tempo indeterminato con profilo di Collaboratore, VII livello, sempre nell'ambito dello stesso Accordo di Collaborazione.
Da settembre 2019 trasferita all'Istituto di Scienze Polari, presso la Sede Secondaria di Roma Tor Vergata.
Ademollo Nicoletta
 Si è laureata in Scienze Biologiche, ha poi conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Polari nel 2003 sempre all’Università di Siena.
Si è laureata in Scienze Biologiche, ha poi conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Polari nel 2003 sempre all’Università di Siena.
Le principali linee di ricerca sono finalizzate alla comprensione di sorgenti, flussi, distribuzione e destino di contaminanti organici persistenti (POPs) ed emergenti in ecosistemi (marini e costieri) polari e temperati. Studi recenti sono incentrati allo studio del trasferimento di POPs emergenti tra comparti abiotici (acqua, sedimento) e biotici (reti trofiche) e tra livelli trofici; bioaccumulo e biomagnificazione e relativi fattori; e alla valutazione del rischio di tossicità (metodo dei TEF, TEQ) nelle reti trofiche marine, anche mediante l'uso di organismi sentinella, per valutare il rischio per la salute delle popolazioni e dell'ecosistema.
Promuove lo studio di specie protette o viventi in aree protette mediante l’uso di metodi di campionamento non-distruttivi e non-letali. Sviluppo ed ottimizzazione di metodi per la determinazione di contaminanti organici emergenti.
Ha partecipato a diverse spedizioni in Antartide nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide e a spedizioni in Artide: Svalbard e Groenlandia quest’ultima nell'ambito di un progetto interazionale sugli effetti dei cambiamenti climatici sugli organismi artici (TUNU Programme: Arctic Ocean Fishes–Diversity, Adaptation and Conservation’’ UiT The Arctic University of Norway).
Scopus - Author ID: 7801563492 ![]() http://orcid.org/0000-0002-1875-6530 Google Scholar
http://orcid.org/0000-0002-1875-6530 Google Scholar
The Arctic Science Summit Week 2021, 19-25 March 2021 Lisboa - Portugal
 Framed by the overarching theme for the Science Conference The Arctic: Regional Changes, Global Impacts, Lisbon invites International experts on the Arctic and Indigenous Peoples to discuss the “New Arctic” and also its impacts and interactions to and with the lower latitudes.
Framed by the overarching theme for the Science Conference The Arctic: Regional Changes, Global Impacts, Lisbon invites International experts on the Arctic and Indigenous Peoples to discuss the “New Arctic” and also its impacts and interactions to and with the lower latitudes.
ASSW2021 Site
Arctic Science Summit Week 2020 Akureyri, Iceland | 27 March - 2 April 2020
 Convened by the International Arctic Science Committee (IASC)
Convened by the International Arctic Science Committee (IASC)
Hosted by the Icelandic Centre for Research and the University of Akureyri
ASSW2020 Site
Beyond EPICA Oldest Ice Core

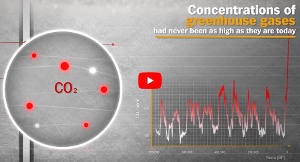 Com'era il clima più di 800.000 anni fa? Grazie al progetto OldestIce i ricercatori stanno ricostruendo la storia del clima del nostro pianeta con l’analisi del ghiaccio in Antartide. Il progetto è finanziato dall’Unione Europea. Intervista a Carlo Barbante, coordinatore del progetto. Il 1° giugno 2019 ha preso ufficialmente avvio Beyond EPICA Oldest Ice Core, finanziato dal programma di ricerca europeo Horizon 2020. Comunicato stampa CNR
Com'era il clima più di 800.000 anni fa? Grazie al progetto OldestIce i ricercatori stanno ricostruendo la storia del clima del nostro pianeta con l’analisi del ghiaccio in Antartide. Il progetto è finanziato dall’Unione Europea. Intervista a Carlo Barbante, coordinatore del progetto. Il 1° giugno 2019 ha preso ufficialmente avvio Beyond EPICA Oldest Ice Core, finanziato dal programma di ricerca europeo Horizon 2020. Comunicato stampa CNR
AGGIORNAMENTO (Settembre 2020): Annullata la campagna Beyond EPICA 2020/21
A causa delle restrizioni dovute al Covid-19, la campagna 2020/21 di Beyond EPICA è stata cancellata. La nostra priorità è mantenere l'Antartide libera dal SARS-Cov-2 virus e rendere la realizzazione del progetto la più sicura possibile. Tutte le attività in campo in Antartide saranno ridotte di un terzo e per questo motivo sarà data priorità alle attività di rifornimento della stazione Concordia e lo scambio del team per la campagna invernale. Il team Beyond EPICA tornerà al campo di Little Dome C nel 2021.
Rappazzo Alessandro Ciro
 Attualmente Collaboratore Tecnico (VI livello) a tempo determinato (dal luglio 2023) nell’ambito del progetto PNRR EMBRC Unlocking the Potential for Health and Food from the seas – EMBRC-UP. Dal 2021 è anche studente del Dottorato in Scienze Polari presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Nel 2014 ha ottenuto la Laurea in Biologia ed Ecologia dell’Ambiente Marino Costiero presso l’Università degli Studi di Messina, con la tesi dal titolo Tolleranza ai metalli pesanti e policlorobifenili in batteri artici (Norvegia Continentale). Durante la preparazione della tesi di laurea ha trascorso 4 mesi presso l’Università di Valencia (Spagna) per acquisire nuove tecniche di laboratorio. Ha partecipato a diverse attività di campionamento in Artide, Antartide e Mediterraneo per il prelievo e il trattamento di campioni per studi microbiologici. In particolare, l’interesse di ricerca è rivolto allo studio delle popolazioni microbiche in ambienti acquatici (mare, acqua dolce e brine iperaline), sedimenti e permafrost. Tra le tecniche adoperate: stima della biomassa procariotica mediante conteggio e analisi morfometrica e morfologica, tramite l’applicazione di tecniche microscopiche in epifluoresenza ed analisi d’immagine; analisi della comunità procariotica mediante CARD-FISH e next generation sequencing; stima dei profili fisiologici dei procarioti a livello di comunità mediante BIOLOG Ecoplate; quantificazione di cellule vitali mediante l’uso di biomarkers (LIVE/DEAD e CTC); screening di batteri per la capacità di degradare composti organici inquinanti. È autore o coautore di circa 25 articoli su riviste internazionali.
Attualmente Collaboratore Tecnico (VI livello) a tempo determinato (dal luglio 2023) nell’ambito del progetto PNRR EMBRC Unlocking the Potential for Health and Food from the seas – EMBRC-UP. Dal 2021 è anche studente del Dottorato in Scienze Polari presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Nel 2014 ha ottenuto la Laurea in Biologia ed Ecologia dell’Ambiente Marino Costiero presso l’Università degli Studi di Messina, con la tesi dal titolo Tolleranza ai metalli pesanti e policlorobifenili in batteri artici (Norvegia Continentale). Durante la preparazione della tesi di laurea ha trascorso 4 mesi presso l’Università di Valencia (Spagna) per acquisire nuove tecniche di laboratorio. Ha partecipato a diverse attività di campionamento in Artide, Antartide e Mediterraneo per il prelievo e il trattamento di campioni per studi microbiologici. In particolare, l’interesse di ricerca è rivolto allo studio delle popolazioni microbiche in ambienti acquatici (mare, acqua dolce e brine iperaline), sedimenti e permafrost. Tra le tecniche adoperate: stima della biomassa procariotica mediante conteggio e analisi morfometrica e morfologica, tramite l’applicazione di tecniche microscopiche in epifluoresenza ed analisi d’immagine; analisi della comunità procariotica mediante CARD-FISH e next generation sequencing; stima dei profili fisiologici dei procarioti a livello di comunità mediante BIOLOG Ecoplate; quantificazione di cellule vitali mediante l’uso di biomarkers (LIVE/DEAD e CTC); screening di batteri per la capacità di degradare composti organici inquinanti. È autore o coautore di circa 25 articoli su riviste internazionali.
Papale Maria
 Nata a Messina, ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Ambientali presso l'Università di Messina (2016) presentando la tesi dal titolo PCB-oxidising bacteria from Arctic and Antarctic environments. Membro del gruppo eLTER H2020 Starting Communities project e del gruppo Association of Polar Early Career scientists APECS.
Nata a Messina, ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Ambientali presso l'Università di Messina (2016) presentando la tesi dal titolo PCB-oxidising bacteria from Arctic and Antarctic environments. Membro del gruppo eLTER H2020 Starting Communities project e del gruppo Association of Polar Early Career scientists APECS.
Attualmente, sta coordinando il progetto PNRA18_00194 Microbial response to human Pollutants in polAr lakeS - MicroPolArS ed il progetto INTERACT Mercury concentration and tolerant microorganisms in Arctic SNOW: new Bioremediation chALLenges – SNOW BALL. Partecipa attivamente a progetti di ricerca nazionali ed internazionali su tematiche inerenti l’ecologia e le biotecnologie microbiche in ambienti polari. Particolare interesse è rivolto all’uso di strumenti molecolari per lo studio della biodiversità e della funzionalità delle comunità microbiche, con attenzione alla capacità di degradare composti inquinanti. Nell’ambito di progetti focalizzati sulla microbiologia in ambienti polari, ha partecipato a campagne di prelievo in Artico e Antartide, nonché a crociere oceanografiche in Mediterraneo.
È specializzata in: trattamento di campioni microbiologici di diversa origine; uso di strumenti molecolari per la biodiversità batterica e l'ibridazione di sonde DNA/RNA; analisi delle comunità microbiche (metagenomica) mediante sequenziamento di nuova generazione; espressione differenziale e validazione statistica dei dati RNA-seq; stima della biomassa microbica; screening di batteri per la produzione di molecole di interesse biotecnologico e per la capacità di degradare composti inquinanti. Ha avuto modo di perfezionare le proprie competenze bioinformatiche e di laboratorio anche grazie e numerosi soggiorni trascorsi in istituti stranieri tra cui il Sequentia biotech (Barcellona, Spagna), l'Università di Jyvaskyla (Finlandia) e l'Università di Valencia (Spagna). È autrice o coautrice di numerosi articoli su riviste peer-reviewed, tra cui Scientific Reports, Science of the Total Environment, Soil Biology and Biochemistry, PLOS One, Applied and Environmental Microbiology, Microbial Ecology, e più di 30 comunicazioni a congressi nazionali e internazionali.
![]() http://orcid.org/0000-0002-6013-4436 Research Gate
http://orcid.org/0000-0002-6013-4436 Research Gate
ARTICO - Ministro dell'Ambiente in visita alla base di ricerca CNR Dirigibile Italia - Isole Svalbard - 23-24 Febbraio 2020
 26 Febbraio 2020
26 Febbraio 2020
Due giorni con il Cnr alle Isole Svalbard. Con il ministro, anche Fabio Trincardi direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terrestre e Tecnologie ambientali, il direttore f.f. dell’Istituto di Scienze Polari (CNR-ISP) Leonardo Langone e il neo Direttore, sempre del (CNR-ISP), Carlo Barbante.
ANTARTIDE - Aggiornamento sulle attività nella base Concordia e Mario Zucchelli
 26 Febbraio 2020
26 Febbraio 2020
Iniziata nella stazione di ricerca italo-francese Concordia (DOME C) la 16a campagna invernale del Pnra e terminate le normali attività di ricerca della 35a campagna estiva del Pnra presso la stazione costiera italiana Mario Zucchelli.
Comunicato stampa CNR
Zangrando Roberta
 Dal 2011 è ricercatrice presso l'IDPA-CNR di Venezia. Da giugno 2019 lavora all'ISP-CNR con sede a Venezia.
Dal 2011 è ricercatrice presso l'IDPA-CNR di Venezia. Da giugno 2019 lavora all'ISP-CNR con sede a Venezia.
I suoi interessi di ricerca includono: la creazione di nuovi metodi analitici utilizzando HRGC-LRMS, HRGC-HRMS, HPLC-HRMS e HPLC-MS / MS per la determinazione di microinquinanti organici, traccianti e biomarker e caratterizzazione chimica della frazione organica delle matrici ambientali. La dott.ssa Zangrando partecipa attivamente ai progetti PNRA Antartico, Artico ed Europeo.
Venier Chiara
 Laurea in Scienze Ambientali (Università Ca’ Foscari Venezia), Dottorato di Ricerca in Scienze dell’Ingegneria Civile ed Ambientale (Università degli Studi di Padova).
Laurea in Scienze Ambientali (Università Ca’ Foscari Venezia), Dottorato di Ricerca in Scienze dell’Ingegneria Civile ed Ambientale (Università degli Studi di Padova).
Posizione attuale: Tecnologa presso l’Istituto di Scienze Polari del CNR.
Precedentemente: Assegnista di Ricerca e Tecnologa presso l’Istituto di Scienze Marine del CNR (Venezia) 2014-2019; Short Term Mobility Grant presso Centre of Excellence for Environmental Decisions, Università del Queensland (Brisbane, Australia); ha frequentato corsi e master in europrogettazione 2012-2014; Assegnista di Ricerca presso Università Ca’ Foscari Venezia 2012-2014; collaboratrice presso ARPAV Settore Acque (Padova) 2011; ricercatrice user per attività sperimentali presso Total Environment Simulator Facility (University of Hull, GB) 2009; collaboratrice presso Centro Internazionale di Idrologia Dino Tonini (Università degli Studi di Padova) 2006-2007; Internship Grant presso Portland State University (Portland, Oregon) 2006 e presso Scripps Institution of Oceanography (San Diego, California) 2005.
Attualmente coinvolta, come project manager, nel progetto europeo H2020 Beyond EPICA Oldest Ice Core: 1,5 Myr of greenhouse gas –climate feedbacks. Attività di ricerca sul tema del bilancio di massa delle calotte polari, incluse analisi geospaziali su dati di osservazione della terra.
Precedentemente, attività di ricerca e supporto alla ricerca nell’ambito della Pianificazione dello Spazio Marittimo (MSP). In particolare, gestione di dati geospaziali ed implementazione di strumenti e software di supporto alle decisioni. Competenza specifica sull’implementazione del software Marxan per la prioritizzazione spaziale di scenari multi-obiettivo. Inoltre, analisi geospaziale per la selezione di siti di acquacoltura, analisi dei servizi ecosistemici per la MSP, degli impatti cumulativi e dei conflitti tra gli usi antropici. Coinvolta in diversi progetti nazionali e internazionali con interesse anche agli aspetti science to policy. ORCID https://orcid.org/0000-0001-6880-2745
Scopus - Author ID: 54928529600 ![]() http://orcid.org/0000-0001-6880-2745
http://orcid.org/0000-0001-6880-2745
Vardè Massimiliano
 Nato a Vibo Valentia. Attualmente Ricercatore (tempo indeterminato) presso l’Istituto di Scienze Polari del CNR sede di Venezia da giugno 2019.
Nato a Vibo Valentia. Attualmente Ricercatore (tempo indeterminato) presso l’Istituto di Scienze Polari del CNR sede di Venezia da giugno 2019.
- Laurea in Chimica,
- Master di II livello presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica
- Scuola di Dottorato in Ingegneria Chimica, Ambientale e della Sicurezza (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”), e Scuola di Dottorato in Scienze Chimiche presso l’Università di Ferrara dove ha conseguito il Dottorato di Ricerca.
Ha insegnato Chimica Generale e Inorganica, e Chimica Organica presso l’Università di Roma “La Sapienza” come Professore a contratto (2008-2019).
Precedentemente ha svolto attività di ricerca presso:
- Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali (CNR-IDPA) sede di Venezia,
- Istituto sull’Inquinamento Atmosferico (CNR-IIA) sede di Montelibretti (Roma), e successivamente sede di Rende (Cosenza),
- Istituto di Igiene “G. Sanarelli”/Dipartimento di Sanità Pubblica (Università di Roma “La Sapienza”).
Ha collaborato con differenti gruppi di ricerca in Italia e all'estero, sviluppando e ottimizzando strategie di campionamento attivo e passivo in atmosfera e metodi chimico-analitici per la determinazione di macro-elementi e microinquinanti organici e inorganici (Diossine, Furani, Policlorobifenili, Idrocarburi policiclici aromatici, Composti organici volatili e metalli pesanti). Ha utilizzato metodi cromatografici su matrici come emissioni industriali, aria ambiente, particolato atmosferico, deposizioni atmosferiche e acque (di mare e naturali).
I suoi interessi si sono focalizzati sulla quantificazione a bassi livelli di concentrazione dei contaminanti, studiando il loro trasporto, la dinamica, il destino e gli impatti ambientali, in aree urbane, rurali e remote. Negli ultimi anni si è concentrato sulla determinazione del mercurio a livelli di ultra-traccia usando tecniche di fluorescenza atomica, in atmosfera, nelle deposizioni atmosferiche, e nelle acque. Nell’ambito del progetto Global Mercury Observation System (GMOS) coordinato dal CNR-IIA, è stato responsabile delle misure del mercurio nelle deposizioni atmosferiche.
Al CNR-ISP, è membro del gruppo di lavoro per la gestione della logistica e delle attività di ricerca presso l'osservatorio di alta quota di Col Margherita (MRG) nelle Alpi orientali (Dolomiti Bellunesi), stazione all'interno del progetto iGosp (Integrated Global Observing Systems for Persistent Pollutants, del programma europeo ERA-PLANET (2017-2020). Ha preso parte a numerose campagne di misure in Italia e all’estero, ad una campagna oceanografica (Med-Oceanor) nel Mar Mediterraneo a bordo della nave oceanografica Urania come Capo-Missione e alle attività di ricerca (progetto iCUPE - Integrative and Comprehensive Understanding on Polar Environments) presso la Stazione Artica “Dirigibile Italia” del CNR come “Acting Station Leader” e “Field Scientist” a Ny Ålesund, isole Svalbard (Norvegia) (4 spedizioni, 2018-2022).
Per il triennio 2022-2025, è stato eletto come RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) e come RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) per gli Istituti di Ricerca CNR del territorio di Venezia.
Pubblicazioni Google Scholar Research gate
Lodi Rachele
 Laurea magistrale con lode in Geologia Applicata e Ambientale presso l'Università di Torino nel 2010, con una tesi dal titolo Distribuzione, origine e conseguenze del contenuto di fluoruro nelle acque sotterranee in un'area del settore centrale del Rift etiopico.
Laurea magistrale con lode in Geologia Applicata e Ambientale presso l'Università di Torino nel 2010, con una tesi dal titolo Distribuzione, origine e conseguenze del contenuto di fluoruro nelle acque sotterranee in un'area del settore centrale del Rift etiopico.
Si è specializzata nella raccolta, analisi e diffusione di dati nei paesi in via di sviluppo e nella mappatura e modellizzazione geologica e idrogeologica attraverso la gestione dei dati GIS. L'esperienza di lavoro in ambiente alpino ha permesso l'approfondimento in tematiche pedologiche e geochimiche. Asegnista di ricerca presso l’Istituto di Scienze Polari del CNR (ISP-CNR) con sede a Venezia; ha lavorato al progetto Nunataryuk (Horizon 2020), coordinato dall'Alfred Wegener Institute, con lo scopo di valutare le conseguenze del disgelo del permafrost artico e di studiare come questo contribuisca al cambiamento climatico.
Posizione attuale: dottoranda di ricerca presso Università Ca' Foscari Venezia, dottorato in Scienze Polari; titolo del progetto presentato: Modelling the fate of POPs distribution in permafrost: combine large scale to local perspective.
Dreossi Giuliano
 Laureato in Scienze Ambientali (laurea triennale: Università degli Studi di Milano-Bicocca, laurea specialistica: Università degli Studi di Trieste). Dottorato in Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici presso l’Università Ca’ Foscari Venezia.
Laureato in Scienze Ambientali (laurea triennale: Università degli Studi di Milano-Bicocca, laurea specialistica: Università degli Studi di Trieste). Dottorato in Scienza e Gestione dei Cambiamenti Climatici presso l’Università Ca’ Foscari Venezia.
Posizione attuale: ricercatore a tempo determinato presso Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISP) con sede a Venezia. Precedentemente assegnista di ricerca e collaboratore occasione presso il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università degli Studi di Trieste, assegnista presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia, assegnista presso IDPA-CNR (in seguito ISP-CNR) e borsista presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia su progetto InterReg Italia-Slovenia ACQUAVITIS.
Principal Investigator del progetto PNRA 2018 WHETSTONE sulle precipitazioni giornaliere raccolte a Dome C, Antartide.
Collaboratore della prof.ssa Barbara Stenni da oltre un decennio e più di recente anche del dott. Mauro Masiol, si occupa di geochimica isotopica delle molecole d’acqua, applicata a carote di ghiaccio polari e Alpine per ricostruzioni paleclimatiche, alle precipitazioni raccolte in Antartide, alle precipitazioni locali della regione Veneto, del Friuli Venezia Giulia, della Slovenia e di altre zone, alle acque superficiali e profonde, alle acque di mare e alle acque di estrazione di piante e suoli.
Utilizza tecniche di spettrometria di massa IRMS (Isotope Ratio Mass Spectrometry) accoppiate a unità di equilibrazione HDO e GasBench e di Spettroscopia ad Assorbimento Laser accoppiata ad autocampionatore e vaporizzatore e a Induction Module per la determinazione della composizione isotopica dell’ossigeno e dell’idrogeno.
Ha partecipato al processamento della carota di ghiaccio alpina dell’Ortles (core #1) e della carota Antartica SolarIce presso la cella frigo dell’Università Ca’ Foscari/CNR Venezia e presso il laboratorio freddo EuroCold dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Scopus - Author ID: 57191615614
De Blasi Fabrizio
 Laurea magistrale in Scienze Forestali e Ambientali (Università degli Studi di Padova), dottorato di ricerca in Territorio, Ambiente, Risorse e Salute (Università degli Studi di Padova).
Laurea magistrale in Scienze Forestali e Ambientali (Università degli Studi di Padova), dottorato di ricerca in Territorio, Ambiente, Risorse e Salute (Università degli Studi di Padova).
Posizione attuale: Ricercatore presso l'Istituto di Scienze Polari del CNR, Venezia.
Dal 2010 svolge attività di ricerca nel campo delle scienze forestali e ambientali con particolare attenzione all’influenza dei cambiamenti climatici sugli ambienti montani d’alta quota dominati da processi nivo-glaciali. A seguito della laurea magistrale, si è concentrato sul settore geomorfologico, idrologico e glaciologico presso il dipartimento TESAF dell’Università di Padova. Ha analizzato le interazioni tra le variazioni climatiche dell’ultimo secolo (es modifiche del regime termo-pluviometrico) e i cambiamenti della criosfera alpina (es variazioni in volume, variazioni stagionali della copertura nevosa ecc.) nonché le conseguenze del riscaldamento globale sul regime idrologico e l’evoluzione delle masse glaciali nelle ultime migliaia di anni.
Negli ultimi anni ha collaborato a progetti di ricerca internazionali quali Ortles project (un progetto di ricerca paleoclimatico) e POLLiCE (analisi del polline presente su carote di ghiaccio alpine).
Attualmente svolge attività scientifica nell’analisi del clima negli ultimi 2000 anni attraverso lo studio delle carote di ghiaccio alpine e appenniniche. Dal 2017 fa parte del team italiano di Ice Memory (IM). IM è un progetto di ricerca internazionale che mira alla salvaguardia delle informazioni climatiche stoccate nei ghiacciai montani di tutto il mondo. Allo stesso tempo, collabora al progetto Osservatorio Atmosferico Col Margherita (MRG) con l'obiettivo di misurare la composizione atmosferica sopra i 2500 m nella regione dolomitica.
Scopus - Author ID: 56674114400
Dallo Federico
 Federico Dallo ha conseguito la Laurea Magistrale in Chimica (LM-54) presso l’Università di Ferrara nel 2013, specializzandosi in chimica teorica e computazionale sotto la supervisione del Prof. Celestino Angeli. Nel 2017 ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Scienze Ambientali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, focalizzandosi sulla diffusione di composti organici volatili nel manto nevoso sotto la guida del Prof. Carlo Barbante. Dal 2017 al 2020 è stato Assegnista di Ricerca presso CNR-IDPA/CNR-ISP, lavorando su tecnologie di monitoraggio ambientale a basso costo presso l’osservatorio meteoclimatico di Col Margherita in ambienti alpini e polari. Dal 2021 al 2023 è stato Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellow, conducendo ricerche su reti di sensori wireless in collaborazione con la University of California, Berkeley.
Federico Dallo ha conseguito la Laurea Magistrale in Chimica (LM-54) presso l’Università di Ferrara nel 2013, specializzandosi in chimica teorica e computazionale sotto la supervisione del Prof. Celestino Angeli. Nel 2017 ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Scienze Ambientali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, focalizzandosi sulla diffusione di composti organici volatili nel manto nevoso sotto la guida del Prof. Carlo Barbante. Dal 2017 al 2020 è stato Assegnista di Ricerca presso CNR-IDPA/CNR-ISP, lavorando su tecnologie di monitoraggio ambientale a basso costo presso l’osservatorio meteoclimatico di Col Margherita in ambienti alpini e polari. Dal 2021 al 2023 è stato Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellow, conducendo ricerche su reti di sensori wireless in collaborazione con la University of California, Berkeley.
Dal 2024, Federico è Ricercatore presso il CNR-ISP a Venezia, dove si occupa dello studio della relazione tra comportamento umano e rischi ambientali, con l’obiettivo di supportare le politiche pubbliche e gli interventi per la resilienza sociale e la salute pubblica.
Federico è ricercatore affiliato presso:
• the University of California, Berkeley
• the University of Sydney
Progetti di ricerca
• healthRiskAdapt (HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01)
• MISO (HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-07)
• PIONEER (MSCA-IF-2018)
LinkedIn:/federico-dallo-b351a582/
Montagna Paolo
 Dirigente di Ricerca presso CNR-ISP con sede a Bologna.
Dirigente di Ricerca presso CNR-ISP con sede a Bologna.
Laurea in Geologia (1999) e Dottorato in Scienze della Terra (2005) presso il Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova, in collaborazione con l’Australian National University.
L’attività di ricerca si concentra principalmente sullo sviluppo e l'applicazione di proxy geochimici per ricostruzioni paleoclimatiche e mira ad affrontare alcuni degli aspetti fondamentali dei meccanismi di biomineralizzazione degli organismi calcificatori (coralli di ambiente profondo, molluschi, alghe calcaree). In particolare, si occupa dell’analisi ed interpretazione degli elementi in traccia e degli isotopi stabili (11B/10B) e radiogenici (143Nd/144Nd, 87Sr/86Sr, 230Th/U) nei carbonati biogenici.
Ha lavorato per lunghi periodi presso diversi istituti stranieri (Australian Institute of Marine Sciences, Australian National University, Lamont-Doherty Earth Observatory, Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement, Università Parigi-Sud e University of Western Australia). Ha partecipato a 20 spedizioni oceanografiche nel Mar Mediterraneo, nell'Oceano Atlantico ed Indiano e nel Mare di Ross (in alcune come capo o co-capo missione) e ha svolto attività di campagna (SCUBA diving) nel Mediterraneo, nel Mar dei Caraibi e Mar Rosso, nell’Oceano Indiano e Pacifico. Autore o co-autore di oltre 90 articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali ISI, 4 capitoli di libro, oltre 120 abstract e 20 seminari ad invito. Ha lavorato come revisore per NSF-USA, ERC-Advanced Grants, ANR-Francia, CNRS/INSU-Francia, NSERC-Canada, FONDECYT-Cile, DFG-Germania, ISF-Israele, Czech Science Foundation, EUROFLEET Plus, Swiss National Science Foundation Eccellenza Professional Fellowship, SCOR WG e per 25 riviste scientifiche ISI.
![]() http://orcid.org/0000-0001-5598-2214 Google Scholar
http://orcid.org/0000-0001-5598-2214 Google Scholar
Miserocchi Stefano
 Laurea in Sc. Geologiche nel 1987 a Bologna. Ricercatore presso l’Istituto di Scienze Marine del CNR dal 1994 al 2019, si è occupato di ricerche biogeochimiche e sedimentologiche in ambiente marino e costiero. In organico al CNR-ISP con sede a Bologna.
Laurea in Sc. Geologiche nel 1987 a Bologna. Ricercatore presso l’Istituto di Scienze Marine del CNR dal 1994 al 2019, si è occupato di ricerche biogeochimiche e sedimentologiche in ambiente marino e costiero. In organico al CNR-ISP con sede a Bologna.
I suoi interessi di ricerca sono attualmente: (a) flussi verticali di particelle e trasporto laterale di materiali dalla piattaforma continentale a bacini profondi nell'Artico e nel Mar Mediterraneo; (b) Metodi di logging non distruttivi di carote di sedimento inclusa la scansione XRF.
Ha partecipato a progetti EU e artici (Snow, Arca, Defrost). PI e/o WP Leader di progetti finanziati da ONR-USA e progetti nazionali.
Ha partecipato a oltre 75 campagne oceanografiche (in 20 campagne come capomissione) tra il 1990 e il 2019 per un totale di 525 giorni di esperienza a bordo.
Autore e coautore di oltre 158 pubblicazioni (+ 120 abstract) inclusi data-report e rapporti tecnici, di cui 62 pubblicazioni su Scopus, 1513 citazioni, indice H = 23.
Scopus - Author ID: 6602827994 Google Scholar
Mazzola Mauro
 Si occupa principalmente di due tematiche di ricerca: la caratterizzazione fisica ed ottica del particolato atmosferico, altrimenti detto aerosol, e della stima del bilancio energetico alla superficie. Per quanto riguarda la prima tematica, si avvale di tecniche quali la fotometria solare e lunare per la stima dello spessore ottico degli aerosol in atmosfera, la misura in-situ dei coefficienti di diffusione e di assorbimento e della distribuzione dimensionale tramite strumentazione ottica online e la misura. Questo ultimo tipo di misura viene effettuata anche su profili ottenuti tramite pallone frenato. Per quanto riguarda il bilancio energetico, utilizza un approccio integrato tra misure e codici di calcolo per la parte radiativa, mentre i bilanci di calore e di massa vengono stimati da misure dirette tipo eddy covariance. Tali attività si svolgono principalmente presso le infrastrutture CNR a Ny-Ålesund (Svalbard) e presso la base Coreana Jang Bogo in Antartide, paese con in quale è attiva da anni una stretta collaborazione.
Si occupa principalmente di due tematiche di ricerca: la caratterizzazione fisica ed ottica del particolato atmosferico, altrimenti detto aerosol, e della stima del bilancio energetico alla superficie. Per quanto riguarda la prima tematica, si avvale di tecniche quali la fotometria solare e lunare per la stima dello spessore ottico degli aerosol in atmosfera, la misura in-situ dei coefficienti di diffusione e di assorbimento e della distribuzione dimensionale tramite strumentazione ottica online e la misura. Questo ultimo tipo di misura viene effettuata anche su profili ottenuti tramite pallone frenato. Per quanto riguarda il bilancio energetico, utilizza un approccio integrato tra misure e codici di calcolo per la parte radiativa, mentre i bilanci di calore e di massa vengono stimati da misure dirette tipo eddy covariance. Tali attività si svolgono principalmente presso le infrastrutture CNR a Ny-Ålesund (Svalbard) e presso la base Coreana Jang Bogo in Antartide, paese con in quale è attiva da anni una stretta collaborazione.
Autore di circa 100 pubblicazioni tra articoli su rivista e contributi in libri scientifici.
Scopus - Author ID: 24367405100 ![]() http://orcid.org/0000-0002-8394-2292 Google Scholar
http://orcid.org/0000-0002-8394-2292 Google Scholar
Lupi Angelo
 Le attività principali di Angelo Lupi sono state indirizzate nello studio delle proprietà ottiche dell'atmosfera, delle interazioni tra la radiazione ultravioletta, visibile e infrarossa con i componenti atmosferici; i suoi interessi di ricerca pertanto si sono rivolti:
Le attività principali di Angelo Lupi sono state indirizzate nello studio delle proprietà ottiche dell'atmosfera, delle interazioni tra la radiazione ultravioletta, visibile e infrarossa con i componenti atmosferici; i suoi interessi di ricerca pertanto si sono rivolti:
a) all'impatto che gli aerosol, i gas in traccia e le nuvole esercitano sul bilancio delle radiazioni del sistema Terra-atmosfera, concentrandosi in particolare sulla valutazione degli effetti radiativi diretti prodotti dall'aerosol,
b) sulla valutazione del bilancio di radiazione nelle aree polari,
c) sul ruolo che hanno gli aerosol e le nubi in queste regioni particolarmente sensibili.
L'attività scientifica è stata divisa tra la ricerca sperimentale (principalmente fotometria solare, valutazioni del bilancio di radiazione in superficie, sia per il flusso solare sia per il flusso atmosferico/terrestre nell’infrarosso, e le proprietà ottiche e fisiche degli aerosol) e la modellizzazione utilizzando i codici di trasporto radiativi per la valutazione dei flussi radiativi nell'atmosfera.
Negli ultimi anni ha partecipato a molteplici campagne polari antartiche, acquisendo esperienza nella strumentazione e nell'analisi dei dati. È coautore di oltre 50 articoli su riviste internazionali.
Scopus - Author ID: 7005284903 ![]() http://orcid.org/0000-0002-5009-9876
http://orcid.org/0000-0002-5009-9876
Langone Leonardo
 Dirigente di Ricerca presso CNR-ISP.
Dirigente di Ricerca presso CNR-ISP.
È interessato alla determinazione della velocità dei processi acquatici che coinvolgono le particelle sedimentarie utilizzando traccianti radioattivi e trappole automatiche di sedimento. La dinamica delle particelle è poi applicata a diversi campi di indagine legati allo studio degli effetti del cambiamento climatico e dell’impatto antropico sull’ambiente marino e polare, quali ad esempio:
(a) i cicli biogeochimici del carbonio organico e della silice biogenica nell'Oceano Antartico, nello Stretto di Fram e nel Mar Mediterraneo per verificare se l’efficienza della pompa biologica stia diminuendo;
(b) ricostruzioni paleoceanografiche tardo Quaternarie che utilizzano componenti biogeniche e radionuclidi per lo studio della variabilità climatica naturale e indotta dalle attività umane;
(c) stime del tasso di crescita della CO2 atmosferica nelle regioni oceaniche remote e polari per validare con misure dirette i dati da satellite;
(d) il trasporto di particelle mediante cascading di acque dense dalla piattaforma continentale verso gli ecosistemi marini profondi, e come questo stia cambiando per effetto di una minore produzione di acqua densa e maggiore stratificazione della colonna d’acqua;
(e) la ricostruzione storica dell'inquinamento dei sedimenti di ambienti lacustri e costieri sia in aree altamente antropizzate che in aree polari remote.
Ha partecipato a progetti nazionali e della Commissione Europea. È stato PI di progetti finanziati da industria e ONR. PI o WP leader di progetti in Antartide e Artide. È il punto di contatto CNR per EU-ARICE e INTERACT III. Ha 30 anni di esperienza in campagne oceanografiche con 90 imbarchi (18 come capo missione) in Mediterraneo, Atlantico, Oceano Meridionale e Oceano Artico.
Coordinatore scientifico delle attività marine durante 2 spedizioni italiane in Antartide.
È autore/co-autore di ca. 100 articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali ISI, 60 articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali o internazionali non ISI, 7 capitoli di libri, 30 rapporti tecnici o report di campagna. Il numero delle citazioni ricevute ammonta a ca.2500, con un h-factor di 27 (fonte Scopus).
Scopus - Author ID: 6603776561 Research Gate Google Scholar
La Mesa Mario
 Laurea con lode in Scienze Biologiche (1990), presso la II Università di Roma.
Laurea con lode in Scienze Biologiche (1990), presso la II Università di Roma.
Dal 2001 al 2019 è stato ricercatore a tempo indeterminato presso l’Istituto di Scienze Marine.
È attualmente ricercatore dell’Istituto di Scienze Polari del CNR presso la sede di Bologna. Si occupa di aspetti legati alla determinazione dell’età tramite analisi delle otoltiti, alla riproduzione ed ai regimi trofici di specie ittiche mediterranee ed antartiche, prendendo parte a progetti di ricerca finanziati dalla Comunità Europea, dal MIUR e dal PNRA. Collabora da anni con partner stranieri su tematiche polari, avendo partecipato a diverse spedizioni scientifiche internazionali in Antartide (USA e Germania).
É autore/coautore di circa 100 pubblicazioni su riviste internazionali (JCR).
Scopus - Author ID: 6701474004 ![]() http://orcid.org/0000-0002-3716-0054 Research Gate Google Scholar
http://orcid.org/0000-0002-3716-0054 Research Gate Google Scholar
Turetta Clara
 Laurea in Scienze Geologiche (Università di Padova).
Laurea in Scienze Geologiche (Università di Padova).
Posizione attuale: Ricercatore presso Istituto di Scienze Polari del CNR, Venezia.
In precedenza: Ricercatore presso Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali – CNR; borsa di studio presso Università Ca’ Foscari di Venezia; assegnista di ricerca presso “Institut de Biogeochimie Marine” - ENS – CNRS, France.
Si occupa di elementi in traccia in matrici reali (acque, particolato, sedimenti, aerosol, neve e ghiaccio) mediante spettrometria di massa a settore magnetico (ICP-SFMS) e a quadrupolo (CRC-ICP-MS); isotopi stabili (δD, δ13C, δ15N, δ18O) in acqua marina, neve/ghiaccio suoli e sedimenti mediante spettrometro di massa (IRMS). Caratterizzazione geochimica di masse d’acqua oceaniche; uso di terre rare come traccianti geochimici in sistemi naturali: in neve e ghiaccio per ricostruzioni paleoclimatiche, in aerosol come traccianti di aree sorgente. Valutazione chemiometrica dei dati.
Progetti di ricerca:
- Horizon2020: “Beyond Epica (2019-2025) - Beyond EPICA Oldest Ice Core: 1,5 Myr of greenhouse gas – climate feedbacks” – Ricercatore e membro del Management Support Team;
- PNRA (2017-2020): “EvASIon - Mercer and Whillans lakes: Evolution of hydrologically Active Subglacial environments” – Project Leader;
- PNRA (2012-2014): CaBiLA- Geochemical characterization of antarctic subglacial lakes) – Project Leader;
- Progetto Premiale ARCA: Arctic - present Climatic change and pAst extreme events;
- Regione Veneto: Q-ALiVe - Quality of Venetian Littoral Environment – Project Leader;
- PRIN15 (2017-2020): RESACC - Risposte di ecosistemi sensibili alpini ai cambiamenti climatici;
- PRIN09 (2012-2013): Arctica, referente per WP4.
Ha partecipato a campagne oceanografiche anche in regioni polari (2001 R/V Italica; 2005-2006 R/V Italica: responsabile di progetto). L’attività di ricerca è comprovata da più di 60 articoli su riviste internazionali (peer review) e 160 abstracts di comunicazioni/poster a congresso.
Profilo CNR People
Scopus - Author ID: 6602486850 ![]() http://orcid.org/0000-0003-3130-2901 WoS Researcher ID: O-2849-2015 Research Gate: Clara Turetta
http://orcid.org/0000-0003-3130-2901 WoS Researcher ID: O-2849-2015 Research Gate: Clara Turetta
Cester Valentina
 Diploma di maturità tecnico-turistica. Dal 1992 al 1998 attività di supporto alla ricerca presso l’Università Ca’ Foscari, Dipartimento di Scienze Ambientali, con contratti di lavoro occasionale, coordinato e continuativo e a tempo determinato. Dal 1998 assunta con contratto a tempo indeterminato presso l’Università Ca’ Foscari, Dipartimento di Scienze Ambientali, ricoprendo un posto da tecnico assegnato per Convenzione all'Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali del CNR (IDPA), già Centro di Studio sulla Chimica e le Tecnologie per l'Ambiente. Dal 1° novembre 2011 dipendente CNR (a seguito mobilità tra enti) presso l’Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali (IDPA), profilo C.T.E.R. - VI livello. Dal 2004 al 2019 assume il ruolo di Segretario amministrativo di IDPA. Da giugno 2019 passa all’Istituto di Scienze Polari (ISP) dove ricopre il ruolo di Segretario amministrativo.
Diploma di maturità tecnico-turistica. Dal 1992 al 1998 attività di supporto alla ricerca presso l’Università Ca’ Foscari, Dipartimento di Scienze Ambientali, con contratti di lavoro occasionale, coordinato e continuativo e a tempo determinato. Dal 1998 assunta con contratto a tempo indeterminato presso l’Università Ca’ Foscari, Dipartimento di Scienze Ambientali, ricoprendo un posto da tecnico assegnato per Convenzione all'Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali del CNR (IDPA), già Centro di Studio sulla Chimica e le Tecnologie per l'Ambiente. Dal 1° novembre 2011 dipendente CNR (a seguito mobilità tra enti) presso l’Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali (IDPA), profilo C.T.E.R. - VI livello. Dal 2004 al 2019 assume il ruolo di Segretario amministrativo di IDPA. Da giugno 2019 passa all’Istituto di Scienze Polari (ISP) dove ricopre il ruolo di Segretario amministrativo.
Nei primi anni di attività Valentina Cester si è occupata della parte logistica delle spedizioni in Antartide relativamente alle attività dei ricercatori afferenti sia a IDPA che al gruppo di Chimica Analitica Ambientale dell’Università Ca’ Foscari. Ha inoltre avuto parte attiva nell’organizzazione dei Convegni Nazionali del Settore Contaminazione Ambientale-PNRA.
Concordia
La Stazione Concordia (75°06’ S, 123°21’ E) è situata sul plateau antartico, a 3.233 m slm nel sito denominato Dome C, e dista oltre 1000 km dalla costa.
La costruzione della stazione, sostenuta da un accordo intergovernativo tra Italia e Francia e frutto della collaborazione tra il PNRA e l'Istituto polare francese Paul Émile Victor (IPEV), si è conclusa nel 2005. Da allora, Concordia è una stazione permanente gestita congiuntamente da PNRA e IPEV nell'ambito dei rispettivi programmi polari.
Per maggiori informazioni visita il sito web www.pnra.aq.
Mario Zucchelli
La Stazione Mario Zucchelli (MZS) è situata a 74°42’ S e 164°07’ E, ad una quota di 15 m slm su un promontorio granitico nella Baia di Terranova (Mare di Ross - Antartide).
La stazione è stata intitolata alla memoria dell’ing. Mario Zucchelli che per sedici anni ha guidato l'Unità di ENEA per l'Antartide (ENEA-UTA). La stazione, attiva dal 1985 ma operativa solo durante l’estate australe, sostiene tutte le attività di ricerca del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA).
Per maggiori informazioni visita il sito www.pnra.aq
Dirigibile Italia
Portale di gestione: dirigibileitalia.isp.cnr.it
Dirigibile Italia è una stazione di ricerca multidisciplinare del CNR, fornisce supporto a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali. La stazione, inaugurata nel 1997, è situata nel villaggio di Ny-Ålesund (78°55' N, 11°56' E), sull’Isola di Spitsbergen, nell’arcipelago delle Svalbard, da cui partì nel 1928 la spedizione polare del Generale Umberto Nobile e in onore della quale fu chiamata Dirigibile Italia. La gestione della stazione, in passato a carico del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente (DSSTTA), è stata assegnata all’Istituto di Scienze Polari.
La stazione partecipa ai programmi di accesso di INTERACT e SIOS, rendendo disponibile i suoi spazi e i suoi mezzi per l’implementazione di progetti di ricercatori appartenenti a paesi che non hanno accesso all’artico.
Inoltre è inserita nel forum degli operatori artici FARO al fine di condividere la propria esperienza organizzativa con altri soggetti di altri paesi.
Dirigibile Italia è una struttura di 323 m2, 170 dei quali sono utilizzati come laboratori e uffici; può ospitare fino a 7 persone.
La base è aperta durante tutto l’anno per fornire supporto ad attività di ricerca.
Tra i servizi che la base mette a disposizione ci sono:
• 6 posti letto per il personale;
• un laboratorio di chimica attrezzato con una cappa a flusso laminare ed una aspirante, una bilancia di precisione, erogatore di acqua ultrapura, freezer e altro;
• diversi spazi per lavorazioni generiche;
• un laboratorio di elettronica e meccanica attrezzato;
• uno spazio magazzino interno per la conservazione del materiale;
• 3 motoslitte per gli spostamenti invernali e primaverili, fornite di carrelli per il trasporto di materiale, oltre che le tute, gli stivali ed i caschi necessari;
• 3 biciclette di tipo “fat-bike” con carrello per gli spostamenti estivi;
• 5 radio VHF per la comunicazione tra le persone in campo e per la loro sicurezza.
- Contatto: stationleader.arctic AT cnr.it
- Pagina Welcome della Stazione
- Pagina Facebook della Stazione di ricerca
- 1 Richiesta di collaborazione con la Stazione Artica Dirigibile Italia da parte di giornalisti-fotografi-documentaristi
- 2 Richiesta di visita presso la Stazione Artica Dirigibile Italia da parte di giornalisti-fotografi-documentaristi
- 3 Richiesta di collegamento con la Stazione Artica Dirigibile Italia da parte delle scuole
Stazioni di ricerca
La maggior parte della attività scientifica dei ricercatori dell’Istituto di Scienze Polari si avvale di tre basi scientifiche permanenti situate nelle aree polari: la Stazione Dirigibile Italia (SDI) alle Svalbard in Artico; le stazioni Mario Zucchelli (MZS) e Concordia in Antartide, rispettivamente nella Baia di Terranova Dome C sul Plateau antartico.
La Stazione Dirigibile Italia è gestita dal CNR-ISP, la Stazione Mario Zucchelli del PNRA è gestita dall’ENEA mentre la base Concordia, nata sulla base un accordo bilaterale italo-francese tra il PNRA (Italia) e l’IPEV (Francia), è gestita in condivisione tra ENEA e IPEV.
Laboratori
Le attività di ricerca si poggiano oltre che sulle stazioni e sugli osservatori anche su una rete di laboratori, situati presso le varie sedi dell'Istituto, che consentono ai ricercatori di sviluppare le tematiche proprie di ISP. Presso i laboratori vengono analizzati i campioni prelevati in aree polari, campioni che, viste le difficili condizioni ambientali in cui ci si trova ad operare durante le campagne, nonché il notevole sforzo logistico che la loro raccolta comporta, sono sempre preziosi e spesso irripetibili. Diventa dunque fondamentale la disponibilità di strumentazione che consenta al ricercatore di ricavare il massimo delle informazioni possibili da ogni campione ottenuto, al fine di avanzare nella conoscenza di questi ambienti estremi.
I laboratori effettuano anche servizio conto terzi e nell’ambito di contratti, convenzioni e collaborazioni di ricerca con società, università e istituzioni nazionali e internazionali. Per maggiori informazioni contattare i referenti dei laboratori/strumenti.
Osservatori
L’attività di ricerca polare ed in aree remote è supportata, oltre che da stazioni permanenti, anche da una serie di Osservatori, cioè da infrastrutture permanenti o semi-permanenti atte a consentire misure prolungate nel tempo e spesso automatizzate.
Fanno capo, a vario titolo, all’Istituto di Scienze Polari otto Osservatori: 6 in regioni polari, di cui 4 in ARTICO (Climate Change Tower, Gruvedabet e 2 Mooring: Kongfjorden e Storfjorden) e 2 in ANTARTIDE (Stazione BSRN e 1 Mooring: Mare di Ross), e 2 in regioni non polari, di cui 1 in regione di ALTA QUOTA (Col Margherita) e 1 in mare ADRIATICO (Ancoraggio Strumentato Permanente in Adriatico).
Rapporti annuali siti osservativi
Organismi Internazionali
Il CNR è presente in diversi organismi internazionali di coordinamento e di programmazione scientifica in Artico e in Antartide. Tra questi vanno citati l’International Arctic Science Committee (IASC), l’European Polar Board (EPB), il Forum of Arctic Research Operators (FARO), il Ny-Ålesund Scientific Managers Committee (NySMAC) e il Sustaining Arctic Observing Networks (SAON).
Inoltre, a seguito di trattati o adesioni ad accordi politici, il CNR supporta attivamente la presenza del nostro paese, con i propri esperti, in organismi, comitati e gruppi di lavoro scientifici. I ricercatori CNR partecipano ai lavori dei Gruppi di Lavoro e di Esperti dell’Arctic Council (AC). Per quanto riguarda l’Antartide il CNR è parte attiva nei diversi comitati permanenti dello Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR).
ISP infine è fortemente impegnato a garantire la partecipazione del CNR nella iniziativa SIOS (Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System) il cui scopo è quello di integrare, ottimizzare e coordinare, a livello internazionale, le risorse e le ricerche nell'arcipelago delle Svalbard.
In questo contesto Istituto di Scienze Polari (ISP) sostiene l’azione di rappresentanza del CNR negli organismi internazionali con la presenza di:
| Acronimo | Organismo | Nominativo | Incarico |
|---|---|---|---|
| Arctic Council - Arctic Contaminants Action Programme
Gruppo di Lavoro POPs e Mercurio |
Warren Cairns | Componente | |
| Arctic Council - Expert Group on Black Carbon and Methane | Stefania Gilardoni | Componente | |
| Arctic Council - Arctic Monitoring & Assessment Programme | Nicoletta Ademollo, Vito Vitale | Componenti | |
| Arctic Council - Arctic Monitoring & Assessment Programme
Gruppo di Lavoro Mercurio e POPs |
Warren Cairns | Componente | |
| Association of Polar Early Career Scientists Comitati Nazionali |
Andrea Spolaor | Componente | |
| Arctic Research Icebreaker Consortium | Leonardo Langone | Coordinatore per il CNR | |
| Marine Invasive Alien Species in Arctic Waters | Maurizio Azzaro | Delegato nazionale | |
| European Polar Board | Vito Vitale | Rappresentante per il CNR | |
| Forum of Arctic Research Operators | Mauro Mazzola | Rappresentante per l'Italia | |
| An International Study of the Marine Biogeochemical Cycles of Trace Elements and Isotopes | Paolo Montagna | Delegato nazionale | |
| International Arctic Science Committee | Carlo Barbante | Delegato nazionale | |
| International Arctic Science Committee
Gruppo di Lavoro sulla Criosfera |
Andrea Spolaor | Componente | |
| International Arctic Science Committee
Gruppo di Lavoro sul Mare |
Tommaso Tesi | Componente | |
| International Permafrost Association | Renato R. Colucci | Delegato nazionale | |
| Ny-Ålesund Science Managers Committee | Mauro Mazzola, Andrea Spolaor | Rappresentanti ad interim per l'Italia | |
| Sustaining Arctic Observing Networks | Vito Vitale | Componente | |
| Synoptic Arctic Survey Scientific Steering Committee | Maurizio Azzaro | Componente | |
| Scientific Committee on Antarctic Research
Input Pathways of Persistent Organic Pollutants to Antarctica |
Nicoletta Ademollo | Componente | |
| Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System
Board of Director |
Vito Vitale | Componente | |
| Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System
Research Infrastructure Coordination Committee |
Mauro Mazzola, Stefania Gilardoni | Componenti | |
| Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System
SIOS Data Management System Working Group |
Giulio Verazzo | Componente | |
| United Nations, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea,
World Ocean Assessment III |
Maurizio Azzaro | Expert |
The 25th International Symposium on Polar Sciences KOPRI - May 12-13, 2020
 The 26th International Symposium on Polar Sciences
The 26th International Symposium on Polar Sciences
Finding solutions to global issues: Polar science and technology
May 12-13, 2020 - Korea Polar Research Institute - Incheon, Republic of Korea
The 26th International Symposium on Polar Sciences organized by Korea Polar Research Institute (KOPRI) will be held on May 12-13, 2020 in Incheon, Republic of Korea. This symposium aims to bring polar scientists together to discuss their research findings and to promote international collaborative research.
KOPRI Site
Tessarin Elisa
 Diploma di maturità conseguito nel 1993 presso l’Istituto Tecnico Commerciale Paolo Sarpi di Venezia.
Diploma di maturità conseguito nel 1993 presso l’Istituto Tecnico Commerciale Paolo Sarpi di Venezia.
Da Febbraio 2002 a Ottobre 2005 ha svolto attività amministrativa presso Pago Italia Srl di Dosson (TV) occupandosi principalmente dell’emissione fatture attive e passive e dei pagamenti. Da Giugno 1999 a Febbraio 2002 è stata impiegata presso Cinquegrani Sas di Quarto d’Altino dove si è occupata di fatturazione clienti e fornitori, verifica dei pagamenti e relazioni con il pubblico. Da Giugno 1996 a Marzo 1999 ha svolto attività di front office presso la concessionaria VW Audi Pole Position SpA di Mestre, occupandosi inoltre di fatturazione clienti e prima nota cassa.
Dal 2005 al 2010 assunta presso l’Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali (IDPA) del CNR con contratto di lavoro a tempo determinato, profilo Collaboratore di Amministrazione-VII livello; dal 2010 assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali (IDPA) del CNR. Nel 2019 passaggio all’Istituto di Scienze Polari (ISP).
Durante gli anni di attività presso il CNR Elisa Tessarin si è principalmente occupata delle procedure relative agli ordinativi di spesa registrazione fatturazione, gestione presenze del personale attraverso strumenti informatici dedicati, organizzazione visite mediche per idoneità al lavoro, procedure di rimborso missioni (viaggi di lavoro) del personale, protocollo informatico ed è stata economo dell’Istituto.
Spolaor Andrea
 Si occupa principalmente di studi paleoclimatici e dei processi all’interfaccia fra neve ed atmosfera con particolare attenzione ai processi post-deposizionali. Si occupa di misure di elementi in tracce (e della loro speciazione) nelle carote di ghiaccio con un focus particolare al ferro, per il suo ruolo attivo nella fertilizzazione oceanica, ed alogeni per la loro dipendenza da processi collegati a variazioni del ghiaccio marino.
Si occupa principalmente di studi paleoclimatici e dei processi all’interfaccia fra neve ed atmosfera con particolare attenzione ai processi post-deposizionali. Si occupa di misure di elementi in tracce (e della loro speciazione) nelle carote di ghiaccio con un focus particolare al ferro, per il suo ruolo attivo nella fertilizzazione oceanica, ed alogeni per la loro dipendenza da processi collegati a variazioni del ghiaccio marino.
È interessato inoltre agli impatti causati dalle civiltà passate ed ai cambiamenti che queste hanno causato nella composizione chimica dell'atmosfera passata. È coinvolto in misure di aerosol in ambienti polari con il fine di studiare il ciclo biogeochimico di elementi in tracce, composti biogenici e black carbon e di valutare le possibili variazioni nel periodo recente. Ha partecipato a numerose spedizioni scientifiche polari, sia in Artide che in Antartide e in aree alpine. È inoltre coinvolto attivamente nella stima dei bilanci di massa in alcuni ghiacciai delle Svalbard.
Scopus - Author ID: 54962645400 ![]() http://orcid.org/0000-0001-8635-9193 ResearchGate Google Scholar
http://orcid.org/0000-0001-8635-9193 ResearchGate Google Scholar
Sartorato Ivan
 Laureato in Scienze Agrarie nel 1992. Ricercatore CNR presso l’Istituto di Scienze Polari, sede di Venezia-Mestre.
Laureato in Scienze Agrarie nel 1992. Ricercatore CNR presso l’Istituto di Scienze Polari, sede di Venezia-Mestre.
Dal 1996 al 2018 presso il Centro per la Biologia ed il controllo delle piante Infestanti, dal 2002 Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale (IBAF) e dal settembre 2018 Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (IRET) di Legnaro, Padova.
Macroaree CNR di riferimento: Terra e Ambiente, Agroalimentare Interessi di ricerca:
- ecofisiologia delle piante infestanti,
- modellizzazione della competizione tra malerbe e coltura e dell’intercettazione luminosa entro canopy,
- destino ambientale degli erbicidi.
Sintesi attività svolta e incarichi: Responsabile dal 2008 al 2016 dell’URT dell’IBAF: “Ecosistemi montani per la mitigazione dei cambiamenti ambientali in area alpina” presso il Centro Studi Alpini dell’Università della Tuscia a Cinte Tesino (TN). Membro del Management Committee dell’Azione COST E 47 (2005-2009): “European Network for Forest Vegetation Management: Towards Environmental Sustainability” del domain: Forests, their Products and Services. Refero per le riviste Applied Ecology, Weed Research, Int. J. of Biodiversity and Conservation, Spanish Journal of Agricultural Research, Journal of Testing and Evaluation.
Esperienze all’estero: Nel 1995 e nel 1997 ha trascorso due periodi all’estero presso la WUR (Wageningen University and Research, Paesi Bassi) per un totale di 6 mesi. Nel 2002 è stato visiting scientist per circa 4 mesi presso il Department of Botany and Plant Sciences, University of California, Riverside, CA, USA. Nel 2008 è stato visiting scientist per due mesi presso il Plant and Invertebrate Ecology Department, Rothamsted Research, UK.
Scopus - Author ID: 6507412824
Gregoris Elena
 Si occupa principalmente di messa a punto di metodi analitici per la determinazione di inquinanti organici, normati ed emergenti, in varie matrici ambientali. Tra le aree di interesse la qualità dell’aria, l’analisi di inquinanti in gascromatografia-spettrometria di massa, la determinazione di microplastiche, l’applicazione di tecniche statistiche per la valutazione delle sorgenti di inquinamento. Ha lavorato a diversi progetti europei, gestito collaborazioni per attività di ricerca anche con aziende private, è stata correlatore di diverse tesi. Ha studiato a Venezia, dove ha conseguito nel 2005 la laurea triennale in Chimica e nel 2007 la laurea specialistica in Chimica e Compatibilità Ambientale, entrambe a pieni voti. Nel 2011 ha conseguito il doppio titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Chimiche presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e di Scienze Biologiche, presso l'Universidade Estadual Paulista di Botucatu (San Paolo - Brasile). Durante il dottorato si è occupata principalmente di analisi di potere antiossidante in alimenti, tra i quali frutta e propoli. Tra il 2009 ed il 2010 ha passato un periodo di 6 mesi all'interno dell'Istituto di Bioscienze dell'Università di San Paolo, lavorando principalmente su frutti originari della zona tropicale del Brasile e scarsamente studiati fino ad allora. Dal 2012 al 2017 è stata assegnista di ricerca presso l'Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali (IDPA-CNR), nel 2017-2018 tecnologo di ricerca del progetto ECOMOBILITY presso Università Ca' Foscari Venezia e a partire da luglio 2019 ricercatore di III livello presso CNR-ISP.
Si occupa principalmente di messa a punto di metodi analitici per la determinazione di inquinanti organici, normati ed emergenti, in varie matrici ambientali. Tra le aree di interesse la qualità dell’aria, l’analisi di inquinanti in gascromatografia-spettrometria di massa, la determinazione di microplastiche, l’applicazione di tecniche statistiche per la valutazione delle sorgenti di inquinamento. Ha lavorato a diversi progetti europei, gestito collaborazioni per attività di ricerca anche con aziende private, è stata correlatore di diverse tesi. Ha studiato a Venezia, dove ha conseguito nel 2005 la laurea triennale in Chimica e nel 2007 la laurea specialistica in Chimica e Compatibilità Ambientale, entrambe a pieni voti. Nel 2011 ha conseguito il doppio titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Chimiche presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e di Scienze Biologiche, presso l'Universidade Estadual Paulista di Botucatu (San Paolo - Brasile). Durante il dottorato si è occupata principalmente di analisi di potere antiossidante in alimenti, tra i quali frutta e propoli. Tra il 2009 ed il 2010 ha passato un periodo di 6 mesi all'interno dell'Istituto di Bioscienze dell'Università di San Paolo, lavorando principalmente su frutti originari della zona tropicale del Brasile e scarsamente studiati fino ad allora. Dal 2012 al 2017 è stata assegnista di ricerca presso l'Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali (IDPA-CNR), nel 2017-2018 tecnologo di ricerca del progetto ECOMOBILITY presso Università Ca' Foscari Venezia e a partire da luglio 2019 ricercatore di III livello presso CNR-ISP.
Scopus - Author ID: 26649910100 ResearchGate Google Scholar
Gabrieli Jacopo
 Bellunese, ha studiato chimica all'Università di Padova ottenendo un dottorato in Scienze Ambientali alle Università di Venezia e di Grenoble.
Bellunese, ha studiato chimica all'Università di Padova ottenendo un dottorato in Scienze Ambientali alle Università di Venezia e di Grenoble.
Ricercatore presso l'Istituto di Scienze Polari del CNR, sede di Venezia, da anni si occupa dello studio di archivi climatici in carote di ghiaccio attraverso l’implementazione di tecniche analitiche innovative.
Montanaro per lavoro ma soprattutto per passione, ha partecipato ad importanti progetti di ricerca non solo sui ghiacciai Alpini, ma anche in Groenlandia, Antartide e Isole Svalbard.
Scopus - Author ID: 36007295400 ResearchGate
De Biasio Francesco
 Laureato in Fisica nel 1993, attualmente ricercatore presso l'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISP) sede di Venezia.
Laureato in Fisica nel 1993, attualmente ricercatore presso l'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISP) sede di Venezia.
Ha oltre 20 anni di esperienza nel campo della meteorologia marina su micro e meso scala, tramite utilizzo del telerilevamento con strumenti a microonde attivi in ambiente marino, da satellite e da piattaforme di osservazione durante campagne in mare (Mare Adriatico: torre Acqua Alta, piattaforme ENI; piattaforma di ricerca Kikeneiz sul Mar Nero). Analisi di serie storiche di dati meteo-marini acquisiti sia attraverso dati in situ che telerilevati. Co-autore di alcuni lavori sulla deduzione del vento all'interfaccia aria-mare tramite l'analisi di immagini SAR con tecniche wavelets continue.
Ha partecipato a:
1) progetto MIUR RITMARE occupandosi dell'acquisizione e della interpretazione di dati scatterometrici telerilevati per la determinazione del vento alla superficie del mare;
2) progetto ESA eSurge-Venice sull'espansione delle possibilità di utilizzo di dati satellitari per la previsione dello storm surge.
Più recentemente ha svolto ricerche nell'ambito dell'ESA Sea Level Climate Change Initiative (SL_CCI), nello svolgimento del progetto ESA SL_CCI Bridging Phase, occupandosi di applicazioni dell'altimetria satellitare.
Da febbraio 2020 partecipa al progetto ESA Radar Altimetry for the Coastal Zone and Inland Waters, che prevede lo sviluppo di specifiche applicazioni dell'altimetria satellitare SAR nelle zone costiere e nelle acque interne.
Responsabile scientifico di tre progetti di ricerca finanziati dal Centro Previsioni e Segnalazioni Maree (Comune di Venezia).
Principali interessi scientifici: telerilevamento a microonde dell'ambiente marino e interpretazione di immagini radar ad apertura sintetica; tecniche di trasformazione wavelet continua; analisi delle serie temporali di vento, livello del mare e radar backscatter; previsioni di storm surge; complementarietà di modellistica atmosferica e telerilevamento da satellite.
È autore o co-autore di più di 30 prodotti indicizzati (fonte Scopus) come articoli pubblicati su riviste internazionali o come atti di conferenze internazionali. La sua produzione scientifica può essere quantificata da un numero di citazioni pari a 242 e da un h-index pari a 9 (fonte Scopus).
Scopus - Author ID: 6603102453 ![]() http://orcid.org/0000-0002-6250-9588
http://orcid.org/0000-0002-6250-9588
Cozzi Giulio
 L'attività di ricerca scientifica svolta dal Dr. Cozzi, condotta presso l’Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Venezia, riguarda tematiche che rientrano nell'ambito della Chimica Analitica con particolare riferimento allo sviluppo di metodologie ed alle applicazioni di tipo ambientale. Gli studi sono stati rivolti in particolare alla messa a punto di metodologie analitiche per lo studio della contaminazione ambientale, causata dell'emissione nell'atmosfera di metalli tossici pesanti, attraverso l’analisi chimica di carote di neve e ghiaccio polari ed alpine, mediante la spettrometria di massa ad alta risoluzione con sistema di ionizzazione al plasma accoppiato induttivamente (ICP-SFMS). Oltre a questo tipo di matrici l’attività scientifica ha considerato particolari archivi di deposizione atmosferica come la torba che è stata studiata per la determinazione dei flussi atmosferici di elementi come arsenico ed antimonio. Le ricerche hanno anche riguardato lo studio della distribuzione di elementi in traccia in aree soggette a differente antropizzazione come l’Antartide, la Groenlandia e le Alpi.
L'attività di ricerca scientifica svolta dal Dr. Cozzi, condotta presso l’Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Venezia, riguarda tematiche che rientrano nell'ambito della Chimica Analitica con particolare riferimento allo sviluppo di metodologie ed alle applicazioni di tipo ambientale. Gli studi sono stati rivolti in particolare alla messa a punto di metodologie analitiche per lo studio della contaminazione ambientale, causata dell'emissione nell'atmosfera di metalli tossici pesanti, attraverso l’analisi chimica di carote di neve e ghiaccio polari ed alpine, mediante la spettrometria di massa ad alta risoluzione con sistema di ionizzazione al plasma accoppiato induttivamente (ICP-SFMS). Oltre a questo tipo di matrici l’attività scientifica ha considerato particolari archivi di deposizione atmosferica come la torba che è stata studiata per la determinazione dei flussi atmosferici di elementi come arsenico ed antimonio. Le ricerche hanno anche riguardato lo studio della distribuzione di elementi in traccia in aree soggette a differente antropizzazione come l’Antartide, la Groenlandia e le Alpi.
Scopus - Author ID: 35495278300 ![]() http://orcid.org/0000-0001-8796-4176 ResearchGate Google Scholar
http://orcid.org/0000-0001-8796-4176 ResearchGate Google Scholar
Corami Fabiana
 Ricercatrice. I suoi principali ambiti di ricerca riguardano la quantificazione e la simultanea identificazione di small microplastics (1-100 µm) in diverse matrici ambientali (permafrost, biota, sedimenti, ecc.) via MicroFTIR, quantificazione e identificazione di fibre microplastiche via MicroFTIR, speciazione di elementi in tracce in acque Antartiche, geospeciazione di elementi in tracce e terre rare (REEs) in sedimenti e suoli, bioaccumulo di elementi in tracce e REEs in penne, tecniche microscopiche e analisi ancillari.
Ricercatrice. I suoi principali ambiti di ricerca riguardano la quantificazione e la simultanea identificazione di small microplastics (1-100 µm) in diverse matrici ambientali (permafrost, biota, sedimenti, ecc.) via MicroFTIR, quantificazione e identificazione di fibre microplastiche via MicroFTIR, speciazione di elementi in tracce in acque Antartiche, geospeciazione di elementi in tracce e terre rare (REEs) in sedimenti e suoli, bioaccumulo di elementi in tracce e REEs in penne, tecniche microscopiche e analisi ancillari.
Autore di vari articoli scientifici pubblicate su riviste peer-review, ha partecipato a convegni nazionali ed internazionali ed è reviewer per riviste come STOTEN, Estuarne Coastal and Shelf Science, International Journal of Environmental Pollution and Remediation, Scientific Reports Nature.
Componente del Consiglio di Istituto (CdI), è inoltre rappresentante del CNR nell’assemblea dei soci del Distretto Veneziano per la Ricerca ed Innovazione (DVRI) ed è uno dei Leonardos per la Science Gallery Venice.
Scopus - Author ID: 7801412352
![]() http://orcid.org/0000-0002-7484-9600
ResearchGate
Google Scholar
http://orcid.org/0000-0002-7484-9600
ResearchGate
Google Scholar
Casula Marco
 CTER VI livello da Novembre 2014.
CTER VI livello da Novembre 2014.
Dal 2014 al 2018 ha lavorato come tecnico presso il CNR ISMAR Venezia partecipando a numerose campagne oceanografiche e occupandosi di reagentari, smaltimenti rifiuti, ordini di materiale e sicurezza nei laboratori.
Dal 2019 afferisce all'Istituto di Scienze Polari del CNR, sede di Venezia, ricoprendo le seguenti mansioni:
- tecnico di laboratorio e utilizzo strumenti di laboratorio,
- raccolta, preparazione e analisi di campioni,
- manutenzione e riparazione strumenti,
- preparazione e trasporto materiale per missioni in Artico o uscite in montagna,
- gestione logistica laboratori e reagentari,
- punto istruttore per gli ordini sul mercato elettronico,
- protocollo informatico,
- controllo e gestione tecnica camere bianche (Clean Rooms).
Barbaro Elena
 Ph.D.: Ricercatrice presso l’Istituto di Science Polari del CNR di Venezia, Italia.
Ph.D.: Ricercatrice presso l’Istituto di Science Polari del CNR di Venezia, Italia.
2013-2018 – assegni di ricerca post-doc presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, e l’Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali (IDPA) del CNR di di Venezia; 2010-2012 dottorato di ricerca in Scienze Chimiche presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Area di ricerca
-Chimica ambientale; dal 2013, la sua ricerca si basa sullo studio di traccianti chimici in numerosi comparti ambientali (ghiaccio, neve aerosol, acqua di lago e sedimento) per definire sorgenti e processi di trasporto. Lo studio è principalmente focalizzato nelle aree polari quali l’Artico e l’Antartide.
-Chimica analitica; sviluppo di metodi ad elevata sensibilità mediante tecniche ifenate di cromatografia liquida quail HPLC-MS/MS e IC/MS per lo studio di composti chimici a livelli di tracce ed ultra-tracce.
Ha un’approfondita esperienza nella preparazione di campioni in camere bianche per la determinazione di composti organici a basse concentrazioni. Ha partecipato a diverse campgne scientifiche in Antartide e nelle Isole Svalbard.
Pubblicazioni e indici bibliometrici: H-index: 12 (Scopus); 41 articoli scientifici(Scopus). >50 poster e comunicazioni orali a congressi scientifici; 2 inviti a presentazioni orali a congressi nazionali ed internazionali.
Campagne di campionamento
• 2019-2015 campagne di campionamento artiche (Ny Alesund, Svalbard);
• 2012, 2014 campagne di campionamento in Antartide presso nave oceanografica Italica e la stazione Mario Zucchelli.
Participazione a progetti di ricerca
2018 - 2019 RCN - SSG- Spatial Distributions of Black Carbon and Mineral Dust in Air and Snow Surface Layers upon Svalbard Glaciers: participante
2017-2019 PNRA - EvASIon - Mercer and Whillans lakes: Evolution of hydrologically Active Subglacial environments: participante
2016-2017 RCN - SSG– Community Coordinated Snow Study in Svalbard: participante
2012-2014 PNRA - CaBiLA: Geochemical characterization of Antarctic subglacial lakes: participante
2012 - 2016 EU – Early Human Impact: participante
Scopus - Author ID: 46961088400 ![]() http://orcid.org/0000-0003-2639-7475 Google Scholar
http://orcid.org/0000-0003-2639-7475 Google Scholar
Cosenza Alessandro
 CTER IV livello - Responsabile IT. Gestione dei sistemi e dei servizi informatici dell'istituto nella sede di Messina. In tale ambito svolge le seguenti attività:
CTER IV livello - Responsabile IT. Gestione dei sistemi e dei servizi informatici dell'istituto nella sede di Messina. In tale ambito svolge le seguenti attività:
- APM - Responsabile Tecnico Rete GARR;
- gestione dell’intera rete informatica dell’istituto;
- gestione dei servizi di rete, in particolare, gestione dei server (file server, web server, firewall, DNS, NAT, etc…) per l’erogazione dei servizi trasversali e dei servizi locali;
- gestione delle reti di trasmissione dati (LAN e wireless);
- gestione delle politiche di accesso (router CISCO e firewall);
- assistenza e supporto hardware e software alle postazioni di lavoro degli uffici e dei laboratori;
- supporto alla realizzazione di videoconferenze;
- utilizzo di software a fini statistici per elaborazione e l’interpretazione di risultati sperimentali (in particolare mediante l’impiego di R, un ambiente di sviluppo specifico per l'analisi statistica dei dati). Si occupa inoltre della gestione dei dati locali istituti relativi al personale: rilevazione presenze, assenze, competenze, buoni pasto, mediante ePAS, il sistema di rilevazione e gestione delle presenze del personale CNR.
Cairns Warren Raymond Lee
 Ha conseguito la laurea in Chimica ambientale presso l'Università dell'East Anglia, seguita da un M.Sc in Chimica analitica, ha ottenuto il dottorato di ricerca presso l'Università di Plymouth nel 1996.
Ha conseguito la laurea in Chimica ambientale presso l'Università dell'East Anglia, seguita da un M.Sc in Chimica analitica, ha ottenuto il dottorato di ricerca presso l'Università di Plymouth nel 1996.
Chimico analitico specializzato nell'analisi degli elementi in tracce e lo studio della loro speciazione chimica. I suoi obiettivi includono determinare il ruolo, il destino e gli effetti tossici dei metalli pesanti nell'ambiente e il loro impatto sull'umanità. Recentemente si è concentrato sul mercurio, le sue concentrazioni atmosferiche e sua presenza nella neve, ghiaccio e acque sotterranee, con particolare attenzione ai fenomeni di deposizione.
Ha partecipato a 2 spedizioni antartiche alla stazione di Concordia ed è l'esperto nazionale italiano per i POPs e il mercurio nei gruppi di esperti di AMAP, (il programma di monitoraggio e valutazione dell'Artico) e nella Programma d'azione dei contaminanti artici (ACAP).
Coautore di oltre 64 pubblicazioni; è uno degli autori per la Atomic Spectrometry Updates Environmental Analysis review della Royal Society of Chemistry.
Scopus - Author ID: 7003572964 Research Gate: Warren Cairns
Becherini Francesca
 Laureata in Fisica presso l’Università di Padova nel 1999, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienza per la Conservazione dei Beni Culturali presso l’Università di Firenze nel 2007.
Laureata in Fisica presso l’Università di Padova nel 1999, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienza per la Conservazione dei Beni Culturali presso l’Università di Firenze nel 2007.
Ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 2002, a tempo indeterminato dal 2011. Dal 2002 al 2019 ha lavorato all’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC), Unità di Padova, quindi nell’agosto 2019 si è trasferita all’Istituto di Scienze Polari, dove è attualmente ricercatore presso la sede di Venezia Mestre.
I suoi principali interessi sono nei campi della Fisica dell’Atmosfera, Climatologia e Microclimatologia, Scienze Ambientali. In ISAC ha iniziato a lavorare in microclimatologia applicata alla conservazione dei beni culturali, alla qualità degli ambienti interni, al risparmio energetico, acquisendo grande esperienza di progetti di ricerca multidisciplinari. Con il tempo la sua attività di ricerca si è sempre più focalizzata sulla climatologia.
Attualmente, il suo interesse è da un lato nello studio del cambiamento climatico attraverso il recupero, correzione e analisi di serie di dati climatici proxy e strumentali; dall’altro nello studio dei processi e parametri fisici dell’atmosfera per investigare il bilancio energetico e il sistema climatico in area polare.
E’ stata membro del team di coordinazione di molti progetti Europei dai programmi FP5 e FP7 fino a Horizon 2020, e ha partecipato a numerosi progetti nazionali e internazionali. Professore a contratto di masters e corsi di specializzazione, ha svolto attività di tutoraggio e supporto tecnico-scientifico a tesi di laurea triennali e specialistiche.
Scopus - Author ID: 55370745600 ![]() http://orcid.org/0000-0002-8408-0102 WoS Researcher ID: AAD-8969-2020 Research Gate: Francesca Becherini
http://orcid.org/0000-0002-8408-0102 WoS Researcher ID: AAD-8969-2020 Research Gate: Francesca Becherini
Caruso Gabriella
 Laureata in Scienze Biologiche, Specialista in Microbiologia Applicata, è ricercatrice CNR dal 1994.
Laureata in Scienze Biologiche, Specialista in Microbiologia Applicata, è ricercatrice CNR dal 1994.
I suoi interessi scientifici riguardano l'ecologia microbica marina ed il ruolo dei microorganismi nei processi di decomposizione della materia organica in ambienti mediterranei e polari attraverso misure di attività enzimatiche (aminopeptidasi, glucosidasi, fosfatasi); la ricerca di batteri patogeni (Escherichia coli, Vibrio spp.) mediante fluorescent antibody method e saggi enzimatici; variazioni nei parametri fisiologici (enzimi digestivi, immunità aspecifica) di Teleostei marini in risposta a stressors.
Recenti studi condotti in ambienti estremi hanno esplorato abbondanza ed attività della comunità batterica eterotrofica free-living (Progetto UVASS, Svalbard, Artide), presente nel permafrost o in brine (progetti Programma Nazionale di Ricerche in Antartide-PNRA 2013/AZ1.05), componente di biofilm microbici su substrati plastici (PNRA16_00105), o vettore di antibiotico-resistenze (PNRA 14_00090). Membro del Collegio Docenti Dottorato in Igiene Applicata- Univ. Messina (2006-2011) e dei Direttivi Comitati Plancton (2000-2001; 2002-2003; 2010-2012; 2013-2015) ed Acquacoltura (2004-2006; 2016-2018; 2019-2021) della Società Italiana Biologia Marina. Abilitata Professore Ordinario di Ecologia (2012-2020).
P.I. e membro di vari progetti di ricerca (PNRA, EU FP 7 PERSEUS, Marine Strategy, VECTOR, MIUR Cluster-Sistemi Avanzati Monitoraggio), ha collaborato con Institute of Hydrobiology-Wuhan (Cina), Univ. du Sud Toulon-France, CENPAT-Puerto Madryn (Argentina), CERTE-Soliman (Tunisia).
Co-autore di oltre 350 lavori scientifici, H index 19 (Scopus) e 24 (Scholar). Referee (Publons) e componente di Editorial Boards delle riviste internazionali OA (J. Mar. Sci. Engin.-JMSE, MDPI; J. Coastal Life Medicine, Hainan Univ.; J. Clinical Microbiol. Biochem. Technol.- PEERTECHZ; The Open Fish Sci. J., The Open Mar. Biol. J., BENTHAM; J. Oceanogr. Mar. Res., J. Ecosyst. Ecogr. LONGDOM).
Scopus - Author ID: 7102219836 ![]() http://orcid.org/0000-0002-3819-5486 Scholar
http://orcid.org/0000-0002-3819-5486 Scholar
Zaccone Renata
 Laureata in Scienze Biologiche e specializzata in Microbiologia Applicata. Dal 1982 svolge la sua attività di ricerca al CNR di Messina, oggi parte dell’ISP-CNR. Dal 2001 è Primo Ricercatore.
Laureata in Scienze Biologiche e specializzata in Microbiologia Applicata. Dal 1982 svolge la sua attività di ricerca al CNR di Messina, oggi parte dell’ISP-CNR. Dal 2001 è Primo Ricercatore.
Sin dall’inizio si è occupata di ricerca nell’ambito dell’ecologia microbica. Si interessa alle interazioni tra i fattori ambientali e le comunità microbiche marine; in particolare degli effetti dei cambiamenti climatici sui cicli biogeochimici, attraverso lo studio dei tassi di decomposizione della sostanza organica (misure di attività enzimatica quali peptidasi, glucosidasi e fosfatasi).
Altri interessi di ricerca sono:
- sperimentazione dell’attività antibatterica di oli essenziali e nuovi polimeri;
- valutazione del rischio sanitario in acque costiere (sperimentazione della tecnica di immunofluorescenza per la conta diretta di Escherichia coli, Vibrio spp, Photobacterium.
P.I. di progetti Nazionali (PRISMA 1, Ecosistemi marini/SINAPSI; MIPAF IVp triennale N.C16; PON-RSF 2000-2006 N.12745; VECTOR L.4–5.2) e regionali. Autore di oltre 130 lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali e nazionali.
Recentemente collabora ai progetti PNRA: 2020-2021 PNRA18-0041-B2, Screening dei fenomeni di antibiotico-resistenza in ceppi batterici isolati da acqua, sedimento e intestino di teleostei antartici. Responsabile dott.ssa M. Mancuso.
2016-2017 Proposta PNRA16: Biodiversità e funzionamento degli ecosistemi planctonici del mare di Ross nell'oceano Meridionale in cambiamento (P-ROSE), responsabile O. Mangoni, UO 7: Tassi biogeochimici microbici. Responsabile dott. R. La Ferla.
2016-2017 Proposta PNRA16: 00207 - A3 – CELEBeR (CDW Effects on glaciaL mElting and on Bulk of Fe in the Western Ross sea (CELEBeR). Coordinatore P. F. Rivaro, Responsabile UO Maurizio Azzaro.
2014-2015 Progetto PNRA: Coastal Ecosystem Functioning in a changing Antarctic ocean (CEFA). Coordinatore Prof L.Guglielmo, UO 7, Responsabile dott. R. La Ferla.
Scopus - Author ID: 6701823549 ![]() http://orcid.org/0000-0002-0151-9416
http://orcid.org/0000-0002-0151-9416
Maimone Giovanna
 Giovanna Maimone è attualmente CTER - IV Livello presso l’Istituto di Scienze Polari.
Giovanna Maimone è attualmente CTER - IV Livello presso l’Istituto di Scienze Polari.
Ha partecipato a numerose campagne oceanografiche in ambienti pelagici del Mar Mediterraneo con particolare riguardo alla raccolta, trattamento e analisi di campioni. Ha partecipato attivamente a progetti di ricerca nazionali ed internazionali su tematiche polari.
Le attività di ricerca svolte sono relative allo studio dell’ecologia delle popolazioni batteriche in campioni di matrice acquatica (mare e brine) e permafrost. In particolare: allo studio della biomassa dei procarioti mediante conteggio e analisi morfometrica e morfologica, tramite l’applicazione di tecniche microscopiche in epifluoresenza ed analisi d’immagine; allastima dei profili fisiologici a livello di comunità dei procarioti mediante BIOLOG Ecoplate; alla quantificazione delle cellule vitali mediante l’uso di biomarker (LIVE/DEAD e CTC). Si interessa inoltre della elaborazione grafica e statistica dei dati sperimentali raccoltinell’ambito dei progetti svolti e collabora alla stesura delle pubblicazioni.
Scopus - Author ID: 7801432695
Lo Giudice Angelina
 Nata a Messina, ha conseguito nel 2006 il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Ambientali presso l’Università di Messina.
Nata a Messina, ha conseguito nel 2006 il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Ambientali presso l’Università di Messina.
È membro del Comitato di Gestione PNRA “Raccolta e diffusione dei reperti” e della Giunta esecutiva del CUR per lo Studio degli Ambienti Estremi e degli Estremofili “Francesco Maria Faranda” (Università di Messina). Ha collaborato con l’Università di Messina per la gestione operativa e scientifica della Collezione Italiana di Batteri Antartici del Museo Nazionale dell’Antartide (CIBAN-MNA). Ha partecipato a campagne di prelievo in Artide (Isola Svalbard e Norvegia Artica) e Antartide, nonché a diverse campagne oceanografiche in Mar Mediterraneo.
Partecipa attivamente a progetti di ricerca nazionali ed internazionali su tematiche inerenti l’ecologia e le biotecnologie microbiche in ambienti polari (marini, terrestri e lacustri), affrontando lo studio delle biodiversità e attività procariotiche, delle potenzialità applicative in biotecnologia di batteri cold-adapted (produzione di biomolecole utili e degradazione di inquinanti a bassa temperatura) e delle interazioni batteriche. Particolare attenzione è rivolta all’associazione tra procarioti e invertebrati bentonici filtratori, alla risposta delle comunità microbiche a disturbi antropici ed alla relazione tra la contaminazione chimica ambientale e la diversità procariotica.
E’ autrice di oltre 70 pubblicazioni su riviste peer-reviewed, tra cui Physics of Life Reviews, Scientific Reports, Biotechnology Advances, Science of the Total Environment, Soil Biology and Biochemistry, PLOS One, Applied and Environmental Microbiology, Microbial Ecology e diversi capitoli di libro.
È nell’Editorial Board delle riviste open-access Microorganisms (Section Microbial Biotechnology) and Diversity (Section Microbial Diversity), e Review Editor per Frontiers in Marine Sciences: Marine Biotechnology.
Scopus - Author ID: 57202031230 ![]() http://orcid.org/0000-0002-8842-083X Research Gate: Angelina Lo Giudice
http://orcid.org/0000-0002-8842-083X Research Gate: Angelina Lo Giudice
Filiciotto Francesco
 Ha partecipato in qualità di responsabile e/o collaboratore ai seguenti Progetti di Ricerca: SOS-BASS-PRIN; ELENO-PONANT within ARICE; VECNA; MARE-ERASMUS+ PLNRDA 2017-2019; MSFD, Dir. 2008/56/CE; SySTeMiC-University of the South Pacific; BYCATCH VII-MIPAAF; CAIMAR JOINT LABORATORY; IRSES-RECOMPRA; Monitoraggio ambientale CNR-AMP Isole Pelagie; EMSO-MedIT; BIOforIU; REMOTO-PO FESR; PESCATEC- PON; RITMARE-MIUR; TESEO-PON; CALYPSO- Italia-Malta; ICT per l'Eccellenza dei Territori; STROAM- Italia-Russia.
Ha partecipato in qualità di responsabile e/o collaboratore ai seguenti Progetti di Ricerca: SOS-BASS-PRIN; ELENO-PONANT within ARICE; VECNA; MARE-ERASMUS+ PLNRDA 2017-2019; MSFD, Dir. 2008/56/CE; SySTeMiC-University of the South Pacific; BYCATCH VII-MIPAAF; CAIMAR JOINT LABORATORY; IRSES-RECOMPRA; Monitoraggio ambientale CNR-AMP Isole Pelagie; EMSO-MedIT; BIOforIU; REMOTO-PO FESR; PESCATEC- PON; RITMARE-MIUR; TESEO-PON; CALYPSO- Italia-Malta; ICT per l'Eccellenza dei Territori; STROAM- Italia-Russia.
Ha partecipato a numerose spedizioni scientifiche in mare nazionali ed internazionali in qualità di capo missione e/o componente dello staff scientifico. Componente di spedizioni scientifiche in Artico per la raccolta di dati acustici ed al Polo Nord geografico. Responsabile del Laboratorio di Biodiversità acustica ed ecologia marina (BioSoundEcology Lab) presso la Sede di Messina di CNR-ISP; Responsabile di Convenzioni tra CNR e Università; ha svolto attività didattica presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Messina; valutatore di proposte progettuali ARTA, MIUR, PO FEP, POR FESR; ha preso parte come presidente e/o componente a circa 50 commissioni di concorso per differenti posizioni nei profili della ricerca; ha partecipato in qualità di relatore a più di 30 Conferenze Nazionali/Internazionali; ha ricoperto la figura di Responsabile di personale con Assegno di ricerca, Borsa di studio, Tesi e Tirocinio pre- e post-laurea.
E’ coautore di più di 40 pubblicazioni internazionali su Riviste scientifiche ISI e più di 80 pubblicazioni tra riviste scientifiche nazionali, proceeding, libri, rapporti progettuali, tecnici e brevetti depositati.
Scopus - Author ID: 36058746700 ![]() http://orcid.org/0000-0002-9418-0414
http://orcid.org/0000-0002-9418-0414
Decembrini Franco
 Laurea con lode in Scienze Biologiche (1983) e Dottorato di ricerca in Scienze Ambientali: Ambiente marino e risorse (1989), Università degli Studi di Messina.
Laurea con lode in Scienze Biologiche (1983) e Dottorato di ricerca in Scienze Ambientali: Ambiente marino e risorse (1989), Università degli Studi di Messina.
Ricercatore CNR dal 1994 presso l’Istituto Sperimentale Talassografico di Messina, poi divenuto (2001) Istituto per l’Ambiente Marino Costiero e successivamente (2019) Istituto per le Risorse Biologiche e Biotecnologie Marine, dal 2019 fa parte dell’Istituto di Scienze Polari. L'attività scientifica è riassunta in vari Rapporti tecnici di crociere oceanografiche (anche in qualità di responsabile scientifico) e più di 100 pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali nelle seguenti linee di ricerca:
- ruolo ecologico e fisiologico delle frazioni dimensionali del fitoplancton nelle reti trofiche marine sia in zone costiere sia off-shore del Mar Mediterraneo, del Mare di Ross (Antartide) e dello Stretto di Magellano,
- studio delle condizioni trofiche negli ecosistemi lagunari salmastri esposti a inquinamento chimico e fenomeni di eutrofizzazione (Habs),
- sviluppo di monitoraggio automatico delle proprietà fisico-chimiche, ottiche e di parametri biologici (fitoplancton) in ambienti marini costieri attraverso misure in situ (boa e nave) e telerilevamento (MIVIS, SeaWiFS).
Ha partecipato a diversi programmi nazionali (ROSSMIZE, PRISMA, CLUSTER10, SNOW Artide) e progetti del PRNA, CNR e del Mi.PA ed internazionali (EU VFP: Strategy; EU FP6: SPICOSA WT 10.3 leader ; INTERACT EU: Sponge).
Scopus - Author ID: 6603331973
Azzaro Maurizio
 Ha conseguito due lauree (Scienze Biologiche; Scienze Naturali) e un PhD in Scienze ed Ingegneria del Mare.
Ha conseguito due lauree (Scienze Biologiche; Scienze Naturali) e un PhD in Scienze ed Ingegneria del Mare.
Le attività di ricerca di Maurizio Azzaro sono focalizzate principalmente sullo studio del funzionamento degli ecosistemi polari con un approccio interdisciplinare dedicato a varie temi che vanno dall’ecologia microbica e lo studio del microbial food web, allo studio della biodiversità e il funzionamento degli ecosistemi marini e terrestri. Nell’arco della sua carriera ha affrontato temi inerenti lo sviluppo di nuove tecnologie in aree polari (aree marginali ai ghiacciai marini), gli effetti dell’inquinamento (metalli pesanti, petrolio, plastiche, etc.) e dei cambiamenti globali e il loro impatto sulle comunità microbiche marine e terrestri. Attenzione è stata posta anche alla conservazione e protezione degli ecosistemi terrestri e marini con particolare riferimento all’Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM) e la Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR).
Maurizio Azzaro in trent’anni di ricerche ha svolto una fervida attività in campo in un ampio spettro di ambienti marini e terrestri: permafrost, ghiaccio marino, laghi (temperati e ghiacciati), stretti, rade, golfi, porti, fiordi, aree di transizione, aree costiere, aree pelagiche (Epi-, meso- e bati-pelago), mari marginali e aree polari. Complessivamente ha partecipato nell’ambito di progetti di ricerca nazionali ed internazionali (> 50), a oltre 60 spedizioni scientifiche in Artide, Antartide (in 3 coordinatore scientifico della spedizione), Cina, Oceano Pacifico, Oceano Atlantico e nel Mar Mediterraneo (in 7 come Capo Missione).
Durante la sua carriera ha pubblicato più di 100 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.
Dal 2019 è responsabile della sezione dell’Istituto di Scienze Polari di Messina.
Scopus - Author ID: 6602752439
Azzaro Filippo
 Ha conseguito la laurea in Scienze Biologiche nel 1988 presso l'Università di Messina. Dal 1 settembre 1981 al 30 agosto 1990 è stato assegnista presso l'Istituto Talassografico di Messina (C.N.R.). Nel 1990 è stato assunto presso il suddetto Istituto, con il profilo professionale di CTER, fino al 31 dicembre 2000. Dal 1 gennaio 2001 riveste il profilo di ricercatore al C.N.R presso l’Istituto Scienze Polari (ISP) di Messina.
Ha conseguito la laurea in Scienze Biologiche nel 1988 presso l'Università di Messina. Dal 1 settembre 1981 al 30 agosto 1990 è stato assegnista presso l'Istituto Talassografico di Messina (C.N.R.). Nel 1990 è stato assunto presso il suddetto Istituto, con il profilo professionale di CTER, fino al 31 dicembre 2000. Dal 1 gennaio 2001 riveste il profilo di ricercatore al C.N.R presso l’Istituto Scienze Polari (ISP) di Messina.
In qualità di ricercatore dell’ISP di Messina, il dr. F. Azzaro collabora a diversi programmi scientifici nazionali ed europei, ha partecipato a numerosi congressi nazionali e internazionali.
L'attività scientifica del dr. F. Azzaro è stata mirata verso temi di Oceanografia Biologica, in particolare:
- determinazione dei nutrienti sia tradizionalmente che con strumentazione di monitoraggio in continuo (mezzo mobile, boa oceanografica);
- valutazione dei parametri trofici (clorofilla a e ATP);
- studio dell’upwelling dello Stretto di Messina e l’influenza sulla produzione e biomassa fitoplanctonica, con l’utilizzo di tecniche di rilevamento automatico e con sistemi iperspettrali da aeromobile (MIVIS).
- studio delle condizioni chimiche e trofiche negli ecosistemi lagunari salmastri, in quelli marini costieri e del largo, Mar Mediterraneo, Mare di Ross (Antartide), aree periantartiche (Magellano) e fiordo Kongsfjorden (Artico);
- inquinamento chimico ed eutrofizzazione negli ambienti marini costieri e di transizione.
Ha partecipato a numerose campagne oceanografiche che afferivano a programmi Nazionali e Internazionali.
Ha partecipato alle seguenti spedizioni scientifiche italiane in Antartide: X (ROSSMIZE 1994/95), XIX (VLT 2003/04), XX (ABIOCLEAR 2004/05), XXXI (CEFA 2015-2016) e XXXII (P.ROSE e CELEBER 2016-2017).
Scopus - Author ID: 8516485200
Rompighiaccio italiana Laura Bassi raggiunge il punto più meridionale della Terra (latitudine 78° 41.1006S)
 7 Febbraio 2020
7 Febbraio 2020
Il record è stato battuto nel corso di un campionamento nel Mare di Ross in Antartide, effettuato per la campagna oceanografica della 35a spedizione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), gestito da ENEA per la pianificazione e l’organizzazione logistica e dal Cnr per la programmazione e il coordinamento scientifico.
Comunicato stampa CNR
XXXV Spedizione in Antartide
Rompighiaccio Laura Bassi - Sito OGS
Physics and Chemistry of the Arctic Atmosphere
Edito da Springer un nuovo libro sull'atmosfera Artica, curato da Cladio Tomasi con Alexander Kokhanovsky, con diversi contributi dei ricercatori ISP (ISAC al momento della preparazione del volume).
Il libro presenta le conoscenze attuali di chimica e fisica dell'atmosfera artica. Particolare attenzione è rivolta agli studi sul fenomeno della foschia artica, alle nuvole troposferiche artiche, sulla nebbia artica, sulle nuvole stratosferiche e mesosferiche polari, sulla dinamica atmosferica, sulla termodinamica e sul trasferimento radiativo in relazione all'ambiente polare. I meccanismi di retroazione atmosfera-criosfera e le tecniche di telerilevamento atmosferico vengono presentati in dettaglio. Vengono anche affrontati i problemi dei cambiamenti climatici nell'Artico.
L'ISP nella spedizione oceanografica sulla piattaforma continentale dell’Australia sudoccidentale
 31 Gennaio 2020
31 Gennaio 2020
Ricercatori del CNR-ISMAR e CNR-ISP partecipano da gennaio 2020 ad una missione oceanografica della nave da ricerca Falkor appartenente allo Schmidt Ocean Institute. Il team internazionale comprende Paolo Montagna (CNR-ISP), che agirà come Co-Capo missione insieme a Julie Trotter dell’University of Western Australia, Marco Taviani, Federica Foglini e Alessandro Remia del CNR-ISMAR.
La campagna oceanografica FK200126 condurrà la prima esplorazione delle acque profonde nella zona sud-occidentale dell’Australia, lungo il Bremer Canyon e il Leeuwin Canyon.
Comunicato stampa CNR
Segui la crociera on line
Artico - Primo paleorecord di ghiaccio marino nel Nord Atlantico
 21 Gennaio 2020
21 Gennaio 2020
Studio dell’Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-ISP) pubblicato su Climate of the Past ha prodotto il primo paleorecord di ghiaccio marino nel Nord Atlantico che ha consentito di scoprirne l’evoluzione durante le variazioni climatiche degli ultimi 120mila anni.
A 120 000-year record of sea ice in the North Atlantic? Clim. Past, 15, 2031–2051, 2019
BANDO PNRA 2019
 MIUR - 17 gennaio 2020
MIUR - 17 gennaio 2020
Decreto Direttoriale n. 20 del 17-1-2020
PNRA 2019 Disciplina delle procedure per la presentazione di proposte di progetti di ricerca rivolte ad approfondire le conoscenze in Antartide.
Scarica e visiona il BANDO PNRA 2019
Scadenza: ore 12 del 27 febbraio 2020
SESS Report 2019
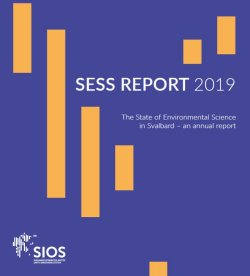 14 Gennaio 2020
14 Gennaio 2020
Il rapporto dello stato della scienza ambientale alle Svalbard (SESS) è stato rilasciato durante la settimana polare notte (SIOS Polar Night Week) a Longyearbyen, gennaio 2020. È il secondo numero di una serie annuale di relazioni pubblicate da SIOS. La relazione di quest'anno comprende le recensioni dei dati e delle attività esistenti, sintesi dei dati eaggiornamenti dei capitoli dell'anno scorso. Si tratta di una descrizione unica delle attività e della collaborazione in corso, nonché raccomandazioni per il futuro nella ricerca delle Svalbard.
Scoping Workshop: Toward Implementing an Antarctic RCC-Network - Bologna, Italy, 7-9 October 2019
 Scoping Workshop: Toward Implementing an Antarctic RCC-Network
Scoping Workshop: Toward Implementing an Antarctic RCC-Network
Bologna, Italy, 7-9 October 2019
The World Meteorological Organization (WMO) is fostering the establishment of Regional Climate Centres (RCCs) for the Polar Regions.
Antartide - Aggiornamenti dal progetto europeo Beyond EPICA - Oldest Ice Core
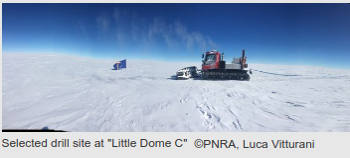 23 Dicembre 2019
23 Dicembre 2019
Sondaggio geofisico ad alta risoluzione conferma il sito per il carotaggio profondo del progetto europeo Beyond EPICA - Oldest Ice Core: 1.5 Myr of greenhouse gas - climate feedback. Esperti di 12 istituzioni provenienti da 10 paesi europei, coordinati da Carlo Barbante dell’Università Ca’ Foscari Venezia e dell’Istituto di Scienze Polari del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-ISP), hanno confermato il sito per il carotaggio in Antartide Orientale.
Comunicato stampa CNR
Beyond EPICA - Oldest Ice Core
Ricercatrice CNR nominata chair di una flagship della Ny-Ålesund Science Managers Committee (NySMAC)
 14 Novembre 2019
14 Novembre 2019
Nel corso del meeting della Terrestrial Ecology Flagship tenutosi ad Oslo il 5 novembre 2019 nell’ambito della Svalbard Science Conference, Angela Augusti ricercatrice dell'Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri (CNR-IRET) è stata nominata coordinatrice della suddetta flagship.
Comunicato stampa CNR
Mostra Artico. Viaggio interattivo al Polo Nord, 15 Gennaio - 12 Febbraio 2020 - Sede CNR - ROMA
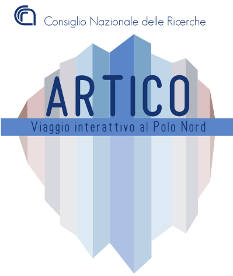 La mostra attraverso installazioni fisiche e multimediali, esperimenti interattivi, apparecchiature scientifiche, ricostruzioni in scala, documenti, oggetti e immagini suggestive guida il pubblico alla scoperta dell’Artico, delle sue peculiarità e dei fenomeni osservati.
La mostra attraverso installazioni fisiche e multimediali, esperimenti interattivi, apparecchiature scientifiche, ricostruzioni in scala, documenti, oggetti e immagini suggestive guida il pubblico alla scoperta dell’Artico, delle sue peculiarità e dei fenomeni osservati.
Il percorso della mostra prosegue mettendo a fuoco le principali attività di ricerca che l’Italia conduce in Artico e in particolare a Ny-Ålesund, nelle Isole Svalbard, dove il Cnr gestisce la stazione di ricerca 'Dirigibile Italia'. Infine si illustra la struttura organizzativa degli organismi internazionali, di cui anche l’Italia fa parte, che gestisce la programmazione scientifica e politica in Artico. La mostra, che si avvale del contributo di vari Istituti Cnr, è un’ottima occasione per capire le attività dei ricercatori italiani che operano in Artico.
EAIIST (East Antarctic Int'l Ice Sheet Traverse)
 3 Dicembre 2019
3 Dicembre 2019
Una 'traversa' sul plateau in Antartide per stimare l'aumento del livelo dei mari
Dal 5 dicembre 2019 al 25 gennaio 2020, una squadra composta da scienziati francesi del Cnrs, dell’Università Grenoble Alpes e da scienziati italiani del Cnr e dell’Ingv percorrerà 1318 km tra andata e ritorno in mezzo al plateau dell’Antartide, su una traversa organizzata dall’Istituto Polare Francese (Ipev) con la collaborazione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (Pnra).
Tra i ricercatori italiani sarà presente in campo Andrea Spolaor (CNR-ISP) .
Comunicato stampa CNR
EAIIST
Antartide: al via la 35a spedizione italiana (2019-2020)
 23 Ottobre 2019
23 Ottobre 2019
Gestita dall’ENEA per la pianificazione e l’organizzazione logistica e dal CNR per la programmazione e il coordinamento scientifico, la missione ha inizialmente riattivato i servizi e preparato la pista di 3 km sul pack marino per l’atterraggio di aerei intercontinentali.
Impiegata per la prima volta l’unica nave italiana in grado di operare nelle aree polari, la Laura Bassi, acquisita dall’Ogs di Trieste, che effettuerà una campagna oceanografica da Lyttelton a Baia Terra Nova.
Comunicato stampa CNR
BANDO PRA 2019 - Scadenza 6 Dicembre 2019
 Programma di Ricerche in Artico 2019-2020:
Programma di Ricerche in Artico 2019-2020:
al via il bando per la presentazione di proposte
Disciplina delle procedure per la presentazione di proposte di progetti di ricerche specifiche a rivolte ad approfondire le conoscenze in Artico.
Scadenza per la presentazione delle domande: 6 dicembre 2019 h 12:00
Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto (Art. 13, Regolamento Organizzazione e Funzionamento CNR del 2019) è costituito dal Direttore, da 6 eletti tra i ricercatori/tecnologi e da 1 eletto tra i tecnici/amministrativi.
Precedenti CdI
Contatto: ISP-CdI AT isp.cnr.it
Il Consiglio dell'Istituto di Scienze Polari (in vigore dal 27 febbraio 2024) è così composto :
.
.
.
.
.
.
.
.

Giuliana Panieri
M.Sclavo (fino al 31 gennaio 2025)
C.Barbante (fino al 30 aprile 2024)
Warren Raymond Lee Cairns
(Rappresentante Personale
Ricercatore/Tecnologo)
Pamela Cialli
(Rappresentante Personale
Tecnico-Amministrativo) 
Fabiana Corami
(Rappresentante Personale
Ricercatore/Tecnologo)

Francesco Filiciotto
(Rappresentante Personale
Ricercatore/Tecnologo)
Angelina Lo Giudice
(Rappresentante Personale
Ricercatore/Tecnologo)
Angelo Lupi
(Rappresentante Personale
Ricercatore/Tecnologo) 
Francesca Spataro
(Rappresentante Personale
Ricercatore/Tecnologo)
21 dicembre 2019 - 19 dicembre 2023
Direttore: Carlo Barbante
Rappresentanti Personale Ricercatore-Tecnologo: Maurizio Azzaro, Fabiana Corami, Federico Giglio, Elena Gregoris, Mauro Mazzola, Rosamaria Salvatori
Rappresentante Personale Tecnico-Amministrativo: Alessandro Cosenza
Padova
Dove siamo: la Sede di Lavoro di Padova dell’Istituto di Scienze Polari è ubicata presso l’Area della Ricerca CNR di Padova, Corso Stati Uniti,4 - 35127 Padova. Mappa
Come raggiungerci:
- in treno: scendendo alla stazione ferroviaria di Padova e poi con l'autobus n.7;
- in auto: dalla autostrada A4, uscendo a Padova Est, si imbocca la tangenziale a sinistra, direzione Piove di Sacco/Chioggia, alla terza uscita (n. 13) ci si trova in Corso Stati Uniti. Seguire la direzione a U obbligatoria e l'entrata del CNR è circa a 100 m dopo il sottopasso. Dalla A13 si esce all'uscita "Padova Zona Industriale" e si arriva direttamente in Corso Stati Uniti a circa 2 Km dall'entrata del CNR;
- in aereo: Aeroporto internazionale di Venezia Tessera e poi con l'autobus fino alla stazione ferroviaria di Padova. Da qui si arriva all'Area con l'autobus n.7. É possibile utilizzare anche gli aeroporti internazionali di Treviso o Verona.
Messina
Dove siamo: l’edificio, in puro stile Liberty, sorge nella zona falcata di Messina, all’ombra della Lanterna del Montorsoli. Grazie alla particolare posizione geografica, esso domina le acque dello Stretto di Messina e del Porto. L’edificio è costituito da un unico fabbricato, formato da un corpo centrale a tre piani alquanto arretrato, che ospita uffici e studi, e da due corpi laterali più sporgenti, destinati a laboratori. La sede ISP di Messina è in condivisione con l’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (CNR-IRBIM) e dispone di un parco di circa 10000 mq, dove sorge anche un edificio che in origine era sede del regio Tiro a Segno Nazionale ed oggi è destinato ad auditorium.
Come raggiungerci:
- in treno: se provenite dalla penisola, scendete alla stazione di Villa San Giovanni, poi imbarcatevi su nave veloce BlueJet con direzione Messina Porto Storico. Se, invece, provenite da una località siciliana, scendete alla Stazione di Messina Centrale. Una volta giunti a Messina, telefonate in Sede per concordare il trasferimento in auto verso l’Istituto;
- in aereo: l’aeroporto più vicino è l’Aeroporto Fontanarossa di Catania. Dall’aeroporto, prendete il bus della SAIS-Autolinee verso la Stazione di Messina Centrale. Una volta giunti a Messina, telefonate in Sede per concordare il trasferimento in auto verso l’Istituto;
- in auto: l’istituto è raggiungibile in automobile con la possibilità di parcheggiare temporaneamente all’interno del parco. Se provenite dalla penisola, una volta giunti a Villa San Giovanni potrete imbarcarvi su nave Caronte (corse ogni 40 min) e poi, giunti a Messina, proseguire in auto fino all’Istituto. Se, invece, provenite da una località siciliana, prendete la A18 Messina-Catania, uscite preferibilmente a Messina Centro e proseguite verso l’istituto seguendo queste indicazioni.
Contatti
 ISP - Sede di Messina
ISP - Sede di Messina
Responsabile
Dr. Maurizio Azzaro
E-mail: responsabile_me AT isp.cnr.it
Spianata S. Raineri 86 - 98122 Messina (ME)
Tel: +39 090 601 5415
Fax: +39 090 669 007
MAPPA
Bologna
Dove siamo: la sede secondaria dell’Istituto di Scienze Polari di Bologna è ubicata nell’Area della Ricerca di Bologna. Gli spazi ISP occupano una superficie complessiva (uffici e laboratori) di circa 300 m2, distribuita tra 2 edifici, in parte condivisi con il personale ISAC (Istituto di Scienza dell’Atmosfera e del Clima) ed ISMAR (Istituto di Scienze Marine).
Come raggiungerci:
- in treno: dalla stazione ferroviaria di Bologna Centrale potete prendere un taxi che in 5 minuti vi condurrà a destinazione, oppure potete prendere l’autobus nr. 87 oppure nr. 37;
- in auto: dall’autostrada prendete l’uscita Bologna Arcoveggio, dalla tangenziale prendete l’uscita n. 5 Quartiere Lame;
- in aereo: dall’aeroporto Guglielmo Marconi potete prendere la navetta Aerobus BLQ, in coincidenza con gli autobus di linea, oppure potete prendere un taxi (cotabo.it, tel. 051-372727 oppure taxibologna.it, tel. 051-4590) che in 10 minuti circa vi condurrà a destinazione.
Contatti
 ISP - Sede di Bologna
ISP - Sede di Bologna
Responsabile
Dr Stefano Miserocchi
E-mail: responsabile_bo AT isp.cnr.it
c/o Area della Ricerca di Bologna
Via P. Gobetti, 101 - 40129 Bologna (BO)
Tel: +39 051 6398 880
Fax: +39 051 6398 939
MAPPA
Venezia - Mestre
Dove siamo: l’Istituto di Scienze Polari occupa il piano 2 dell’edifico DELTA nel nuovo Campus Scientifico dell’Università Ca’ Foscari Venezia in via Torino 155, Venezia-Mestre. Il nuovo Campus Scientifico di Mestre è un moderno complesso edilizio composto da cinque nuovi edifici, da due edifici preesistenti e da una nuova residenza universitaria.
Come raggiungerci: coordinate GPS: Lat. 45°, 477790 - Long. 12°, 254480 - UTM 33N 285419-5039695 - MAPPA
- in treno: stazione di Venezia-Mestre, autobus Nr. 31H, fermata Torino-Università, oppure Nr. 43, fermata Torino-Università. Dall’Istituto verso la stazione di Venezia-Mestre autobus Nr. 32H oppure Nr. 43. Stazione di Porto Marghera poi 10-15 min a piedi;
- in auto: l’Istituto è raggiungibile in automobile con la possibilità di parcheggiare temporaneamente all’interno del campus. Provenendo da Padova, uscita per Venezia, 8 min, 5.3 Km;
- in aereo: l’aeroporto più vicino è l’Aeroporto Marco Polo di Venezia. Dall’aeroporto autobus Nr. 15 (fino a Stazione FS), quindi autobus Nr. 31H, fermata Torino-Università, oppure Nr. 43, fermata Torino-Università.
Atmosfera
L’atmosfera polare è caratterizzata da una forte stabilità e dalla forte inversione termica che si determina in tali regioni (la temperatura aumenta all’aumentare della quota rispetto al suolo, al contrario di quanto avviene nelle regioni a medie latitudini), entrambi fenomeni che sono conseguenza del suolo quasi perennemente congelato o coperto di neve e ghiaccio. Tale proprietà vale anche per la superficie del mare, quando ricoperta dal ghiaccio.
Un altro elemento importante dell’atmosfera polare è rappresentato dalla presenza del cosiddetto vortice polare, un moto vorticoso delle masse d’aria intorno al polo che tiene separate le masse d’aria fredda polari da quelle più calde alle medie latitudini. La conoscenza delle caratteristiche termodinamiche dell’atmosfera polare è fondamentale per poter studiare i cicli biogeochimici di specie naturali e i processi di trasporto a lunga distanza di componenti atmosferici dalle aree antropizzate.
Le attività di ricerca svolte presso ISP sono finalizzate ad approfondire la conoscenza dei processi e delle interazioni tra le diverse componenti del sistema climatico, in modo particolare alle interfacce aria-neve-suolo e aria-mare-ghiaccio marino.
Composizione atmosferica
Le regioni polari rappresentano un laboratorio a cielo aperto per studiare i cicli biogeochimici di specie naturali, le trasformazioni chimiche atmosferiche in un continente incontaminato, così come i processi di trasporto dalle medie e dalle basse latitudini. Diversi costituenti caratterizzano la composizione atmosferica, tra cui rivestono una notevole importanza i gas cosiddetti serra (quali il vapore acqueo, l’anidride carbonica ed il metano le cui concentrazioni sono influenzate da attività antropiche e da processi naturali), e gli aerosol. Questi ultimi costituenti hanno un impatto notevole nelle regioni polari perché contribuiscono fortemente ai processi di retroazione che amplificano i cambiamenti climatici.
L’aerosol atmosferico è composto da particelle in sospensione all'interno dell'atmosfera, che possono essere di origine naturale (tramite sollevamento ad opera dei venti di particelle da superfici denudate o desertiche, di spume marine e di particelle di origine vulcanica o legate a grandi incendi) o antropica (emissioni industriali e da combustibili). Lo studio della composizione chimica dell'aerosol antartico e artico è uno dei punti chiave nella ricerca polare. Questi studi sono eseguiti mediante l’utilizzo di specifici traccianti chimici, come ad esempio i componenti idrosolubili, gli acidi organici, gli zuccheri, i composti fenolici, gli amminoacidi, gli elementi in traccia o le terre rare. L’aerosol svolge un importante ruolo nella regolazione del clima interagendo con la radiazione solare e modificando le proprietà microfisiche delle nubi.
Oceanografia
Gli oceani e i mari polari sono studiati nelle loro proprietà chimico-fisiche, i loro movimenti, gli scambi energetici tra oceano e atmosfera, gli organismi che vi vivono (compresa la loro ecologia e origine) e la struttura geologica dei bacini oceanici, nonché i sedimenti che vi si depositano.
ISP possiede competenze su diversi aspetti dello studio dell’oceanografia polare.
Oceanografia fisica e chimica
 Gli oceani polari sono uno dei motori che influenzano l’intero Sistema Terra. Ai poli infatti si generano delle acque che si diffondono per tutti gli Oceani fino al polo opposto "alimentando" la Conveyor Belt. Le masse d'acqua coinvolte trasportano sia energia che sostanze disciolte, gas e particelle insolute con la conseguenza di influenzare significativamente la composizione stessa delle acque e, da ultimo, il clima terrestre. Lo studio della geochimica delle masse d’acqua polari (mediante la determinazione di elementi in traccia, di composti organici e degli isotopi stabili e radiogenici) consente di valutare i rapporti che intercorrono fra le diverse masse d’acqua (di neoformazione e/o acque “vecchie” provenienti da latitudini più basse), di comprendere i processi in atto e, per finire, di fornire i dati necessari alla creazione e all’implementazione di modelli che consentiranno di comprendere l’interazione delle diverse masse d’acqua e, più in generale, l’evoluzione del sistema climatico terrestre.
Gli oceani polari sono uno dei motori che influenzano l’intero Sistema Terra. Ai poli infatti si generano delle acque che si diffondono per tutti gli Oceani fino al polo opposto "alimentando" la Conveyor Belt. Le masse d'acqua coinvolte trasportano sia energia che sostanze disciolte, gas e particelle insolute con la conseguenza di influenzare significativamente la composizione stessa delle acque e, da ultimo, il clima terrestre. Lo studio della geochimica delle masse d’acqua polari (mediante la determinazione di elementi in traccia, di composti organici e degli isotopi stabili e radiogenici) consente di valutare i rapporti che intercorrono fra le diverse masse d’acqua (di neoformazione e/o acque “vecchie” provenienti da latitudini più basse), di comprendere i processi in atto e, per finire, di fornire i dati necessari alla creazione e all’implementazione di modelli che consentiranno di comprendere l’interazione delle diverse masse d’acqua e, più in generale, l’evoluzione del sistema climatico terrestre.
Biologia e Ecosistemi
Gli ambienti polari mostrano un’elevata biodiversità sia su scala spazio-temporale sia nei diversi livelli di organizzazione biologica, dalle molecole all’intero ecosistema. I recenti e rapidi cambiamenti climatici e ambientali rendono urgente la necessità di comprendere la risposta delle comunità biologiche e l’impatto su di esse a breve e lungo termine. In questo contesto, i ricercatori dell’ISP affrontano lo studio di diversi aspetti bio-ecologici nell’ecosistema marino e terrestre di entrambi i poli. La ricerca si sviluppa su quattro campi di indagine principali a volte interconnessi tra loro.
Biodiversità ed adattamento
 Le comunità biologiche polari sono generalmente sottoposte all’influenza di diversi fattori concomitanti alla bassa temperatura, quali essiccamento, copertura di ghiaccio, scarsa disponibilità di nutrienti, esposizione a radiazioni solari nocive (ad esempio radiazioni UV-B), fotoperiodi estremamente variabili e, in casi specifici, elevate salinità e stress osmotico. La biodiversità garantisce il funzionamento di tutti gli ecosistemi, per cui studiare le proprietà e l’evoluzione temporale degli ecosistemi polari costituisce uno strumento di fondamentale importanza per migliorare le nostre conoscenze sullo stato attuale e per predirne il futuro, anche in relazione ai cambiamenti climatici. L’analisi e il monitoraggio della biodiversità delle comunità biologiche e delle loro dinamiche ecologiche costituiscono il punto focale di questa tematica di ricerca. Di particolare interesse è anche lo studio dei meccanismi di adattamento morfologico-funzionale adottati dagli organismi polari per la sopravvivenza in condizioni estreme.
Le comunità biologiche polari sono generalmente sottoposte all’influenza di diversi fattori concomitanti alla bassa temperatura, quali essiccamento, copertura di ghiaccio, scarsa disponibilità di nutrienti, esposizione a radiazioni solari nocive (ad esempio radiazioni UV-B), fotoperiodi estremamente variabili e, in casi specifici, elevate salinità e stress osmotico. La biodiversità garantisce il funzionamento di tutti gli ecosistemi, per cui studiare le proprietà e l’evoluzione temporale degli ecosistemi polari costituisce uno strumento di fondamentale importanza per migliorare le nostre conoscenze sullo stato attuale e per predirne il futuro, anche in relazione ai cambiamenti climatici. L’analisi e il monitoraggio della biodiversità delle comunità biologiche e delle loro dinamiche ecologiche costituiscono il punto focale di questa tematica di ricerca. Di particolare interesse è anche lo studio dei meccanismi di adattamento morfologico-funzionale adottati dagli organismi polari per la sopravvivenza in condizioni estreme.
Criosfera
La fusione sempre più evidente delle calotte glaciali e dei ghiacciai in generale, il conseguente cambiamento del livello del mare, la distruzione delle piattaforme glaciali mettono in evidenza come questa parte della criosfera costituisca una porzione fragile del sistema Terra. I ghiacciai sono archivi climatici unici che ci offrono l'opportunità di indagare il clima del passato e di valutare i cambiamenti in atto nella prospettiva di lunghe scale temporali. Tali cambiamenti sono però resi evidenti anche dalla fusione del permafrost che ha un drammatico impatto nelle aree polari ma anche alle medie latitudini. In questo difficile contesto di cambiamenti climatici i ricercatori dell’Istituto di Scienze Polari affrontano, con attività di ricerca tra loro interconnesse, lo studio di neve e ghiaccio, della loro composizione chimica nonché dei principali parametri fisici, l’evoluzione del permafrost e l’impatto che la crescente fusione ha su atmosfera, biosfera e idrosfera sia a livello regionale che globale.
Manto nevoso
 La neve, oltre ad influenzare il bilancio di massa dei ghiacciai e delle calotte polari, riflette la composizione chimica atmosferica ed interagisce in modo dinamico con tutte le altre componenti ambientali delle regioni polari. Rappresenta una porzione della criosfera estremamente reattiva dove molteplici processi post-deposizionali possono avvenire. Lo studio del manto nevoso in tali regioni diventa quindi indispensabile per comprendere i processi, le interazioni ed i cambiamenti che esso stesso sta subendo a seguito del cambiamento climatico in atto e per valutare le ricadute sul sistema globale. È inoltre fondamentale per la comprensione dei meccanismi di ri-emissione e rilascio di composti accumulatisi durante la notte polare e l’impatto non trascurabile che tale rilascio può avere sui cicli bio-geochimici polari.
La neve, oltre ad influenzare il bilancio di massa dei ghiacciai e delle calotte polari, riflette la composizione chimica atmosferica ed interagisce in modo dinamico con tutte le altre componenti ambientali delle regioni polari. Rappresenta una porzione della criosfera estremamente reattiva dove molteplici processi post-deposizionali possono avvenire. Lo studio del manto nevoso in tali regioni diventa quindi indispensabile per comprendere i processi, le interazioni ed i cambiamenti che esso stesso sta subendo a seguito del cambiamento climatico in atto e per valutare le ricadute sul sistema globale. È inoltre fondamentale per la comprensione dei meccanismi di ri-emissione e rilascio di composti accumulatisi durante la notte polare e l’impatto non trascurabile che tale rilascio può avere sui cicli bio-geochimici polari.
Foto di Elena Barbaro (CNR-ISP)
Ambiti di ricerca
Introduzione
Le attività di ricerca dell'ISP si svolgono principalmente in Antartide e in Artico dove neve e ghiaccio sono l’aspetto dominante del paesaggio. Queste regioni, più di altre, risentono dei cambiamenti climatici in atto e a causa di ciò il lavoro degli scienziati è diventato una vera e propria corsa contro il tempo per riuscire a conoscere al meglio la storia del nostro pianeta al fine di comprendere come le attività umane, dalle origini delle prime civiltà fino ai giorni nostri, abbiano impattato sugli ecosistemi, interagendo e modificando anche i delicati equilibri che governano il sistema climatico terrestre.
Missione
La missione dell’ISP è contribuire ad accrescere la qualità della ricerca scientifica e tecnologica dell’Italia nelle regioni polari e fornire un contributo alle conoscenze sui cambiamenti globali anche a sostegno delle politiche ambientali italiane ed europee e nello sviluppo di nuove tecnologie e metodologie di indagine.
L’Istituto si propone di essere un punto di riferimento:
- scientifico della ricerca polare del CNR, con ampie connessioni con le Università e con gli enti pubblici e privati nazionali ed internazionali, in grado di offrire competenze multidisciplinari e tecnologie essenziali allo studio ed alla salvaguardia dell’ambiente;
- tecnico–scientifico, in grado di fornire il più qualificato contributo al Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, al Programma di Ricerca in Artico ed alla Commissione Europea attraverso lo sviluppo di attività di ricerca e di monitoraggio;
- per la cooperazione e la ricerca interdisciplinare polare anche attraverso lo sviluppo di incontri, pubblicazioni, opportunità di ricerche ed attività complementari, proponendosi come interfaccia con la società;
- per la standardizzazione della qualità delle misure e dei metodi di elaborazione, per lo sviluppo di misure coordinate e finalizzate a comuni piani di ricerca e/o a comuni obiettivi generali;
- per la formazione della futura generazione di ricercatori nelle scienze polari.
Ciò consentirà di comprendere meglio i cambiamenti climatici in atto negli ambienti Artici ed Antartici ed i possibili sviluppi futuri sia a livello polare che globale. Gli studi affrontano tematiche di ricerca inerenti sia aspetti chimici/geochimici che fisici in un approccio multidisciplinare per la salvaguardia di ambienti estremi vulnerabili. Le ripercussioni su tali dinamiche sono ancora poco conosciute e richiedono un approccio multidisciplinare e di lungo termine per ricerche integrate.
Personale
DIRETTRICE - PANIERI GIULIANA - direttore.isp AT cnr.it - Tel:041-2348659
Staff
Contattare con nome.cognome AT cnr.it
ADEMOLLO NICOLETTA -
Bologna - Ricercatore
ANTONELLI GIUSEPPE -
Bologna - Collaboratore tecnico
ARGIRIADIS ELENA -
Venezia - Ricercatore - Tel:041-2348658
AZZARO FILIPPO -
Messina - Ricercatore - Tel:090-6015419
AZZARO MAURIZIO -
Messina - 1° Ricercatore - Tel:090-6015415
BARBARO ELENA -
Venezia - Ricercatore - Tel:041-2348504
BEATRICI DANIELA -
Roma-Tor Vergata - Collaboratore tecnico
BECHERINI FRANCESCA -
Venezia - 1° Ricercatore - Tel:041-2346761
CAIRNS WARREN RAYMOND LEE
- Venezia - 1° Ricercatore - Tel:041-2348992
CARNIEL SANDRO -
Venezia - Dirigente di Ricerca
CARUSO GABRIELLA -
Messina - 1° Ricercatore - Tel:090-6015423
CASULA MARCO -
Venezia - Collaboratore tecnico (assegnazione temporanea presso altra struttura)
CAVALIERE ALICE
- Bologna - Tecnologo
CESTER VALENTINA -
Venezia - Collaboratore tecnico - Tel:041-2348547
CIALLI PAMELA -
Roma-Tor Vergata - Collaboratore di amministrazione - Tel:06-45488349
COLUCCI RENATO R.
- Venezia - Ricercatore - Tel:040-3756876
CORAMI FABIANA -
Venezia - Ricercatore - Tel:041-2348658
COSENZA ALESSANDRO -
Messina - Collaboratore tecnico - Tel:090-6015439
COZZI GIULIO -
Venezia - Ricercatore - Tel:041-2348935
CRISAFI FRANCESCA -
Messina - Ricercatore
DALLO FEDERICO -
Venezia - Ricercatore - Tel:041-2348937
DE BIASIO FRANCESCO -
Venezia - Ricercatore - Tel:041-2348938
DE BLASI FABRIZIO -
Venezia - Ricercatore
DECEMBRINI FRANCO -
Messina - Ricercatore - Tel:090-6015413
DI FRANCO SABINA -
Roma-Montelibretti - Tecnologo - Tel:06-90672394
DI LEO GUGLIELMO -
Messina - Collaboratore tecnico
DI MAURO BIAGIO
- Milano - Ricercatore - Tel:02-66173404
FILICIOTTO FRANCESCO
- Messina - Ricercatore - Tel:090-6015420
GABRIELI JACOPO -
Venezia - 1° Ricercatore - Tel:041-2348911
GIGLIO FEDERICO
- Bologna - Ricercatore - Tel:051-6398904
GILARDONI STEFANIA -
Milano - 1° Ricercatore - Tel:02-66173328
GIORDANO PATRIZIA -
Bologna - Ricercatore - Tel:051-6398902
GREGORIS ELENA -
Venezia - Ricercatore - Tel:041-2348937
IAKIMOV MIKHAIL -
Messina - Dirigente di Ricerca
LA CONO VIOLETTA -
Messina - Ricercatore
LA MESA MARIO -
Bologna - 1° Ricercatore - Tel:071-2078838
LA SPADA GINA -
Messina - Ricercatore
LANGONE LEONARDO -
Bologna - Dirigente di ricerca - Tel:051-6398870
LO GIUDICE ANGELINA -
Messina - 1° Ricercatore - Tel:090-6015414
LUPI ANGELO
- Bologna - Ricercatore - Tel:051-6399588
MAIMONE GIOVANNA -
Messina - Collaborare tecnico - Tel:090-6015423
MAZZOLA MAURO -
Bologna - Ricercatore - Tel:051-6399592
MISEROCCHI STEFANO -
Bologna - 1° Ricercatore - Tel:051-639880
MONTAGNA PAOLO -
Bologna - Dirigente di ricerca - Tel:051-63988913
NOGAROTTO ALESSIO -
Bologna - Collaboratore tecnico
PALADINI DE MENDOZA
FRANCESCO - Messina - Ricercatore
PANSERA MARCO -
Messina - Ricercatore
PAPALE MARIA -
Messina - Ricercatore
PATROLECCO LUISA -
Roma-Montelibretti - 1° Ricercatore - Tel:06-90672797
PESCATORE TANITA -
Bologna - Ricercatore
PLINI PAOLO -
Roma-Montelibretti - Ricercatore - Tel:06-90672392
PORCINO NUNZIATINA
- Messina - Ricercatore
RAPPAZZO ALESSANDRO CIRO
- Messina - Collaboratore tecnico
RAUSEO JASMIN -
Roma-Montelibretti - Ricercatore
SACCHETTO ALESSIO
- Padova - Collaboratore di amministrazione
SALERNO FRANCO - Milano - 1° Ricercatore (assegnazione
temporanea)
SCALABRIN
ELISA - Venezia - Ricercatore - Tel:041-2348938
SCIACCA VIRGINIA
- Messina - Ricercatore
SCLAVO MAURO -
Padova - Dirigente di ricerca – Tel:049 8295907
SMEDILE FRANCESCO -
Messina - Ricercatore
SPATARO FRANCESCA -
Roma-Montelibretti - Ricercatore - Tel:06-90672852
SPOLAOR ANDREA -
Venezia - 1° Ricercatore
TESI TOMMASO -
Bologna - 1° Ricercatore - Tel:051-6398864
TURETTA CLARA -
Venezia - 1° Ricercatore - Tel:041-2348947
VALENTINI EMILIANA -
Roma-Montelibretti - Ricercatore
VARDE' MASSIMILIANO -
Venezia - Ricercatore - Tel:041-2348938
VENIER CHIARA -
Venezia - Tecnologo
VERAZZO GIULIO -
Bologna - Tecnologo
VITALE VITO -
Bologna - Dirigente di ricerca - Tel:051-6399595
ZANELLA JACOPO -
Padova - Collaboratore tecnico - Tel:049-8295714
ZANGRANDO ROBERTA -
Venezia - 1° Ricercatore - Tel:041-2348945
ZANOTTO EMANUELA -
Venezia - Collaboratore tecnico - Tel:041-2348902
ZUCCHETTA MATTEO -
Venezia - Ricercatore - Tel:041-2348937
Sedi secondarie
ISP - Sede di Bologna
Responsabile
Dr Stefano Miserocchi
E-mail: responsabile_bo AT cnr.it
c/o Area della Ricerca di Bologna
Via P. Gobetti, 101 - 40129 Bologna (BO)
Tel: +39 051 6398 880
Fax: +39 051 6398 939
MAPPA
ISP - Sede di Roma
Responsabile
Dr.ssa Luisa Patrolecco
E-mail: responsabile_rm AT cnr.it
c/o Area della Ricerca di Roma 1
Via Salaria km 29,300 - 00015 Montelibretti (RM)
Tel: +39 06 9067 2797
Fax: +39 06 9067 2787
MAPPA
ISP - Sede di Messina
Responsabile
Dr. Maurizio Azzaro
E-mail: responsabile_me AT cnr.it
Via S. Raineri 86 - 98122 Messina (ME)
Tel: +39 090 601 5420
Fax: +39 090 669 007
MAPPA
L’Istituto è altresì articolato nelle seguenti sedi secondarie senza Centro di Responsabilità:
Sede secondaria di Padova, c/o Area di Ricerca di Padova - Mappa
Sede secondaria di Roma Tor Vergata, c/o Area di Ricerca di Roma 2 – Tor Vergata - Mappa
Direzione
 Istituto di Scienze Polari (CNR-ISP)
Istituto di Scienze Polari (CNR-ISP)
Direttrice GIULIANA PANIERI
Principali interessi sono lo studio degli ambienti marini estremi e le loro connessioni con i cambiamenti climatici nell'Artico e altrove.
Negli ultimi 12 anni è stata professoressa ordinaria di Geologia presso il Dipartimento di Geoscienze dell'Università Artica della Norvegia. Ha lavorato presso il CNR-ISMAR (Italia) e presso università internazionali negli Stati Uniti, in Spagna, Germania e Francia. Ha ricoperto il ruolo di Presidente della Divisione di Biogeoscienze e Segretario Generale dell'Unione Europea di Geoscienze (EGU), gestendo e coordinando numerosi progetti nazionali e internazionali. Ha pubblicato numerosi lavori scientifici, è stata editore di libri, e piu volte invitata come keynote in conferenze internazionali. Ha guidato numerose spedizioni in Oceano Artico. Ultimamente, si è dedicata con passione allo sviluppo di strumenti per l'Ocean Literacy e al supporto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, implementando compiti e risultati specifici nell'ambito di numerosi progetti nazionali e internazionali.
![]() https://orcid.org/0000-0001-9411-1729 Scopus - Author ID: 56135838100 Loop profile: 835890
https://orcid.org/0000-0001-9411-1729 Scopus - Author ID: 56135838100 Loop profile: 835890
E-mail: direttore.isp AT cnr.it
c/o Campus Scientifico - Università Ca' Foscari Venezia
Via Torino, 155
30172 VENEZIA MESTRE (VE)
Direttori precedenti:
• Mauro Sclavo - direttore f.f. (1° maggio 2024 - 31 gennaio 2025)
• Carlo Barbante - 1° direttore ISP (1° maggio 2020 - 30 aprile 2024)
• Leonardo Langone - direttore f.f. (1° giugno 2019 - 30 aprile 2020)
Chi siamo
L’Istituto, costituito con provvedimento n.81 del 31/05/2019 del Presidente Inguscio, afferisce al Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente (DSSTTA) a far data dal 1° giugno 2019.
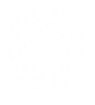 Ministero dell'Universita e Ricerca
Ministero dell'Universita e Ricerca
Programma Ricerche Artico
Programma Nazionale di Ricerca in Antartide
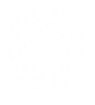 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
L'Italia e l’Artico
L’Italia e l’Antartide







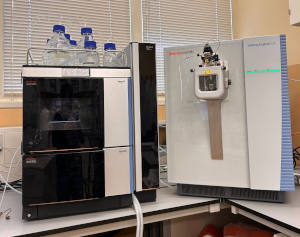
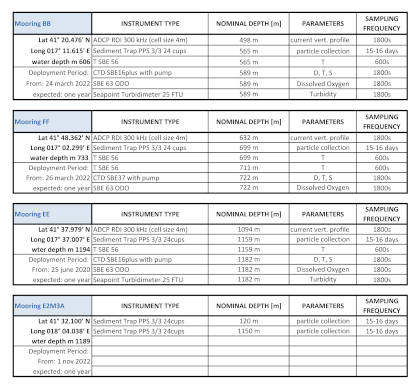


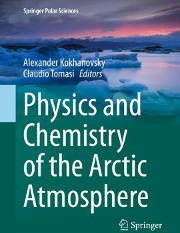




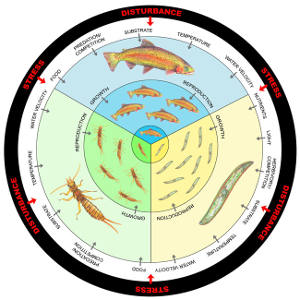
 La maggiore comprensione dei processi biologici e i recenti progressi nel campo delle biotecnologie consentono di utilizzare il mondo naturale per ottenere progressi in diversi settori industriali, quali ad esempio lo sviluppo di farmaci e additivi alimentari. In generale, il termine bioprospecting viene adoperato per indicare l'esplorazione di esseri viventi e materiale biologico ai fini della ricerca di biomolecole che possano essere utili per l’uomo. In questo ambito, risorse genetiche scarsamente conosciute e poco descritte presentano un alto potenziale per la scoperta di nuovi e preziosi prodotti naturali. Pertanto, gli organismi polari, date le loro peculiari capacità metaboliche e gli adattamenti fisiologici a condizioni ambientali estreme, ben si prestano allo scopo. Non viene, inoltre, trascurato il possibile coinvolgimento di organismi polari nella rimozione di sostanze inquinanti, anche persistenti, a bassa temperatura.
La maggiore comprensione dei processi biologici e i recenti progressi nel campo delle biotecnologie consentono di utilizzare il mondo naturale per ottenere progressi in diversi settori industriali, quali ad esempio lo sviluppo di farmaci e additivi alimentari. In generale, il termine bioprospecting viene adoperato per indicare l'esplorazione di esseri viventi e materiale biologico ai fini della ricerca di biomolecole che possano essere utili per l’uomo. In questo ambito, risorse genetiche scarsamente conosciute e poco descritte presentano un alto potenziale per la scoperta di nuovi e preziosi prodotti naturali. Pertanto, gli organismi polari, date le loro peculiari capacità metaboliche e gli adattamenti fisiologici a condizioni ambientali estreme, ben si prestano allo scopo. Non viene, inoltre, trascurato il possibile coinvolgimento di organismi polari nella rimozione di sostanze inquinanti, anche persistenti, a bassa temperatura.